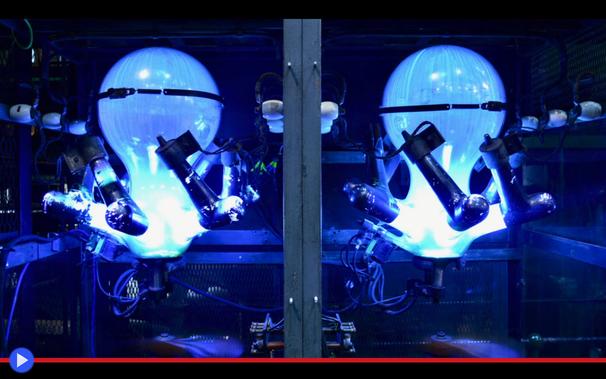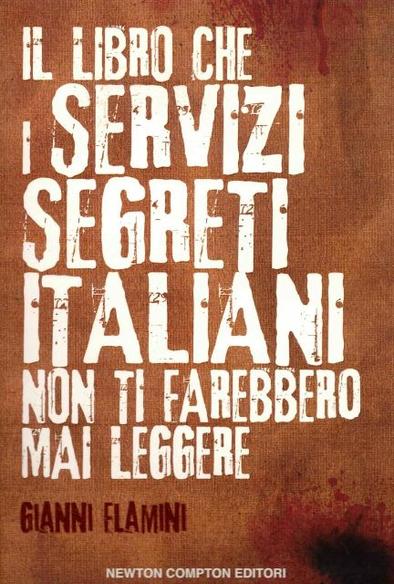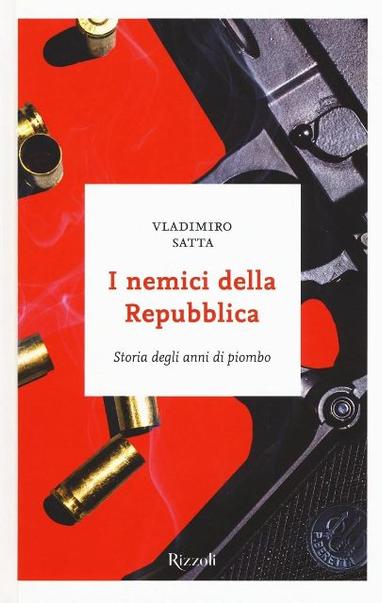Il coinvolgimento della Rosa dei Venti nella realizzazione della strage alla Questura di Milano appare dunque evidente
La strage, che costituisce uno degli episodi più oscuri della strategia della tensione, giunse al termine di una lunga serie di attentati che avevano insanguinato il paese a partire dal ‘69 di cui i più rilevanti, oltre naturalmente a piazza Fontana, furono la strage di Gioia Tauro del 22 luglio del ‘70 e quella di Peteano del 31 maggio del ‘72. L’attentato avvenne giovedì 17 maggio 1973, alle ore 10:55, presso la Questura di via Fatebenefratelli quando Gianfranco Bertoli lanciò una bomba contro il portone d’ingresso del palazzo. Il bilancio fu di quattro morti e cinquantatré feriti. Quella mattina si era da poco conclusa la commemorazione del primo anniversario dell’assassinio del commissario Luigi Calabresi. Dopo l’arresto Bertoli si professò anarchico sostenendo di aver compiuto l’attentato per vendicare Pinelli; le sue dichiarazioni, a cui si sarebbe sempre attenuto, seguivano alla lettera le istruzioni che gli erano state impartite nei mesi antecedenti da alcuni dei più importanti membri di Ordine Nuovo durante i giorni di indottrinamento trascorsi a Verona dove l’uomo, in vista dell’imminente attentato, era stato tenuto sotto stretta osservazione. Il coinvolgimento della figura di Calabresi naturalmente serviva ad occultare meglio la mano degli ideatori rendendo più credibile la paternità anarchica della strage. L’obbiettivo dell’attacco, poi mancato, era il ministro dell’interno Mariano Rumor colpevole, secondo gli ordinovisti, di non aver proclamato lo stato di emergenza dopo la bomba del 12 dicembre del ‘69. L’eliminazione del ministro, nei piani degli ideatori della strage, avrebbe dovuto servire anche ad evitare una riedizione del centro-sinistra che si stava profilando come altamente probabile sulla base degli equilibri politici interni alla DC.
[…] I principali attentati che precedettero l’attacco alla Questura di Milano furono, come sopra ricordato, essenzialmente due. In primo luogo si ricorda il fallito attentato del 7 aprile del 1973 sul direttissimo Torino-Genova-Roma ad opera del gruppo La Fenice. <32 L’esecutore materiale, Nico Azzi, giovane missino, nel tentativo di controllare l’ordigno, temendo che questo non fosse stato impostato correttamente, aveva fatto scoppiare inavvertitamente un detonatore tra le sue gambe, rendendo impraticabile l’innesco dell’ordigno. Nell’ipotesi iniziale all’attentato avrebbe dovuto seguire la solita operazione di attribuzione della paternità a sinistra. In quell’occasione si era deciso di far
ricadere la responsabilità del gesto sul gruppo genovese “XXII ottobre”, collegato significativamente all’editore Giangiacomo Feltrinelli. Secondo il progetto iniziale, a questa strage doveva far seguito una seconda sul treno Monaco-Roma che poi non venne attuata a causa del fallito attentato sul primo treno, considerato che Azzi, colto in flagrante, era chiaramente di destra, per cui la messa in scena non poteva più essere orchestrata.
Un secondo snodo significativo nella strategia perseguita prima dell’attentato a Rumor fu il cosiddetto “giovedì nero di Milano”. Il 12 aprile 1973 era stata indetta dall’MSI e dal Fronte della gioventù, l’organizzazione giovanile del partito, una manifestazione di protesta che, a causa dei fatti dei giorni precedenti, era stata limitata dal prefetto Libero Mazza al solo comizio. Nonostante ciò, centinaia di militanti del Movimento Sociale Italiano e delle principali organizzazioni dell’estrema destra scesero in piazza e si scontrarono con le forze dell’ordine. Nel corso della manifestazione rimase ucciso l’agente di polizia Antonio Marino, in seguito all’esplosione di una bomba a mano lanciata da Vittorio Loi, giovane missino che venne immediatamente identificato. Dalle testimonianze di Loi, che sentendosi abbandonato dal suo partito cominciò a parlare, si comprese che i disordini erano stati volontariamente provocati dalla dirigenza missina. <33
Al di sopra degli attentatori, come è stato ormai accertato dalla Magistratura, operava il già citato gruppo golpista la Rosa dei Venti che svolgeva una funzione di coordinamento tra i diversi gruppi eversivi. <34 Si trattava di un’organizzazione atlantica intersecata con gli apparati dello stato, il cui nome conteneva un chiaro richiamo al simbolo della NATO, oltre ad evocare il numero dei gruppi di estrema destra associati alla stessa organizzazione. <35 Facevano parte dell’organizzazione diversi militari, quali ad esempio il maggiore Amos Spiazzi e il generale Francesco Nardella, oltre ad estremisti neri: tra i nomi più rilevanti ricordiamo il principale promotore del gruppo Dario Zagolin – informatore degli americani e del SID -, Eugenio Rizzato, Sandro Sedona e Sandro Rampazzo. Tra i membri risultavano anche diversi industriali ed esponenti del Fronte nazionale che avevano preso parte al golpe Borghese, tra cui occorre ricordare l’avvocato Giancarlo De Marchi, che come noto aveva già giocato un ruolo rilevante in qualità di collettore dei finanziamenti per il progetto golpista del principe Borghese.
La figura di De Marchi ricompare proprio nel marzo 1973 quando, nell’ambito della riproposizione di un piano eversivo, venne contattato dal maggiore Amos Spiazzi, su indicazione di un agente del SID. Il compito era quello di valutare affidabilità e la serietà dell’avvocato genovese, che si era dichiarato disponibile a reperire fondi a sostegno della strategia stragista, rassicurandolo al contempo sulla concretezza e fattibilità del disegno golpista, stante l’esistenza di un rilevante numero di militari disposti a proseguire il fallito golpe Borghese.
L’esistenza di un nuovo progetto golpista è stata confermata d’altra parte anche dalle indagini del giudice Giovanni Tamburino, dalle quali si evince chiaramente che la Rosa dei Venti nel 1973 aveva come obbiettivo quello di promuovere interventi tesi all’istaurazione di un regime autoritario in Italia attraverso la realizzazione di un colpo di stato. Secondo le dichiarazioni di Remo Orlandini, uomo di fiducia del principe Borghese, ai già citati eventi dell’aprile-maggio 1973 – l’attentato al treno Torino-Roma, la manifestazione del 12 aprile e la bomba alla Questura – doveva seguire, l’instaurazione di un clima di forte tensione sociale in Valtellina alla cui direzione avrebbe dovuto esserci il leader del Movimento di azione rivoluzionaria (MAR) Carlo Fumagalli, altro nome di fondamentale importanza nel mondo dell’estrema destra in quella stagione. Altro passaggio teso a creare un clima adatto ad un colpo di stato.
Nell’aprile del 1973 l’attività della Rosa Dei Venti era strettamente connessa alle attività di Ordine Nuovo. Da fonti provenienti dai carabinieri e dal SID risulta infatti che il giorno della strage Bertoli era atteso da Sandro Rampazzo fuori dalla questura, che come abbiamo già sottolineato avrebbe dovuto farlo scappare a bordo della sua auto. <36 Il coinvolgimento della Rosa dei Venti nella realizzazione della strage alla Questura di Milano appare dunque evidente e questo conferma il fatto che la strage di Bertoli si inserisse in un disegno di ben più ampia portata di quanto per lungo tempo abbiano voluto far credere sia parte dei Servizi Segreti sia una parte della stampa. Come avvenuto con il golpe Borghese, l’opinione pubblica sarebbe però venuta a conoscenza del progetto ordito dalla Rosa dei Venti, peraltro in modo parziale, solo nell’autunno del 1974 grazie all’evoluzione dell’inchiesta condotta dal giudice Tamburino.
Al compimento dell’attentato avrebbe dovuto seguire l’intervento delle Forze Armate, in modo analogo a quanto era stato previsto dopo la strage alla Banca dell’Agricoltura di Milano. Nonostante l’atto stragista non avesse raggiunto gli obbiettivi che si era prefissato, – Rumor rimase illeso – la Rosa dei Venti avrebbe comunque allertato le strutture civili e militari per passare all’azione il 2 giugno del 1973. Anche in questa occasione l’esecuzione del golpe rientrò soltanto a causa di un intervento esterno.
Contrariamente a quel che sperava la destra, la bomba alla questura non determinò comunque uno spostamento a destra del governo, ma finì anzi per rafforzare all’interno della DC la linea favorevole ad una riedizione del centro-sinistra.
Rispetto alle altre stragi che hanno insanguinato il nostro paese, l’attentato alla questura costituisce uno snodo rilevante nella storia della strategia della tensione. Come ha sottolineato in modo chiaro Dondi, esso costituì «l’ultima strage costruita cercando di attuare il meccanismo di provocazione con lo scambio di attribuzione». <37
Contrariamente a quanto avevano sperato gli ordinovisti e diversamente da quanto era accaduto con la strage di Piazza Fontana, gran parte dell’opinione pubblica diffidò da subito della paternità anarchica dell’attentato. Probabilmente la lunga scia di sangue che aveva attraversato il Paese e l’attività sempre più incisiva della controinformazione avevano cambiato in modo profondo la sensibilità degli italiani. D’altro canto anche la stampa d’opinione, sia pure con le dovute eccezioni, non poté non ravvisare le evidenti incongruenze di una riconduzione della strage alla pista anarchica. Troppi erano gli elementi che non tornavano. Innanzitutto il profilo biografico-politico dell’attentatore, le cui frequentazioni di uomini e organizzazioni della destra eversiva erano difficilmente occultabili. «L’Unità» e «Paese Sera» già dal 18 maggio avevano rilevato i legami del Bertoli con Pace e Libertà, l’organizzazione finanziata dalla Cia.
In secondo luogo, non si capiva come Bertoli avesse potuto sapere della commemorazione di Calabresi con una settimana di anticipo, cioè al momento di lasciare Israele, quando invece la cerimonia era stata resa pubblica soltanto il 15 maggio. Era evidente che ci doveva essere un coinvolgimento di qualcuno all’interno delle istituzioni. Risultava infine decisamente poco credibile non ipotizzare una trama internazionale alla luce dei numerosi spostamenti di Bertoli. Come era stato possibile infatti che il Mossad non fosse stato in grado di identificare un pregiudicato che operava sul suo territorio, che intratteneva rapporti con uomini dell’estrema desta francese e che andava e veniva dallo stato ebraico con un passaporto falso?
Insomma, troppi elementi non quadravano nella strage di via Fatebenefratelli. Proprio per questo si può dire che l’attentato costituisce in senso tecnico la fine della strategia della tensione, almeno come era stata delineata nell’ambito del convegno dell’Istituto Pollio tenuto all’hotel Parco dei Principi di Roma del maggio 1965.
[NOTE]
32 A. Giannuli, E. Rosati, Storia di ordine nuovo. La più pericolosa organizzazione neo-fascista degli anni settanta, cit., p. 162. La Fenice fu un’organizzazione dell’estrema destra milanese fondata da Giancarlo Rognoni nel 1971. Il gruppo nel febbraio 1973, rientrò sotto l’ombrello del MSI, grazie all’accordo con Franco Servello, cosa avvenuta anche per Ordine Nuovo alla vigilia della strage di Piazza Fontana. Ai membri de La Fenice erano state infatti promesse alcune cariche all’interno del partito. Tra i principali militanti ricordiamo Nico Azzi, Francesco De Min e Mauro Marzorati. Il gruppo godeva della protezione di Pino Rauti.
33 M. Dondi, op. cit., p.308-309.
34 G. Tamburino, La Rosa dei Venti nel quadro dell’eversione stabilizzante, https://memoria.cultura.gov.it (consultato il 20 novembre 2024).
35 M. Dondi, op. cit., p. 330. Le organizzazioni legate alla Rosa dei Venti, inizialmente venti, divennero poi ventitré. Tra queste ricordiamo Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, Fronte nazionale, Mar.
36 Cfr. S. Ferrari, Le stragi di stato. Piccola enciclopedia del terrorismo nero da piazza Fontana alla stazione di Bologna, Nuova iniziativa editoriale, Roma 2006, p. 95.
37 M. Dondi, op. cit., p. 327.
Marta Cicchinelli, Stampa e strategia della tensione: la strage alla Questura di Milano sui settimanali italiani, Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Anno Accademico 2023-2024
#17 #1973 #AntonioMarino #attentati #CarloFumagalli #CIA #controinformazione #FrancescoNardella #fronte #Genova #GianfrancoBertoli #gioventù #golpe #Israele #maggio #MAR #MartaCicchinelli #Milano #militari #MSI #NATO #nazionale #neofascisti #NicoAzzi #OrdineNuovo #Questura #rosa #Sid #strage #strategia #tensione #tentativo #Valtellina #Venti #VittorioLoi