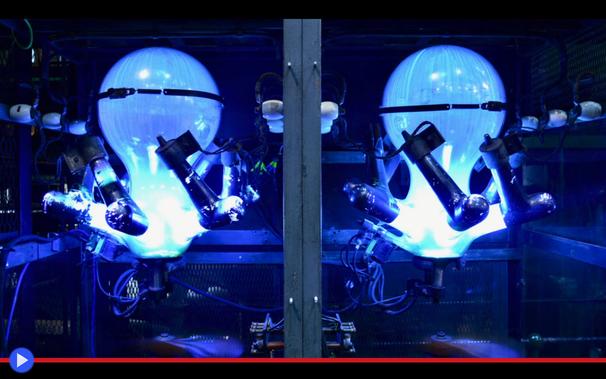Cavillare sulla strage di Piazza Fontana
Il terrorismo italiano, come sottolineato in precedenza, è peculiare rispetto ad altre forme terroristiche contemporanee. Lo scontro invase la scena politica, sociale privata e pubblica, dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Ottanta. Nei primi anni Settanta, la debolezza dell’esecutivo di fronte alle tensioni della società apparve in tutta la sua chiarezza ed evidenza non solo nelle frequenti crisi di governo, ma anche nel modo in cui fu affrontato il primo manifestarsi del terrorismo politico <98.
Il primo atto terroristico, che mise in luce l’incapacità di risolvere il caso, fu l’attentato del 12 Dicembre del 1969: gli apparati dello Stato fornirono prova della loro incertezza e inconcludenza che furono messe sotto accusa dall’opinione pubblica e dalla stampa di sinistra, la quale individuò nell’estrema destra fascista la matrice politica dell’attentato e denunciò le pesanti responsabilità dei servizi di sicurezza nel deviare le indagini verso un’improbabile pista anarchica. La pista “imboccata” dagli inquirenti all’indomani degli attentati fu quella appunto quela anarchica: le prime indicazioni vennero dagli apparati statali, i governanti le recepirono, gran parte della stampa e della televisione le rilanciarono, amplificandole, verso l’opinione pubblica che in maggioranza ci credette, almeno agli inizi <99.
Con il tempo la pista anarchica si rivelò fallace e si affermò la pista neofascista. La svolta in tal senso è collocabile nel 1972, tre anni dopo la strage. Tra le tante ipotesi giudiziarie, giornalistiche e storiografiche ventilate intorno all’impostazione delle indagini su Piazza Fontana, la sussistenza di un presunto patto segreto e inconfessabile tra due “cordate” capeggiate rispettivamente dal Presidente della Repubblica Saragat e dal Ministro degli Esteri Moro “è quella che più concerne le altre sfere politico-istituzionali e che al contempo, sarebbe anche il fondamentale motivo dell’impunità dei responsabili della strage”. <100
In un volume uscito nell’Ottobre del ’78, intitolato “Il segreto della Repubblica”, fu esposta per la prima volta l’idea che la verità su Piazza Fontana, prima manifestazione di terrorismo, sia stata celata mediante un “informale ma ferreo patto del silenzio tra le massime istituzioni, concordato il 23 Dicembre del 1969”. <101 L’opera in questione fu riscoperta negli anni Novanta dal giudice istruttore Guido Salvini e da allora ha riscosso maggiore interesse e veri e propri consensi. Il “Segreto della Repubblica” consisterebbe in un compromesso tra due ampie aree politiche, una autoritaria e quasi filo-golpista e una più cauta e non disponibile a ridurre gli spazi di democrazia <102.
La prima aerea faceva capo a Saragat mentre la seconda a Moro e l’accordo tra i due avrebbe previsto elezioni anticipate che avrebbero dovuto propiziare la fine del centro sinistra e i ritorno al centrismo e, in cambio Moro avrebbe rinunciato a dirottare le indagini relative alla Strage di Piazza Fontana dalla pista anarchica alla pista fascista. In questa maniera, la verità sulla strage fu sacrificata <103.
Il volume “Il segreto della Repubblica” fu pubblicato dopo il 1978 e riguardo al cruciale colloqui tra Saragat e Moro nel Dicembre del 1969 non vi era nessun documento. “Nessuno è tanto pazzo da rimproverare il presidente Saragat degli attentati, ma l’intera sinistra italiana sostiene che la sua strategia della tensione ha indirettamente incoraggiato l’estrema destra ad andare verso il terrorismo. È stato nel Luglio del 1969 che Saragat ha provocato la scissione dei socialisti italiani: la famosa coalizione di centro-sinistra crollò, lasciando la Dc di Rumor sola, in un governo di minoranza nel bel mezzo dell’uragano dell’autunno caldo. Le motivazioni di Saragat nel causare la scissione erano sottili: per risolvere la crisi si sarebbero indette nel nuovo anno le elezioni durante le quali la paura del comunismo avrebbe spazzato via la forte sinistra della Dc distruggendo le ipotesi di una coalizione con il Pci. La previsione non funzionò poiché il Pci emerse come il partito dell’ordine, lungi dall’incoraggiare il caos”. <104
Le forze politiche, all’indomani dell’attentato si espressero a caldo sull’accaduto e le opinioni furono discordanti, come era prevedibile. Nelle prime ventiquattro ore, a livello nazionale, quasi tutti si astennero da prese di posizione sull’identità degli stragisti a Milano. La sera del 12 dicembre del 1969, il consiglio provinciale approvò a maggioranza un documento che perentoriamente definiva “nazifascista” la matrice degli attentati <105. La direzione nazionale della Dc dichiarò che gli attentati esplosivi furono “il risultato di una predicazione della violenza come metodo e come fine nei rapporti sociali”. <106 Alla sorpresa per l’inaudita gravità dell’episodio si accompagnava un’ammissione di
disorientamento: “Nessuno riesce a trovare una qualche spiegazione che abbia un minimo sentore di logica, anche di logica aberrante e distorta”. <107 A Montecitorio, i liberali non formularono sospetti in alcuna direzione e puntualizzarono che “troppo a lungo si era tollerata in Italia non tanto una predica teorica della violenza, quanto l’educazione concreta alla violenza”. <108 Altrettanto agnostici furono i repubblicani, secondo i quali le bombe costituirono “l’allargamento di una situazione” <109 sempre più problematica. “Per i socialdemocratici, gli atti proditori scaturivano dall’intendimento di turbare un’evoluzione civile e sociale meritoria: la lotta di classe era un atto di civiltà e andava mantenuta nell’ambito del sistema democratico”. <110 Le immediate reazioni dimostrarono che esse non furono affatto un segnale convenuto tra politici e assassini per poi procedere alla repressione della protesta sociale. Da destra, missini e monarchici sostennero che il governo non tutelava il paese dalla dilagante sovversione di sinistra e che “a debolezza segue violenza e strage”. <111
Dopo ripetute indagini e ripetute ipotesi, il giudicato definitivo addossò la strage di Piazza Fontana agli ordinovisti padovani, tuttavia, la strage, non è mai stata rivendicata da Ordine Nuovo.
L’intuizione giusta della sinistra che la strage fosse stata eseguita dalla destra era guastata dalla visione semplicistica che si aveva di quest’ultima. La sinistra era convinta che tutti i fascisti fossero “servi dei padroni” e agissero come loro braccio armato. Essa ignorava l’esistenza di un fascismo anticapitalistico, antiborghese, antioccidentale e indisponibile al compromesso con le potenze che avevano debellato l’Italia. Tradizionalmente, il problema di come fosse considerata dall’opinione pubblica la condotta degli apparati statali, è stato trattato dagli storici con riferimento alla sinistra e, in particolare, a quella parte di essa che giustificò le proprie violenze presentandole alla stregua di risposte a uno Stato stragista <112. Mentre l’opinione pubblica, nei primi tempi, poteva solo supporre che fossero scattate protezioni nei confronti degli anarchici, i veri stragisti sapevano che la strage non era attribuibile a essi. Tra le varie ipotesi, i sostenitori della teoria di una “strage di Stato” non furono innocui e contribuirono a creare una risposta terroristica e violenta in quanto: “Coperture e apparati deviati sono cose gravissime, ma per parlare di terrorismo di Stato bisognerebbe dimostrare o almeno ipotizzare che un ceto dirigente di governo o una sua parte significativa abbiano pianificato stragi e assassinii. Terrorismo di stato è il nazismo, naturalmente. Sono Stalin, il regime militare argentino, i colonnelli greci. Ma deve avere una regia politica, istituzionale. E invece in Italia la formula è ripetuta con disinvoltura. Non ha senso rifletterci ora”. <113
Se lo Stato è un assassino e addirittura pianifica stragi, ne segue che la risposta violenta è legittima. L’erronea percezione dei sostenitori della teoria della strage di Stato va attribuita essenzialmente a loro stessi. L’idea che lo Stato fosse complice dello stragismo influì finanche su quei terroristi neofascisti i quali si batterono contro di essa, come dimostrano il caso di Vinciguerra e della coppia formata da Fioravanti e Mambro (appartenenti ai Nar). Quest’ultima ammetterà: “Eravamo cresciuti con l’idea, anzi con la paranoia, che a destra ci fossero infiltrazioni e addirittura agenti provocatori, proprio perché eravamo stanchi di sentir dire che i fascisti erano in combutta con i poliziotti, che erano il braccio armato del potere, abbiamo fatto tutto l’opposto, abbiamo risposto a modo nostro a quelle teorie che erano solo teorie tra l’altro, ci siamo cascati in pieno”. <114
Pertanto la percezione di uno Stato che non facesse giustizia, produsse all’estrema destra effetti non meno perniciosi di quelli prodotti a sinistra, con l’unica differenza che per quanto concerne la destra, il discorso era strettamente legato al comportamento degli apparati statali dopo la strage di Piazza Fontana e non alla progettazione ed esecuzione di essa. Su questo terreno “del dopo strage”, lo Stato ha di che rimproverare se stesso, quindi entro questi limiti, è parzialmente responsabile dell’immagine che diede <115.
Tra i disordini e le violenze, attentati dinamitardi, larghi margini d’impunità per gli autori dei reati, ripetute crisi di governo e peggioramento della situazione economica, all’inizio degli anni Settanta l’Italia diede “l’impressione di una società che fosse sul punto di crollare”. <116
[NOTE]
98 G. Sabatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 341.
99 V. Satta, I nemici della Repubblica: storia degli anni di piombo, Rizzoli, Milano, 2016, p. 179.
100 Ivi, p.
180.
101 Ibidem.
102 Ivi, p. 160.
103 W. Rubini, Il segreto della Repubblica, Selone, Milano, 2005, p. 119.
104 V. Satta, I nemici della Repubblica: storia degli anni di piombo, Rizzoli, Milano, 2016, p. 204.
105 Rea, Le bombe di Milano, Rizzoli, Milano p. 69.
106 V. Satta, I nemici della Repubblica: storia degli anni di piombo, Rizzoli, Milano, 2016, p. 204.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Ibidem.
110 Ivi, p. 205.
111 Ibidem.
112 Ivi, p. 268.
113 Intervista rilasciata a Gian Guido Vecchi e pubblicata con il titolo Strage di Stato? Corriere della Sera, 2008.
114 Intervista rilasciata a Zavoli per il programma La notte della Repubblica.
115 V. Satta, I nemici della Repubblica: storia degli anni di piombo, Rizzoli, Milano, 2016, p.265.
116 S. Tarrow, Democrazia e disordine, Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 269.
Benedetta Lorenzale, L’impatto delle forze antisistema sul sistema politico italiano negli anni di piombo, Tesi di Laurea, Università Luiss “Guido Carli”, Anno Accademico 2017-2018
#12 #1969 #1972 #1978 #anticomunismo #apparati #BenedettaLorenzale #destra #dicembre #fontana #indagini #ipotesi #milano #Moro #opinione #piazza #pubblica #Saragat #segreti #Stato #terrorismo