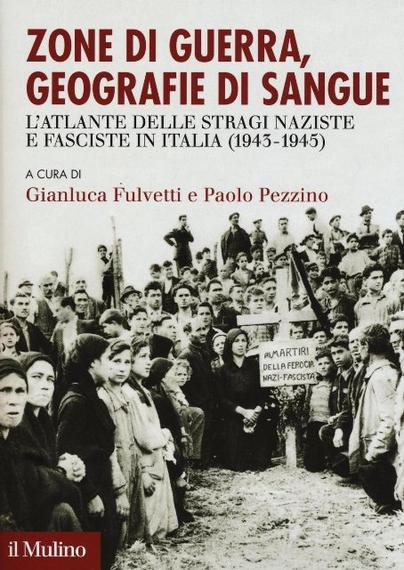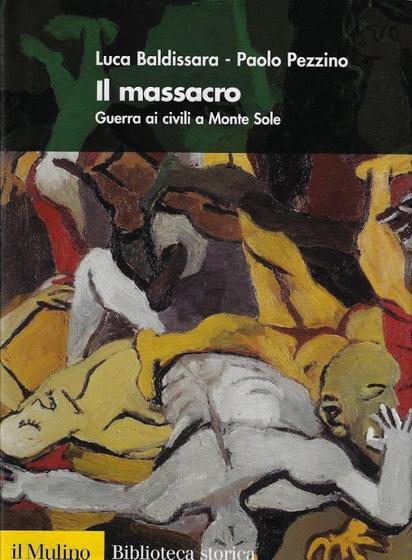In Italia, fino all’ultimo, il numero delle diserzioni di soldati tedeschi rimase contenuto
I documenti ancora disponibili negli archivi hanno permesso un’analisi sistematica [n.d.r.: relativa ai disertori dell’esercito tedesco in Italia] solamente per la 10ª armata tedesca. Anche in questo caso però le informazioni non coprono tutto l’arco di tempo in cui l’armata fu presente in Italia, ed è presumibile che i dati riportati rappresentino per difetto, più che per eccesso la reale consistenza numerica (a causa ad esempio di fattori come la mancanza, il ritardo o ancora la perdita delle segnalazioni).
Si può comunque ritenere che il fenomeno abbia avuto una dimensione limitata, se rapportato al milione di soldati circa dell’esercito tedesco che furono presenti tra il 1943 e il 1945 in Italia <619. Qui i soldati della Wehrmacht si trovavano in un paese straniero, circostanza questa che di per sé poteva rappresentare un deterrente per i disertori, per un’insieme di motivi che andavano dalle difficoltà linguistiche alle conoscenze geografiche insufficienti, alla presenza di formazioni partigiane e alleate.
Appare cosi corretto affermare che gli episodi di diserzione dei soldati non furono in grado di costituire un rilevante pericolo per la tenuta delle forze militari della Germania in Italia; ciò sembra confermare il giudizio espresso da Carlo Gentile, secondo il quale: “Fino al crollo del Terzo Reich le truppe tedesche presenti in Italia non andarono soggette a tendenze disgregative degne di nota, per cui nel marzo del 1945 le autorità della Wehrmacht poterono rinunciare per buone ragioni a instaurare un sistema di repressione interna simile a quello messo in atto nel territorio del Reich per punire i disertori e i disfattisti […] In Italia, fino all’ultimo, il numero delle diserzioni rimase contenuto” <620.
Diversi furono comunque i provvedimenti assunti per contrastare gli episodi di diserzione; esemplificative sono in tal senso le azioni dei reparti di polizia militare e degli altri reparti di disciplina dell’esercito tedesco.
Già nell’autunno del 1943 in un interrogatorio alleato si fece menzione della presenza nella zona di Napoli di un Jägerbattaillon il cui compito principale era il mantenimento dell’ordine tra i soldati tedeschi. Alcuni militari trovati in abiti civili, erano stati uccisi dal battaglione, mentre si riferiva che altri soldati scaricavano nell’aria le loro munizioni, così da poter finger di aver esaurito i proiettili e di aver combattuto fino all’ultimo nel caso di un loro arresto <621.
Come ricorda lo stesso Gentile inoltre nei primi mesi estivi del 1944 venne inviato in Italia un reggimento di Feldjäger, adibito alla repressione della diserzione <622.
Nella primavera del 1945 si procedette a organizzare delle linee di controllo, che dovevano servire per evitare che i soldati si intrattenessero nelle retrovie o commettessero atti di indisciplina <623. Ancora ad inizio aprile il comandante supremo del gruppo d’armate C (Oberbefehlshaber Südwest), in una sua comunicazione dai toni chiaramente propagandistici e destinata a essere diffusa tra i soldati, affermava come coloro i quali erano passati nelle fila dell’esercito angloamericano venivano considerati come “ehrlose Verräter”, traditori senza onore. La circolare riportava infatti quanto avevano riferito alcuni soldati al loro ritorno in Germania, ovvero che non appena avevano terminato di fornire informazioni di carattere militare erano stati trattati non più come normali prigionieri di guerra, ma senza alcun rispetto ed onore, con livelli minimi di assistenza e non adeguati alle norme internazionali sul trattamento dei prigionieri di guerra, proprio perché disertori <624.
Osservando le cifre di quanti tra i fuggitivi vennero ricatturati appare però come tali tentativi furono piuttosto limitati nella loro efficacia. In tal senso va fatta una considerazione anche sull’operato dei tribunali militari tedeschi e sull’efficacia del loro modus operandi. I procedimenti penali che vennero condotti nei confronti dei disertori intendevano non solo punire i colpevoli, ma tramite l’esemplarità rappresentata dalle condanne a morte anche dissuadere il resto dei soldati da questo tipo di comportamenti.
Erano però molti anche coloro i quali, colpevoli di reati minori, proprio per evitare le conseguenze di un eventuale condanna sceglievano di fuggire e abbandonare le formazioni, rendendosi però così a loro volta colpevoli di diserzione, così come emerge anche da alcuni casi presentati nel IV capitolo <625. Dai procedimenti penali dei tribunali emergono gli sforzi che questi attuarono per individuare e giudicare i comportamenti ritenuti contrari alla disciplina militare da parte dei soldati. Nei casi di diserzione alcuni elementi (la falsificazione dei documenti, l’abbandono della divisa e l’utilizzo di abiti civili, il contatto con le formazioni partigiane, l’aiuto ottenuto da persone esterne) venivano valutati dai giudici come dettagli che testimoniavano la volontà degli accusati di allontanarsi in maniera definitiva dalla propria unità. L’assenza, in alcuni casi, di queste aggravanti era invece sottolineata nelle arringhe dei difensori per mettere in risalto al contrario le buone intenzione degli imputati.
Ancora sulla base dei dati presentati nel III capitolo emerge come la maggior parte di coloro i quali si resero colpevoli di diserzione o di essersi allontanati dalle proprie formazioni non fossero nati in Germania ma provenissero invece da “paesi dell’Est”, reclutati spesso forzatamente, da persone appartenenti alla “Deutsche Volksliste III” o ancora da austriaci, jugoslavi, francesi. Ne è una conferma anche il fatto che, nei dati presentati nelle tabelle del terzo capitolo, il maggior numero di diserzioni è attribuibile alla 5ª Gebirgs-Division e alla 44ª Infanterie-Division, composte proprio da soldati di origine austriaca e slovacca, nei confronti dei quali particolarmente attiva era la propaganda partigiana.
Un’ulteriore conferma arriva anche dalla preponderante presenza di questi soldati all’interno delle bande partigiane italiane, rispetto ai loro camerati germanici; si deve però ricordare come questi gruppi etnici rappresentassero una minoranza nel numero complessivo dei soldati della Wehrmacht, che si dimostrarono invece pronti a combattere fino agli ultimi giorni di guerra. A simili risultati, per quanto riguarda i disertori dell’esercito tedesco passati a combattere con le formazioni partigiane nella provincia di Parma è giunto anche Marco Minardi, come abbiamo visto nel paragrafo conclusivo del III capitolo.
Come emerge dagli interrogatori condotti dagli alleati, i timori che i soldati tedeschi nutrivano per la propria sorte e per quella della Germania, che in caso di sconfitta si riteneva potesse andare incontro a distruzione materiale e culturale, rappresentarono un fattore di forza (insieme all’indottrinamento ideologico, alla propaganda e alla repressione interna) <626 dell’esercito nazista, anche quando la disfatta appariva ormai inevitabile.
Le fonti alleate riportavano anche come le classi di soldati più giovani e quelle più anziane apparivano quelle dal morale più basso durante la guerra <627. Sarebbero però necessarie ulteriori ricerche per ricostruire con più precisione i profili biografici di un più ampio numero di disertori, per valutare l’esistenza o meno di una relazione tra la frequenza degli episodi di diserzione e l’impiego che venne fatto in guerra delle divisioni dalle quali essi provenivano. Ciò ci permetterebbe di mettere in relazione le scelte di quanti disertarono con, ad esempio, alcuni dei risultati raggiunti da Carlo Gentile, il quale individuava in alcuni fattori, come la giovane età dei soldati, un elemento chiave negli episodi di violenza di cui si resero responsabili alcune formazioni, rivalutando al contrario l’incidenza dell’“Osterfahrung”. È possibile rintracciare un’incidenza di questi due aspetti anche per quanto riguarda i casi di diserzione? Appaiono comunque corrette le considerazioni espresse da Ziemann, già richiamate nell’introduzione e che emergono dall’analisi di diversi studi, secondo le quali le motivazioni politiche in senso stretto rappresentavano solo in un ridotto numero di casi l’elemento decisivo che spingeva alla diserzione i soldati <628. Ciò appare naturale per quanto emerge dai documenti dei tribunali militari, nei quali gli imputati intendevano dissimulare le loro reali intenzioni, adducendo scuse e presentando delle giustificazioni ai loro comportamenti, per poter in qualche modo rendere meno pesante la loro condanna. Altri elementi apparivano così più decisivi nella scelta della diserzione, come le
preoccupazioni per la propria famiglia, la volontà di avere del tempo libero, le relazioni sentimentali. In alcuni casi emerge anche dai casi presentati in questa tesi come diffusi fossero i casi di quanti intendevano sottrarsi alla giustizia militare, prendendo la decisione di fuggire. I dati riportati nelle tabelle a conclusione del III capitolo non permettono di distinguere tra quanti, dopo aver disertato, si consegnarono agli alleati e quanti invece ai partigiani. È però necessario ricordare come entrare in contatto con gli alleati rappresentasse senza dubbio una circostanza più favorevole rispetto al consegnarsi alle formazioni partigiane e che offriva maggiori garanzie, quali la possibilità di essere trattati come prigionieri, di non dover continuare a combattere e di tornare alle proprie famiglie.
Allo stesso modo Ziemann affermava che non erano conosciute le cifre e i motivi di quanti decisero di consegnarsi agli alleati in Italia <629. Circa le loro scelte emerge però dagli interrogatori alleati e da quelli fatti dai partigiani come, tra le motivazioni che venivano espresse, più frequenti fossero quelle di natura politica, legate all’opposizione al regime nazista. Anche in questo caso è però necessario interrogarsi sulla genuinità di tali confessioni, che non poterono non essere condizionate dalla situazione in cui vennero rilasciate.
Ad influenzare il fenomeno della diserzione furono anche alcune valutazioni di carattere “militare” come il fattore della ritirata continua, spesso in condizione di caos, che favorì così la fuga dei soldati, la perdita di fiducia nella vittoria, la supremazia aerea degli alleati. A rendere possibile, o perlomeno più semplice da realizzare e con maggiori possibilità di successo, l’abbandono della propria formazione, potevano però anche essere le favorevoli condizioni meteorologiche o il trovarsi in un ambiente adatto a nascondersi o a ricevere aiuto da attori esterni (popolazione, formazioni alleate, strutture religiose); al contrario, questi elementi potevano anche trasformarsi in fattori di dissuasione. Ciò trova conferma anche nei dati che vedono per l’Italia nell’estate-autunno del 1944 e negli ultimi mesi di guerra nella primavera del 1945 i periodi in cui si verificarono la maggiore parte dei casi di diserzione. Per l’estate del ’44 questi dati si possono spiegare sia in riferimento alla ritirata disordinata delle armate tedesche che ebbe luogo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, conseguente allo sfondamento della linea Gustav e alla presa di Roma da parte degli alleati, sia con la crescita di attività delle formazioni partigiane, che causò il dilagare tra i soldati tedeschi di una sorta di “psicosi delle bande” <630.
Per quanto riguarda la primavera del 1945 un fattore decisivo fu invece rappresentato dalla consapevolezza sempre crescente che la guerra stava per terminare. Di conseguenza la presenza di disertori fu più alta nelle formazioni partigiane che operavano nelle regioni dove il fronte di guerra si fermò più a lungo e dove la presenza di militari della Wehrmacht fu maggiore (Emilia Romagna, Toscana, ma anche Piemonte e Veneto).
Un’analisi del fenomeno della diserzione nei vari fronti sui quali l’esercito tedesco fu impegnato deve necessariamente tenere conto di questi diversi fattori (temporali, ambientali, politici). Nei primi anni di guerra i successi tedeschi, la fiducia nella vittoria, ma anche la minaccia rappresentata dal movimento partigiano rappresentarono un motivo di coesione per le forze armate tedesche, sul fronte orientale così come in Africa. Soprattutto a partire dalla metà del 1944 però, con il crollo del gruppo d’armate Mitte, l’avanzata sovietica verso la Germania e lo sbarco alleato in Francia, divenne chiaro che la guerra sarebbe terminata con una sconfitta, che l’esercito alleato e quello sovietico erano militarmente superiori e che la fuga rappresentava una buona possibilità, per i soldati, di poter sfuggire ai combattimenti e tornare a casa, nonostante questo significasse sfidare la giustizia militare o un periodo di prigionia <631.
[NOTE]
619 Carlo Gentile, I tedeschi e la guerra ai civili in Italia, in Gianluca Fulvetti, Paolo Pezzino (a cura di), Zone di guerra, cit., p. 131.
620 Carlo Gentile, I crimini di guerra, cit., pp. 391-392.
621 Headquarters Fifth Army, Psychological Warfare Branch I.N.C., Subject: Weekly Reports on P/W’s, 14/10/1943, US NARA, Record Group 407, Entry 427, Box 2216.
622 Carlo Gentile, I crimini di guerra, cit., p. 138.
623 BA-MA, RH 19-X/47. Si veda anche Andreas Kunz, Wehrmacht und Niederlage, p. 285.
624 Der Oberbefehlshaber Südwest (Oberkommando Heeresgruppe C), Betr: Behandlung deutscher Überläufer in anglo-amerikanischer Kriegsgefangenschaft, 03/04/1945, BA-MA, RH 19X/47.
625 Rimane comunque ancora da valutare, come anche Ziemann osservava, quale fosse l’effettiva capacità deterrente, all’interno delle truppe, rappresentata dalle condanne a morte e da altri tipi di punizioni, Benjamin Ziemann, Fluchten aus dem Konsens zum Durchalten, cit., pp. 599-600.
626 Thomas Kühne, Gruppenkohäsion und Kameradschaftsmythos, cit.
627 Headquarters Fifth Army, Psychological Warfare Branch, Subject: Morale interrogations of German prisoners. Weekly report, 23/10/1943, US NARA, Record Group 407, Entry 427, Box 2216.
628 In tal senso anche Andreas Kunz, Wehrmacht und Niederlage, cit., p. 268.
629 Benjamin Ziemann, Fluchten aus dem Konsens zum Durchalten, cit., p. 597.
630 Carlo Gentile, I crimini di guerra, cit., pp. 136-146.
631 Cfr. Manfred Messerschmidt, Die Wehrmachtjustiz, cit., p. 161 e ssg. Qui è offerta anche un’analisi comparativa del numero dei reati documentati per quanto riguarda l’esercito tedesco, quello giapponese, americano, inglese, francese e sovietico. Per la partecipazione di soldati tedeschi ai movimenti di resistenza europei anche Gerhard Paul, Die verschwanden einfach nachts, cit.
Francesco Corniani, “Sarete accolti con il massimo rispetto”: disertori dell’esercito tedesco in Italia (1943-1945), Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Trieste, Anno Accademico 2016-2017
#1943 #1944 #1945 #44ªInfanterieDivision #5ªGebirgsDivision #alleati #austriaci #disertori #fascisti #Feldjäger #FrancescoCorniani #francesi #interrogatori #Italia #jugoslavi #partigiani #repressione #Resistenza #tedeschi #tribunali #Wehrmacht