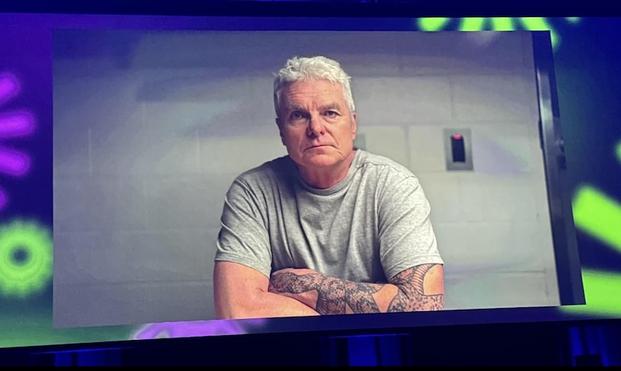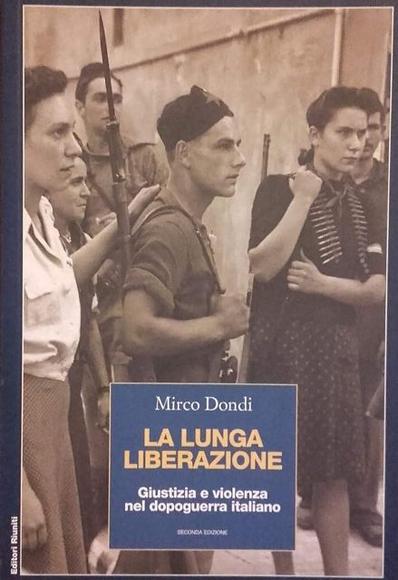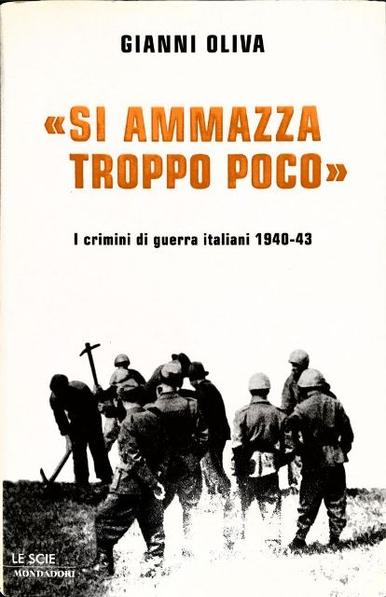Le brigate Garibaldi della Lombardia furono tra le più efficienti nella cattura dei presunti collaborazionisti
Il decreto legislativo n.° 142 emanato il 22 aprile 1945 toccò un nervo scoperto di chi aveva conosciuto le asprezze del governo di Salò e il fardello dell’occupazione tedesca.
Molti cittadini si dimostrarono pronti a collaborare con le istituzioni preposte per attuare i provvedimenti sanzionatori sporgendo denunce contro i collaborazionisti. A Liberazione avvenuta, svanito il timore delle repressioni e delle persecuzioni da parte di nazisti e saloini, nulla più ostacolò l’iniziativa della popolazione di “farla pagare” ai precedenti oppressori e profittatori.
La mole e lo stato attuale dell’archiviazione delle fonti a disposizione rende difficoltosa, al momento, la ricostruzione dell’effettiva consistenza di tutte le denunce sporte a carico dei collaborazionisti nella provincia di Milano <124.
Dalle informazioni reperibili a partire dagli atti processuali si desume che la maggior parte delle persone accusate di collaborazionismo per cui fu istruito il processo furono segnalate tra la fine di aprile e la fine di giugno 1945. Nella seconda metà dell’anno le denunce continuarono con una minore intensità fino a cessare nella primavera successiva <125.
Gli autori delle denunce furono in molti casi i parenti o i conoscenti delle vittime o coloro che avevano direttamente subito i torti o le violenze. E’ il caso, ad esempio, dell’avvocato Alfonso Mauri, il quale due giorni dopo la liberazione di Milano denunciò il portinaio dello stabile dove esercitava la professione, Stefano Barlocco, per aver provocato il suo arresto da parte della polizia tedesca <126. E’ invece la vedova Anna Abanassino a denunciare, il 20 maggio 1945, Norberto Ficini quale delatore del marito Ferruccio Bolognesi, morto in Germania dopo esservi stato deportato <127. Analogamente, il commerciante di origine argentina Santiago De Filippi, processato “per aver denunciato alle SS Germaniche il sig. Goldfluos Enrico, segnalandolo come israelita e detentore di armi destinate ai partigiani nonché di apparecchio radio ricevente trasmittente, provocandone l’internamento a Dachau”, è stato segnalato dal figlio dell’internato <128.
Anche i gruppi partigiani attivi sul territorio investirono le proprie energie nella ricerca e denuncia dei fascisti di Salò che, in molti casi, vennero dalle stesse bande fermati e arrestati.
Alcuni esempi: l’ufficiale della Gnr Alberto Guzzi fu prelevato il 26 aprile da un corpo di Volontari della Libertà, Maria Ferlat, interprete, venne arrestata il 30 aprile dai volontari della sezione romana-vigentina del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Alcuni agenti di pubblica sicurezza del comando generale della VIII brigata Matteotti fermarono il 3 maggio Tommaso Cacciapuoti, arricchitosi grazie a traffici illegali con i tedeschi, mentre il Commissario nazionale per l’Opera Nazionale Combattenti Luigi Russo fu arrestato qualche giorno dopo (12 maggio) da una formazione di “Giustizia e Libertà” e Ugo Franzolin, cronista di guerra della X Mas, da un gruppo garibaldino della Lombardia <129. Le brigate Garibaldi della Lombardia furono tra le più efficienti nella cattura dei presunti collaborazionisti. Oltre ad esse e a quelle citate nei precedenti esempi si misero in azione la brigata “giovanile Matteotti”, la brigata “San Giusto”, la brigata “Migliarini” e gruppi del Corpo Volontari della Libertà come la brigata “Biancardi” e il gruppo “Montezemolo”.
Altre volte le segnalazione di sospetti collaborazionisti arrivarono da colleghi di lavoro <130 o coinquilini <131, mentre in rari casi – concentrati nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile – si registrano costituzioni spontanee <132.
A tener desti gli animi della popolazione sulla punizione dei delitti commessi in nome del fascismo contribuirono, nei primi mesi dopo la liberazione, gli organi di stampa. I giornali del tempo ospitarono, infatti, articoli che, con toni più o meno infervorati e con considerazioni più o meno polemiche, mantennero la vicenda sanzionatoria al centro dell’interesse pubblico.
A partire dalla fine di maggio, sulla pagina milanese del Corriere d’Informazione apparvero costantemente aggiornamenti sugli ex-fascisti arrestati <133 e resoconti dei processi che si svolgevano davanti alla Corte d’Assise Straordinaria di Milano <134.
Parallelamente, i cittadini furono febbrilmente invitati collaborare con i Cln e le pubbliche autorità per avviare più celermente possibile i processi sanzionatori. Già nei primissimi giorni successivi alla liberazione apparvero incoraggiamenti a sporgere “denuncie dettagliate, indicando le persone, i fatti, i danni subiti e le prove documentali od orali” facendo pervenire “uno scritto senza alcuna formalità alla Commissione intestata sedente presso il Palazzo di Giustizia, via Freguglia” <135.
Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, i numerosi articoli sull’argomento divennero veri e propri appelli indirizzati alla popolazione a darsi da fare per “stanare” gli ex fascisti che si nascondono <136 o che tentano di riciclarsi come partigiani <137 e coloro che hanno approfittato dell’occupazione tedesca per godere di posizioni di potere o per portare a termine affari e profitti personali <138. La risposta dei cittadini ai frequenti appelli sembrò essere positiva, tanto da incalzare il lavoro della polizia e dell’apparato giudiziario <139.
In genere i querelanti indirizzarono i propri esposti alla Questura, ai Carabinieri o direttamente alla Corte d’Assise Straordinaria mediante l’ufficio del PM o l’autorità inquirente. Moltissimi furono anche coloro che si rivolgono ai Cln che, in questa fase di “caccia al nemico” dimostrarono grande energia ed operosità.
Tra la primavera e l’estate del 1945 i Comitati di Liberazione regionali e provinciali ricevettero una pioggia di denunce, segnalazioni, aggiornamenti e indicazioni <140.
Al Cln della città di Milano privati cittadini denunciarono, ad esempio, alcuni impresari nel campo edile per essersi messi a servizio dell’occupante.
Gino Ferrari, appaltatore edile operante a Molinazzo di Cormano, venne denunciato perché “Sostenitore e difensore e propagandista del verbo fascista – prima e dopo l’8 settembre 1943 – particolarmente ai propri dipendenti, collaborazionista dei fascisti e dei tedeschi per i quali ha fatto lavori diversi per conto della Todt, di Milano e provincia”. Inoltre, “ha minacciato ripetutamente i dipendenti di invio in Germania se questi manifestavano la loro avversione ad essere impiegati sui lavori per i tedeschi e per le loro organizzazioni. Sollecitava i nipoti all’iscrizione nell’esercito repubblichino e brigava presso Farinacci per far ottenere una ricompensa al valore militare ad un nipote ferito nella lotta contro i Patriotti sul fronte italiano”. Infine: “E’ già stato segnalato da diversi dipendenti come elemento fazioso, e ricercato dopo il 26 luglio 1943 per una giusta punizione, ma si era reso irreperibile. Ha fatto discreta fortuna durante il periodo di guerra immagazzinando rilevante quantità di materiale venuto da vie traverse della Todt”. Insieme a lui, anche la moglie, Maddalena Lireque Ferrari, di nazionalità francese, fu segnalata in quanto “coadiuva, segue ed incita il marito, tipico esempio di degenerazione dei caratteri francesi, fascista, opportunista, denigratrice del proprio paese” <141.
Di un altro appaltatore edile operante nel milanese, Aldo Cardani, si comunicò: “Sostenitore fascista e propagandista di prima e dopo il 26 luglio. Tacciava pubblicamente di antitaliani dei semplici antifascisti, provocando noie e richiami polizieschi per questioni seguite da minacce da parte delle autorità politiche fasciste” <142.
Un’ulteriore denuncia riguardò l’Ingegner Guido Piazzoli, titolare della ditta “Fr. Ing. Piazzoli” di Milano. In essa si dichiarò che l’ingegnere, al momento irreperibile, usava mettere a disposizione dei tedeschi le proprie risorse e la propria professionalità eseguendo lavori di fortificazioni, bunker, fori da mine nel tratto stradale Ventimiglia-San Remo, e che in più si vantava della ingente fortuna che queste attività gli avevano procurato <143.
Anche i soldati tedeschi rimasti in territorio italiano dopo il 25 aprile furono oggetto delle denunce dei cittadini.
Nel luglio 1945 l’artista lirico Luigi Stellasi informò il Clnai che Alf Rauch, cittadino tedesco e nazista, circolava in Milano con falsi documenti e suggerì di rivolgersi all’impresario del teatro Carcano per testimonianze circa i suoi trascorsi <144. Negli stessi giorni, venne denunciato anche il Dr. Wilhelm Vogel, proprietario o comproprietario della ditta “Primo aghificio italiano S.A. Lecco-Laorca”.“Il dott. Wielhelm Vogel – si legge nella denuncia – è spia di pace e di guerra, lui e sua moglie Gina Fabbri di Ravenna, ove ha parenti fascisti e già gerarchi e ove avranno forse nascosto denaro e gioielli e altro. Questa canaglia del dott. Vogel, come tutti gli altri tedeschi che sono in Italia e “nessuno li tocca” <145, quanto siamo imbecilli noi Italiani, e sono migliaia che infestano Milano e tutta l’Italia e tutti da fucilare perché tutti quanti complici (spie ladri assassini) coi comandi tedeschi e in futuro proibire per legge la residenza in Italia a tutti i tedeschi, questo spione del dott. Voghel ha diversi indirizzi …” <146.
La spirale delle denunce cominciata alla fine dell’aprile 1945 divenne per qualcuno una ghiotta occasione da sfruttare per disfarsi di elementi sgraditi. Risale al 4 settembre 1945 una lettera firmata dal Cln di Pantigliate in cui si chiede al Clnai di intercedere presso il Comando dell’Arma dei Carabinieri per ottenere la sostituzione del Brigadiere Fogliani, Comandante la Stazione locale dei Carabinieri. Il motivo della richiesta fu la sua “scandalosa condotta”. Egli “gozzoviglia, e da tempo, con tutti i signoretti esponenti dell’ex PFR diminuendo il principio d’autorità e giustizia che dovrebbe essere integro in un Comandante dei CC.RR. […] Inoltre è un uomo che non ha nessuna parola, che girella a seconda dell’opportunità e non gode ne stima né fiducia tanto dalle Autorità quanto dal popolo” <147.
[NOTE]
124 Le denunce a carico dei collaborazionisti non sono raccolte in modo sistematico e unitario ma sparpagliate tra le denunce giunte ai vari commissariati di Polizia e alla Questura di Milano per tutti i tipi di reato. Cfr. ASM, QUESTURA DI MILANO, Casellario permanente di polizia giudiziaria (bb 523), Commissariati di pubblica sicurezza di zona (bb 558), Commissariati di pubblica sicurezza distaccati (bb 33). A queste bisogna poi aggiungere le segnalazioni fatte al Clnai e alle sue varie sezioni provinciali della Lombardia, di cui è reperibile solo una miscellanea nei fondi Cln Alta Italia e Cln città di Milano dell’INSMLI.
125 L’ultimo esposto registrato è quella a carico di Franco Gandini, denunciato il 4 aprile 1946 dal dott. Weinelberger Emanuele, di nazionalità ebraica e suo creditore, per averlo precedentemente segnalato all’ufficio politico del gruppo Oberdan di Milano. ASM, Cas Milano, 10.05.1947, Sez. Terza, Pres. Emanuele Giovanni, vol. 10/1947.
126 ASM, Cas Milano, 06.07.1945, Sez. Prima, Pres. Marantonio Luigi, vol. 1/1945.
127 ASM, Cas Milano, 19.09.1945, Sez. Terza, Pres. Marano Matteo, vol.2/1945.
128 ASM, Cas Milano, 08.08.1945, Sez. Prima, Pres. Mottino Gianbattista, vol.1/1945.
129 Nell’ordine: ASM, Cas Milano, 08.06.1945, Sez. Prima, Pres. Marantonio Luigi; 23.05.1945, Sez. Prima, Pres. Marantonio Luigi; 06.07.1945, Sez. Prima, Pres. Marantonio Luigi; 01.06.1945, Sez. Prima, Pres. Marantonio Luigi ; 13.06.1945, Sez. Seconda, Pres. Modugno Domenico, vol.1/1945.
130 Edgardo Matisek, ad esempio, Commissario per la gestione straordinaria della società per azioni “Philips Radio e Metalix” è denunciato per illeciti affari con gli occupanti dai colleghi di lavoro. ASM, Cas Milano, 09.07.1045, Sez. Prima, Pres. Mottino Gianbattista, vol. 1/1945.
131 De Rossi Maria, casalinga, è accusata di delazione dal coinquilino Enzo Imbriani. ASM, Cas Milano, 03.07.1945, Sez. Seconda, Pres. Gurgo Luigi, vol. 1/1945
132 Mario Nasini, ufficiale dell’esercito poi passato alla milizia volontaria della sicurezza nazionale e al servizio della Rsi, si consegna spontaneamente alla polizia alla fine di aprile mentre Giuseppe Dalla Croce si costituisce al Cln di Cusano Milanino per essere stato capitano della Gnr e aver svolto la funzione di Pubblico Ministero presso il Tribunale Speciale per la difesa dello stato, nella sezione VII con sede in Milano. Nell’ordine: ASM, Cas Milano, 11.06.1945, Sez. Seconda, Pres. Modugno Domenico; 13.07.1945, Sez. Prima, Pres. Mottino Gianbattista, vol. 1/1945.
133 “Quasi quattro mila “politici” nel carcere di San Vittore” e “Spie e aguzzini fascisti tratti in arresto” in Corriere d’informazione, 28 maggio 1945; “Tristi figuri fascisti tratti in arresto”, in Corriere d’informazione, 09 giugno 1945.
134 “Il processo a Rolandi Ricci. Un clamoroso incidente”, in Il Corriere d’informazione, 24 maggio 1945; “Trent’anni ad Attilio Teruzzi e quindici e Rolandi Ricci”, Ibidem, 25 maggio 1945; “L’istruttoria contro Graziani”, Ibidem, 27 maggio 1945; “Buffarini Guidi e Uccelli condannati alla pena capitale”, Ibidem, 29 maggio 1945; “Escandescenze dell’ex gerarca durante l’interrogatorio”, Ibidem, 8 giugno 1945; “Cesare Rossi condannato a quattro anni di reclusione”, Ibidem, 9 giugno 1945.
135 “Le Commissioni di giustizia al lavoro”, in L’Unità, 28 aprile 1945.
136 “Centinaia restano da prendere ancora annidiati nelle case o ricomparsi in strada sotto i travestimenti più impensati. Tenete gli occhi aperti. Segnalateli subito ai Comandi”, in “Un collaborazionista”, Ibidem, 11 maggio 1945.
137 “Bisogna stare in guardia, bisogna impedire che questa gente giunga a infiltrarsi nei partiti antifascisti”, in “Mimetizzazioni”, Ibidem, 12 maggio 1945.
138 “Punire i collaborazionisti”, Ibidem, 30 aprile 1945.
139 “alla pressione delle masse, che diventa sempre più intensa, corrisponde un risveglio, sia pure ancora insufficiente, dell’apparato giudiziario e dell’attività degli organi di polizia”, in “La questione partigiana davanti al Consiglio dei Ministri”, Ibidem, 13 maggio 1945.
140 Il fervore e lo slancio dei cittadini a partecipare alla punizione dei fascisti è testimoniato dalla mole della documentazione reperita. Numerosi sono gli incartamenti conservati all’Archivio dell’Istituto INSMLI di Sesto San Giovanni in cui sono conservate centinaia di denunce e segnalazioni. Cfr. Archivio INSMLI, Fondo Cln Alta Italia, b. 49, fasc. 606, 607, 608, b. 51, fasc. 679, b. 52, fasc. 688, b. 58 fasc. 765, b. 59, fasc. 787 e 789; Fondo Cln città di Milano, b. 3, fasc. 19. Lo stesso dato è messo in luce per l’Emilia Romagna da Mirco Dondi in M. Dondi, La lunga liberazione, p. 41.
141 Archivio INSMLI, Fondo Cln Alta Italia, busta 59, fasc. 787.
142 Ivi
143 Ivi
144 INSMLI, Fondo Clnai, b. 49, fasc. 606.
145 Corsivo suo.
146 INSMLI, Fondo Clnai, b. 49, fasc. 606.
147 INSMLI, Fondo Clnai, b. 59, fasc. 793.
Lucia Reggiori, Collaboratori e collaborazionisti a Salò: i processi per collaborazionismo nelle sentenze della Corte d’assise straordinaria di Milano (1945-1947), Tesi di dottorato, Università degli Studi di Pisa, 2014
#1945 #Cas #collaborazionisti #crimini #delitti #denunce #deportati #epurazione #fascisti #Lombardia #LuciaReggiori #milano #partigiani #processi #repubblica #Resistenza #RSI #Salò #tedeschi #tribunale