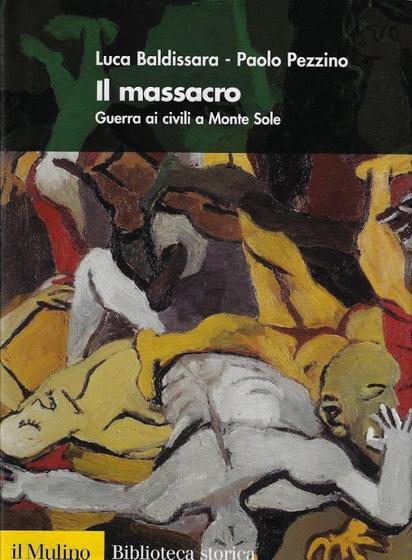Sul processo a Kesselring
L’esame del processo contro Kesselring è interessante per la ricostruzione del meccanismo del terrore messo in atto dalle truppe tedesche in Italia dopo l’8 settembre 1943, di cui ha parlato Battini. Durante le prime tre settimane del processo, ci si occupò dell’esame delle prove addotte per le due imputazioni, dell’interrogatorio dell’imputato e dell’escussione dei testimoni. Fra questi ultimi, ventuno furono convocati dalla difesa e nove dall’accusa. Un ruolo determinante ebbero tre testimoni dell’accusa: il tenente colonnello A.P. Scotland, un ufficiale dello spionaggio dell’esercito britannico che si era infiltrato nelle truppe tedesche, Herbert Kappler e il giudice militare dell’esercito tedesco, Hans Keller. Scotland aveva interrogato Kesselring e raccolto le sue deposizioni durante la sua prigionia a Londra. Questi atti costituirono le prove decisive per l’incriminazione dell’imputato, il quale – ricordiamo – il 6 maggio fu ritenuto colpevole di entrambi i capi d’imputazione e condannato a morte per fucilazione. Vediamo dall’analisi della sentenza come Battini sia arrivato a concludere che «la responsabilità diretta del comandante supremo era stata provata in modo incontrovertibile e la condanna fu inevitabile» <422.
Al processo, Scotland mise in luce che gli ordini emanati dal comando dell’esercito tedesco in Italia, in particolare quelli del 17 giugno e del 1° luglio, avevano contribuito a scatenare una controguerriglia condotta «con la massima violenza anche contro donne e bambini» <423, dando così avvio «a tutti gli eccessi contro i civili a cui si sarebbero abbandonati i comandanti subalterni» <424. Scotland sottolineò inoltre che, per un ordine del Comando supremo della Wehrmacht del 1° maggio 1944 inviato dal maresciallo Keitel, fossero stati affidati a Kesselring l’autorità suprema sulle operazioni antipartigiane, il comando sulle forze delle SS e della polizia dipendenti dal generale Wolff e la supervisione del coordinamento territoriale delle linee di comunicazione con le retrovie, conferito allo stesso Wolff. Le operazioni antipartigiane, affidate al comando delle SS, sarebbero state coordinate da Wolff in collaborazione con il quartier generale di Kesselring, a cui spettava l’approvazione di qualsiasi piano di attacco. Lo schema tratteggiato da Scotland trovò conferma nella testimonianza del colonnello Beelitz, che era stato primo ufficiale dello staff generale di Kesselring. Anch’egli ammise che dal 1° maggio al generale Wolff fu ordinato di seguire gli ordini di Kesslering, a capo dell’Oberkommando Sud West (Comando supremo del fronte sud-ovest), per quanto riguardava la guerra partigiana. Beelitz documentò l’esistenza di collegamenti fra il comando dell’esercito e quello delle SS, che avevano permesso a Kesselring di essere costantemente informato sulle operazioni antipartigiane condotte da Wolff. L’importanza di tali testimonianze è stata sottolineata da Battini:
“Si aprì così l’interrogativo su quanto Kesselring avesse effettivamente conosciuto delle efferate attività di alcune unità delle Waffen SS poste direttamente agli ordini di Berlino – ad esempio la XVI Panzerdivision SS, la divisione SS Hermann Göering e la divisione cosacca di Debes – le quali si erano rese responsabili di alcuni dei massacri più feroci, da S. Anna di Stazzema a Marzabotto. Venne così provata l’ipotesi che le SS furono effettivamente subordinate alla Wehrmacht nelle operazioni contro i partigiani e contro le popolazioni civili”. <425
Lo stesso Kappler danneggiò il feldmaresciallo, dichiarando di aver detto esplicitamente a Kesselring di avere in custodia persone imputate di reati punibili con la pena di morte e non ancora condannate a morte. Fu quest’ultimo a ritenere necessario eseguire immediatamente l’ordine di rappresaglia imposto da Hitler. La testimonianza di Kappler contrastava con quella del giudice militare Hans Keller, il quale però non riuscì a trovare prove a suo favore. Questi, sebbene sostenesse di aver emanato l’obbligo per tutti i battaglioni di dotarsi di corti marziali sul campo, dovette ammettere che tali corti non avevano gli strumenti per poter operare effettivamente. Egli non riuscì nemmeno a provare l’esistenza di direttive per lo svolgimento di regolari processi ai partigiani catturati e ai civili sospettati di collaborare con loro. Il comando non aveva proposto, evidentemente, alcuna misura garantistica: nessuna esecuzione di civili era stata preceduta da un processo. Il testimone finì così per compromettere la posizione dell’imputato e ammise che l’ordine di Kesselring del 17 giugno 1944 che garantiva protezione a qualsiasi ufficiale che si fosse reso responsabile di eccessi nelle stragi «sarebbe risultato ambiguo e avrebbe potuto essere frainteso» <426, soprattutto nelle mani di un giovane ufficiale.
Kesselring si difese sostenendo che gli ordini da lui emanati si spiegavano con la difficile situazione in cui l’esercito tedesco, dopo la caduta di Roma del 4 giorno 1944, si era trovato ad agire, costretto alla ritirata, tormentata dai bombardamenti aerei alleati e dagli attacchi dei partigiani. Le sue dichiarazioni dimostrarono però che in quelle difficoltà egli maturò un atteggiamento di rancore verso l’esercito e il popolo italiano, che sarebbe stato poi alla base della sua politica di occupazione. Baldissara e Pezzino hanno messo ben in luce come questo rancore si sia riversato sulla popolazione civile, provocando stragi di inermi:
“Questa insistenza sulla minaccia partigiana […] era la spia di una preoccupazione reale per l’attività della guerriglia sul terreno propriamente militare, inscritta però in un latente e ampiamente condiviso giudizio di disprezzo e totale repulsa per qualsivoglia forma di guerra irregolare. Un disprezzo che non poteva non rovesciarsi sui componenti delle formazioni partigiane e sulle popolazioni che si ritenevano collaterali a esse, e che non poteva non costituire il presupposto della sottrazione di innocenza ai civili – donne e bambini inermi – e dunque della giustificazione stessa del massacro, sia durante (per coloro che lo compivano) sia dopo (per coloro che lo giudicavano)”. <427
Sebbene Kesselring inizialmente provasse ad addossare la colpa delle stragi senza limiti alle autorità fasciste della RSI, dovette poi ammettere che qualche atrocità era stata commessa anche da parte tedesca. Kesselring si contraddisse durante il processo, poiché da una parte affermava che i propri ordini avessero rispettato il diritto di guerra, dall’altra attribuì la causa delle stragi al caos in cui era precipitato l’esercito, che avrebbe rallentato il sistema di comunicazione. I documenti, invece, dimostravano che gli ordini emanati da Kesselring non avevano rispettato affatto procedure regolari secondo il diritto di guerra. Ne è una prova anche il fatto che Kesselring solamente alla fine dell’estate del 1944 aveva istituito tribunali militari sul campo mentre, l’8 febbraio 1945, aveva stabilito che le decisioni sarebbero state prese solo dalle corti marziali. In realtà Kesselring, sin dalla fine del 1943, aveva ordinato di utilizzare non solo le misure tradizionali della controguerriglia ma tutti i mezzi a disposizione, perfino l’uccisione indiscriminata di civili sospettati di collaborazione, garantendo una protezione speciale a chi non fosse passato attraverso un procedimento giudiziario sul campo. Il colonnello Halse gli contestò allora il testo dell’ordine del 1° luglio 1944: «Una quota della popolazione maschile dell’area (infestata dai partigiani) verrà arrestata e, nel caso del prodursi di atti di violenza questi stessi uomini saranno uccisi» <428. A quel punto, Kesselring, incalzato dalle domande del colonnello, arrivò a sostenere che «anche i civili innocenti sterminati come ostaggi erano stati uccisi perché comunque colpevoli di “non aver per tempo preso le distanze dai partigiani”» <429.
Un’altra ammissione, sulla falsariga della precedente, che il feldmaresciallo fece durante l’interrogatorio, sarebbe stata determinante per l’esito del processo. Kesselring infatti affermò: «nelle aree infestate o occupate dai partigiani la popolazione combatteva al loro fianco o collaborava con essi, volontariamente o no. L’esercito fu allora costretto a considerare la popolazione alla stregua dei partigiani» <430. Come ha sottolineato Battini, l’imputato offriva così una prova della criminosità dei suoi ordini, «introducendo un’artificiosa distinzione tra la popolazione delle “aree infestate” dai partigiani, che poteva essere rastrellata, deportata e anche “giustiziata” nel caso di attacchi ripetuti, e le rappresaglie contro i partigiani combattenti, i quali potevano essere eliminati in qualsiasi circostanza senza il rispetto delle regole del diritto di guerra» <431. A quel punto, il presidente del tribunale ribatté che in entrambi i casi si era trattato di massacri indiscriminati, contrari alle norme belliche e che quindi tale distinzione non aveva alcun valore. Sebbene le convenzioni belliche non riconoscessero ai civili il diritto di insorgere contro l’occupante, quest’ultimo era chiamato al rispetto delle loro vite. Senza una regolare inchiesta che provasse la colpevolezza dei civili, essi rimanevano innocenti e la rappresaglia risultava completamente illegittima. Per questo, era stato illegale uccidere sia civili innocenti che ostaggi: in entrambi i casi si era trattato di assassinio e non di legittima rappresaglia.
In questo senso fu particolarmente significativo un altro passaggio del processo, la seduta del 14 marzo, nella quale Kesselring spiegò cosa intendesse per «zone partigiane»: parti di territorio in cui «tutta intera la popolazione condivideva lo stesso obiettivo [dei partigiani] e perciò io potevo supporre quasi con certezza che chiunque fosse stato estratto da questo gruppo di persone […] appartenesse ai partigiani e che alcuni di essi fossero dei capibanda»432. Ciò implicava che gli abitanti di zone nelle quali si fossero verificati episodi di guerriglia fossero considerati di per sé dei partigiani e che quindi fosse riservato loro lo stesso trattamento repressivo. Nel caso di episodi di insorgenza, veniva dunque sancita una condizione di colpevolezza collettiva: i civili non potevano non sapere e avrebbe dovuto collaborare con l’occupante, dunque, in caso contrario, la punizione collettiva nei loro confronti senza indagine né processo era giustificata. Come hanno sottolineato Baldissara e Pezzino, «la fonte di legittimazione della violenza e del ricorso alla rappresaglia contro i civili stava dunque nel presentare come illegittima e immorale la guerra partigiana, addirittura nell’assumerla – forzando l’interpretazione delle convezioni internazionali – alla stregua di un crimine di guerra ai danni dell’esercito regolare» <433.
Per concludere, è interessante prendere in esame un ultimo documento, il “Report on German reprisals for partisan activity in Italy”, il rapporto generale steso dagli inglesi sui risultati delle indagini da loro compiute sulle stragi di civili commesse in Italia, che l’11 di agosto del 1945 veniva inviato dal Quartier generale alleato al sottosegretario di Stato britannico del War Office. Questo rappresentava la sintesi delle investigazioni britanniche e mostra come gli inglesi fossero arrivati a comprendere la sistematicità del meccanismo terrorista praticato dai tedeschi contro le popolazioni civili. Il report collegava infatti le rappresaglie tedesche all’attività partigiana e sottolineava il complesso sistema di ordini che aveva scatenato le violenze contro la popolazione civile. Secondo i britannici, che erano entrati in possesso della documentazione del quartier generale di Kesselring, a causa delle preoccupazioni tedesche per l’intensificarsi dell’attività partigiana nell’estate 1944, «un vero e proprio sistema di ordini aveva fondato e incoraggiato la fase più intensa di azioni contro i civili» <434. Un messaggio telegrafato del 1° maggio 1944 inviato dal feldmaresciallo Keitel, capo dell’OKW, Oberkommando der Wehrmacht (Comando supremo delle forze armate) a Kesselring risolveva così il problema della ripartizione di competenze fra SS e forze armate: al generale comandante in capo del settore sud-ovest era attribuito il comando supremo delle operazioni contro i partigiani in Italia. Al comandante supremo delle SS e della polizia, Karl Wolff, spettava dunque la responsabilità operativa delle operazioni lontane dal fronte, ma egli doveva seguire i principi guida stabiliti da Kesselring, che assunse perciò il comando della lotta alle bande partigiane in Italia, e operare sotto di lui. Gli ordini di Kesselring erano quindi trasmessi ai vari livelli gerarchici per dare indicazioni sulle misure da adottare. Anche nel report si faceva riferimento agli ordini del 17 giugno 1944 e del 1° luglio dello stesso anno, che – come abbiamo visto sopra – sono stati citati durante il processo a dimostrazione del fatto che Kesselring aveva incoraggiato una vera e propria controguerriglia contro i civili. Il rapporto britannico concludeva che le «rappresaglie non erano state compiute per ordine di comandanti di singole formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata diretta dal Quartier Generale del feldmaresciallo Kesselring» <435.
Questo rapporto inglese ci offre anche indicazioni sul giudizio dei britannici nei confronti della guerra partigiana, poiché affermava che «nessuna obiezione potesse essere avanzata per l’uccisione di partigiani durante le operazioni e nella maggior parte dei casi per la loro esecuzione dopo la cattura» <436. A ragione di ciò, veniva utilizzata un’argomentazione che già abbiamo trovato: «è senza dubbio vero che molti erano camuffati con uniformi tedesche o non avevano segni distintivi o uniformi dalle quali potessero essere riconosciuti» <437. Si riteneva inoltre che potesse essere giustificata nel diritto internazionale e consuetudinario la presa di ostaggi come misura per prevenire attacchi ostili, ma che tale non potesse essere la cattura casuale di uomini innocenti e la loro uccisione al di fuori di ogni regola come rappresaglia. L’uccisione di anziani, donne e bambini era comunque «assolutamente indifendibile» <438.
La rilevanza di questo documento è dunque duplice poiché, da una parte, mostra come i britannici fossero perfettamente a conoscenza della gerarchia dei comandi tedeschi e del sistema degli ordini che faceva capo a Kesselring e che aveva originato una controguerriglia contro le bande partigiane e le popolazioni civili e, dall’altra, è prova dello scetticismo dei britannici verso la guerra partigiana, «della quale peraltro gli Alleati avevano ampiamente usufruito, e che avevano anzi incoraggiato sia con inviti al combattimento, sia con i lanci di materiale e di armi, ma che essi stessi giudicavano alla fine del conflitto, contraria alle norme del diritto internazionale di guerra» <439. Lo scetticismo verso la forma della guerra partigiana, diffuso – come abbiamo visto – anche nella cultura di guerra britannica, assunse però nel caso delle truppe tedesche aspetti molto più radicali.
Nella cultura della guerra nazista, alla rappresentazione fortemente negativa della guerriglia si aggiunsero anche altri fattori ideologici, come il risentimento verso gli italiani «traditori» e la dimensione razziale del nazismo, che spiegano perché le forze tedesche, soprattutto le formazioni più ideologizzate, arrivarono a compiere tali violenze. La disumanizzazione del nemico portò ad abbassare «la soglia dell’inibizione a colpire gli inermi» <440. Il coinvolgimento nel conflitto dei civili si inscriveva in un contesto di guerra totale, condotta con un grande dispiego di mezzi e uomini e con armamenti di grande capacità distruttiva. Era comunque la guerra partigiana il fattore principale che provocava il ricorso terroristico alla violenza contro i civili. Da una parte, per la difficile situazione in cui si trovava l’esercito tedesco in continua ritirata, il quale non riusciva a sopportare la costante condizione di insicurezza alle proprie spalle. In questo senso, il meccanismo del terrore suppliva a queste difficoltà e alla mancanza di uomini per il controllo del territorio e diventava parte delle tattiche dell’esercito. Dall’altra, «nella difficoltà di individuare e contrastare adeguatamente i combattenti irregolari, di differenziare […] l’abitante dal “bandito” […], i civili si trasformano essi stessi in partigiani: non nel senso che siano – neppure nella percezione tedesca – nella loro totalità effettivamente dei combattenti, […] ma che nelle rappresentazione delle forze d’occupazione i profili del civile e del partigiano tendono viepiù a sovrapporsi e coincidere» <441.
Possiamo concludere che alcune riflessioni giuridiche maturate all’interno del dibattito dei giuristi sul processo di Norimberga, come la questione della responsabilità individuale e dell’obbedienza agli ordini dei superiori, trovarono una sorta di applicazione nelle forme della giustizia assunte nei tribunali militari italiani. Giuristi come Nuvolone e Vassalli avevano ben colto infatti la rilevanza di tali questioni. Il primo si era addentrato in un’analisi dei vari livelli di responsabilità che la riflessione sull’obbedienza agli ordini superiori comportava. È interessante notare che nella casistica analizzata da Nuvolone troviamo dei riferimenti precisi al cosiddetto mandante specifico, il quale è ravvisabile negli uomini a capo di un’amministrazione militare. Questa categoria di persone, la quale rispecchiava proprio il ruolo dei militari tedeschi giudicati in Italia, era – a parere del giurista – pienamente responsabile dei crimini compiuti, sebbene questi le fossero stati ordinati da un superiore. Potremmo dire che lo stesso principio giuridico era stato applicato dal Tribunale militare di Bologna, affermando che, se anche Reder avesse ricevuto ordini superiori, avrebbe dovuto rifiutarsi di compiere atti che costituivano manifestatamente reato. Ciò non era avvenuto invece per il processo a Kappler, nel quale l’obbedienza a un ordine era stata considerata un’esimente. Il passo avanti fatto dal tribunale bolognese, messo in luce anche dal già menzionato Ago, aveva dunque accolto le riflessioni di quei giuristi come Nuvolone e Vassalli che ritenevano che un ordine illegittimo non potesse valere come giustificazione di una condotta criminale.
[NOTE]
422 Battini, Peccati di memoria cit., p. 88.
423 Atti del processo, cit. in Ivi, p. 77.
424 Ibidem.
425 Battini, Peccati di memoria cit., p. 80.
426 Atti del processo, cit. in Ivi, p. 78.
427 Baldissara e Pezzino, Il massacro cit., p. 418.
428 Cit. in Battini, Peccati di memoria cit., p. 83.
429 Battini, Peccati di memoria cit., p. 84.
430 Atti del processo in Battini, Peccati di memoria cit., p. 81.
431 Battini, Peccati di memoria cit., p. 81.
432 Atti del processo in Baldissara e Pezzino, Il massacro cit., p. 419.
433 Baldissara e Pezzino, Il massacro cit., p.420.
434 De Paolis e Pezzino, La difficile giustizia cit., p. 19.
435 Cit. in De Paolis e Pezzino, La difficile giustizia cit., p. 20.
436 De Paolis e Pezzino, La difficile giustizia cit., p. 20-21.
437 Ivi, p. 21.
438 Ibidem.
439 Ibidem.
440 Ivi, p. 421.
441 De Paolis e Pezzino, La difficile giustizia cit., p. 419.
Claudia Nieddu, Il dibattito in Italia sui criminali di guerra (1945-1951), Tesi di Laurea, Università degli Studi di Pisa, Anno accademico 2017-2018
#1943 #1944 #1945 #ClaudiaNieddu #controguerriglia #crimini #fascisti #guerra #Kesselring #nazisti #ordini #partigiani #processo #rappresaglie #SS #stragi #tedeschi #Wehrmacht