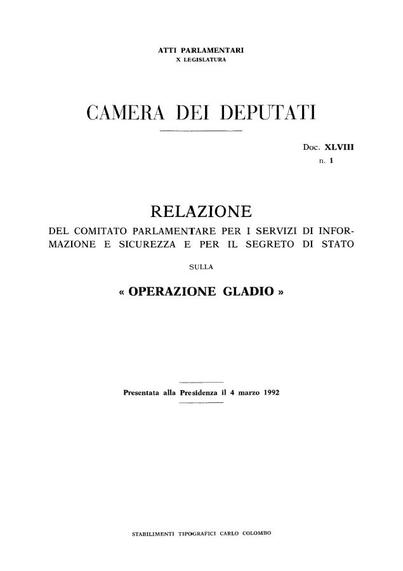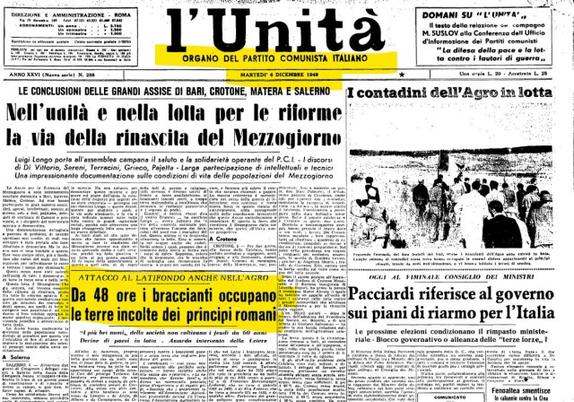La Osoppo e il MACI sono da ritenersi le principali strutture segrete anticomuniste a carattere armato sorte in Italia prima del 1956
Se il compito essenziale di Gladio era quello di attuare: “attività di informazione, infiltrazione/esfiltrazione, propaganda, guerriglia, sabotaggio in parti del territorio occupate dal nemico” <16, siamo oggi in possesso di numerosi documenti che testimoniano come fin dal 1945 nel territorio italiano nacquero una molteplicità di organizzazioni che si erano fatte carico degli stessi identici compiti che in quel 1956 vennero assegnati a Gladio. Il 26 novembre 1956 (giorno del varo ufficiale della Stay Behind italiana) in sostanza, non segnò la data di nascita di un servizio parallelo a quello ufficiale quale mai l’Italia aveva conosciuto, ma di una sorta di riorganizzazione di tutte quelle strutture nate per essere in grado di reagire ad una aggressione straniera ed operanti fin dall’immediato dopoguerra.
In base ai documenti oggi disponibili è inoltre possibile dimostrare che le radici profonde di tali strutture risalgono ad un momento storico ancora precedente e precisamente al periodo che fece seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943. Fu infatti durante le settimane successive a tale data che i neonati servizi segreti del governo di Brindisi ritennero che, nell’ottica della guerra all’invasore nazista, costituisse un supporto di grande importanza riuscire a creare una rete clandestina in grado di operare al di là del fronte nemico e capace di porsi in sinergia con le nascenti formazioni partigiane. Alcuni degli uomini che in quegli anni operarono all’interno dei servizi segreti del governo Badoglio, adoperandosi nel sostenere la guerra dietro le linee dell’esercito di invasione nazista, li ritroveremo poi nel dopoguerra tra gli artefici della creazione di strutture paramilitari occulte in funzione anticomunista ed infine anche dentro la stessa Gladio.
Nell’indagare sulle origini di Gladio si dovrà perciò partire dai convulsi e concitati giorni post-armistizio, quando la nuova intelligence al servizio del Governo del Sud, valutò positivamente l’idea secondo la quale, accanto alle Forze Armate regolari, dovessero operare bande di “irregolari”, capaci di agire contro il nemico mettendo in atto forme di guerriglia e sabotaggio. L’attenzione dovrà poi essere rivolta al cruciale momento del passaggio dalle prime strutture segrete sorte in funzione antinazista a quelle che, nell’immediato dopoguerra, cominciarono ad operare in funzione anticomunista e per far questo sarà necessario soffermarsi in modo particolare su quanto accadde in una precisa regione geografica, il Friuli Venezia Giulia. E’ qui infatti che si possono trovare i presupposti, tanto politico-ideologici quanto operativi, delle formazioni Stay Behind anticomuniste, le cui radici affondano nel drammatico ed insanabile contrasto che, a partire dall’autunno del 1944, si venne a creare dentro alla Resistenza friulana fra i partigiani comunisti filo-titini delle Brigate Garibaldi e i “partigiani bianchi” che militavano nella Brigata cattolica Osoppo.
Queste primordiali strutture, nate in modo pressoché spontaneo fin dai primi giorni dell’estate del 1945 per volontà di quegli osovani che erano decisi a difendere il Friuli dal pericolo di aggressione titina, ricevettero ben presto un decisivo supporto “istituzionale” da parte dei massimi vertici politici e militari della nuova Italia democratica, i quali garantirono agli osovani finanziamenti, armi, nonché la possibilità di essere addestrati alla tecniche di guerriglia e sabotaggio sotto l’egida di ufficiali dell’Esercito americano. Ad inizio 1947 così, una volta aumentata la consistenza numerica ed affinato l’addestramento, da queste embrionali organizzazioni segrete potè nascere la più importante struttura di tipo Stay Behind sorta in Italia prima del 1956, ovvero la “Osoppo-Organizzazione O”, la cui vicenda dovrà essere seguita con particolare attenzione, poiché essa a tutti gli effetti può essere considerata la vera e propria progenitrice di Gladio, all’interno della quale andò a costituire la branca principale.
Se il Friuli fu indiscutibilmente il “laboratorio” in cui vennero sperimentate e portate a compimento le principali entità prodromiche a Gladio, nel corso degli anni quaranta anche in altre zone dell’Italia settentrionale numerosi partigiani cattolici e liberali, una volta conclusa la lotta contro il nazifascismo, rimasero in armi ed entrarono a far parte di strutture segrete create in funzione anticomunista. Di assoluta rilevanza da questo punto di vista fu il ruolo giocato nell’area lombarda da una organizzazione denominata: “Movimento Avanguardista Cattolico Italiano” (MACI), originariamente fondata nel 1919 per iniziativa dell’allora arcivescovo di Milano, Monsignor Andrea Ferrari. Sotto il fascismo però, il MACI era stato costretto a sciogliersi e soltanto nel novembre 1945, per espressa volontà del cardinale Ildefonso Schuster e della curia milanese, esso rivide la luce. Ufficialmente si trattava di una organizzazione impegnata nella difesa del cattolicesimo e dei valori cristiani e che alle elezioni politiche dell’aprile 1948, di concerto con i “celebri” Comitati Civici di Luigi Gedda, si distinse per il grande zelo propagandistico profuso in favore dei candidati democristiani in Lombardia e Piemonte. Accanto a questo suo ruolo pubblico tuttavia, il MACI fin dai primi anni post-bellici aveva sviluppato una vera e propria attività sotterranea attraverso la creazione di una struttura segreta, che fu posta sotto il “comando” di un ex partigiano bianco di nome Pietro Cattaneo ed i cui compiti essenziali erano quelli di sorvegliare il “nemico comunista”, cercare di scoprirne eventuali piani insurrezionali per essere pronti a reagire qualora fossero stati messi in atto. A Milano vi era il “comando centrale” di tale struttura, alla quale facevano capo numerose cellule dislocate in quasi tutte le provincie lombarde le quali, disponendo di infiltrati sia nelle sezioni comuniste, sia in vari luoghi di lavoro, tenevano costantemente informato Cattaneo su ogni possibile “azione sovversiva” dei comunisti. Il MACI non può essere “tout court” definito una organizzazione di tipo Stay Behind, poiché le sue caratteristiche erano più consone a quelle di una sorta di servizio segreto parallelo capace di avere un capillare controllo del territorio al fine di prevenire eventuali atti ostili del “nemico”. Tuttavia, anch’esso disponeva di una dimensione prettamente militare e la assoluta maggioranza dei suoi componenti erano ex partigiani anticomunisti pronti a riprendere le armi (molte delle quali vennero occultate anche nelle sacrestie) qualora ciò servisse ad impedire che in Italia si affermasse un regime di tipo sovietico. Rispetto a quella della “Osoppo-Organizzazione O” e di Gladio, la vicenda del MACI è molto meno nota, eppure la sua importanza deve essere considerata assoluta in quanto tale struttura, come si vedrà, aveva come diretti referenti sia la Democrazia Cristiana, sia le più alte autorità ecclesiastiche. Di enorme interesse da questo punto di vista appare una missiva riservata che nel 1948 l’allora segretario provinciale della DC milanese, Vincenzo Sangalli, inviò a Pietro Cattaneo, e nella quale era scritto che la DC riconosceva proprio il MACI quale unica organizzazione armata legittimata ad agire in suo nome.
Per consistenza numerica e diffusione nel territorio, la Osoppo e il MACI sono da ritenersi le principali strutture segrete anticomuniste a carattere armato sorte in Italia prima del 1956. Se della Osoppo è certa la continuità con Gladio, la stessa cosa non la si può affermare con sicurezza per quanto riguarda il MACI, anche se non sembra essere un caso che gli ultimi documenti in cui si parla dell’esistenza di tale rete militare cattolica siano risalenti alla metà degli anni cinquanta. Dal 1956 in poi infatti, della organizzazione militare del MACI non si hanno più notizie ed è perciò verosimile ipotizzare che anch’essa, come la Osoppo, sia stata sciolta all’atto della nascita di Stay Behind, avvenuta nel novembre di quell’anno.
Nella ricostruzione della storia di Gladio e delle strutture ad essa prodromiche c’è infine un altro importante aspetto che deve essere affrontato ed è quello relativo ai supposti “misteri” ed alle presunte trame oscure che ancora oggi graverebbero intorno all’esistenza di tali entità. Sebbene infatti Stay Behind in sede giudiziaria sia stata assolta, è oggettivamente da riconoscere, senza per questo fare della facile dietrologia, che la sua vicenda presenta ancora svariati nodi da sciogliere. Si renderà quindi necessario cercare di rispondere anche ad alcuni cruciali quesiti quali, tra gli altri, quello relativo alle eventuali collusioni fra le suddette strutture e il neofascismo, sui possibili sconfinamenti nell’illegalità di cui alcuni elementi ad esse organici potrebbero essersi resi responsabili, nonché all’interrogativo, che come vedremo è verosimilmente quello di maggiore rilevanza, se davvero oggi conosciamo per intero la storia delle organizzazioni Stay Behind o se in realtà non vi sia un altro livello, parallelo alla stessa Gladio, che non è ancora venuto alla luce. Al tempo stesso però, allorchè verranno affrontate tali questioni, sarà fondamentale ricordare che Gladio (così come le organizzazioni ad essa affini) è uscita totalmente assolta da ogni procedimento penale. Se è quindi pur vero che permangono zone d’ombra ed aspetti non ancora perfettamente chiariti, è tuttavia imprescindibile avere presente quella che è ad oggi la verità giudiziaria. Questo non significa ovviamente che essa sia di riflesso una verità in senso assoluto, ma non si può non tenere conto che, secondo la magistratura, una prova concreta ed inconfutabile di un coinvolgimento di Gladio in atti di tipo eversivo non è mai emersa.
Fino a questo momento si è avuto modo di parlare di strutture anticomuniste, ma c’è un altro tema la cui conoscenza si deve considerare una integrazione essenziale ai fini di redigere una ricostruzione realmente completa della storia delle organizzazioni segrete a carattere paramilitare presenti sul territorio italiano dal dopoguerra in poi. Se è infatti indiscutibile che fin dal 1945 in Italia nacquero una molteplicità di formazioni armate “nemiche” del PCI e la cui esistenza era ignota non solo all’opinione pubblica, ma anche a gran parte del Parlamento, è oggi altrettanto dimostrato che in quegli stessi anni anche il Partito Comunista Italiano possedeva una sua organizzazione militare segreta.
Si trattava di quella che, con una dicitura impropria ma divenuta ormai di uso comune, è stata chiamata “la Gladio Rossa” <17. Questo termine fu usato per la prima volta nel maggio 1991 in una inchiesta del settimanale l’Europeo firmata dai giornalisti Romano Cantore e Vittorio Scutti, i quali, basandosi in gran parte su quanto loro dichiarato da un ex dirigente toscano del PCI di nome Siro Cocchi, “rivelarono” che per anni, a partire dal 1945, era esistito un apparato militare facente capo al PCI e che di fatto avrebbe costituito una sorta di “contraltare” di Gladio. La “Gladio Rossa” sarebbe infatti stata una specie di quinta colonna dei paesi comunisti dislocata in Italia ed essa, in caso di invasione del territorio italiano da parte di truppe sovietiche, avrebbe dovuto operare in loro favore, agendo attraverso forme di guerriglia da attuare contro gli Eserciti Alleati. Sebbene la descrizione che la suddetta inchiesta giornalistica fornì di tale struttura armata fosse oggettivamente piuttosto generica, quell’articolo dell’Europeo ebbe un effetto dirompente, poiché pochi giorni dopo la sua pubblicazione, la Procura di Roma decise di aprire un fascicolo di indagine in relazione alla presunta esistenza di una organizzazione paramilitare organica al PCI, sui suoi possibili collegamenti coi paesi del blocco sovietico e su suoi eventuali piani insurrezionali. Fu così che ebbe inizio l’inchiesta su quella che da quel momento si cominciò a chiamare convenzionalmente “la Gladio Rossa”. Dopo che nei mesi precedenti il dibattito politico era stato in gran parte monopolizzato dal caso di Stay Behind e dalle dure invettive che “da sinistra” vennero rivolte alla Democrazia Cristiana, colpevole, si disse, di aver dato copertura ad una struttura eversiva, nelle settimane seguenti a quel maggio 1991, a finire sul “banco degli imputati” furono gli ex comunisti, a loro volta accusati di aver strumentalmente utilizzato l’esistenza di Gladio per dare una falsa immagine della storia d’Italia. Proprio la vicenda della “Gladio Rossa”, fu allora detto, dimostrava quanto fossero fasulle le ricostruzioni storiche che fino a quel momento erano comparse nella “stampa progressista” e che avevano descritto il PCI quale partito che mai deflettè dal rispetto della Costituzione e dei valori democratici, cui dall’altra parte si sarebbe invece opposta una DC asservita agli interessi americani e con loro complice di qualunque artificio pur di non mandare al potere i comunisti <18.
[NOTE]
16 SRACS, Relazione Andreotti, cit., pag. 5.
17 Ovviamente la struttura militare del PCI non si chiamò mai Gladio Rossa, che è solo un nome che si cominciò ad usare nei primi anni novanta (quando uscirono i primi documenti attestanti l’esistenza di tale struttura) per analogia con l’altra Gladio, quella anticomunista.
18 A distinguersi in modo particolare in questa campagna di stampa tesa a “rivalutare” Gladio e ad accusare i post-comunisti di strumentalità politica, fu soprattutto il Giornale all’epoca diretto da Indro Montanelli. Rievocando quei giorni, Montanelli ha scritto: “Gladio divenne un’arma preziosa per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dallo sfascio dell’ideologia e dei partiti comunisti e per avvalorare la tesi che l’Italia fosse vissuta in una falsa democrazia, viziata da presenze poliziesche, autoritarie e golpiste (….) con il risultato che unico partito rispettabile, in tanto sfascio, rimaneva il PCI poi divenuto PDS, sconfitto dalla storia recente; ma che si pretese fosse rivalutato, grazie ad un’abile operazione trasformistica (…)” (I. Montanelli, M.Cervi, L’Italia degli anni di piombo, in Storia d’Italia, Vol. XI, RCS Libri, Milano 2004, pag. 39).
Giacomo Pacini, Le organizzazioni paramilitari segrete nell’Italia Repubblicana (1945-1991), Tesi di laurea, Università degli Studi di Pisa, Anno Accademico 2005-2006
Nel 2001 Gianni Donno, docente di storia contemporanea all’Università di Lecce e consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo e le stragi, ha pubblicato una corposa raccolta di documenti, corredata da brevi commenti, riguardanti la cosiddetta «Gladio rossa», ossia la presunta struttura paramilitare del Pci che avrebbe avuto non scopi difensivi, ma rivoluzionari ed offensivi in vista del ribaltamento dello Stato democratico [cfr. G. Donno, La Gladio rossa del Pci (1945-1967), Rubbettino, Soveria Mannelli 2001]. La credibilità dell’impianto del volume, stante anche l’impostazione fieramente anticomunista dell’autore (che giunge a suggerire dei fili di collegamento non solo culturale e politico ma persino organizzativo tra il Pci e le Brigate rosse), è tuttavia, a mio avviso, piuttosto dubbia. Donno, infatti, si basa su pochi documenti, spesso provenienti dal Sifar o da altre fonti informative – non meglio identificate – del ministero dell’Interno: gli stessi estensori delle relazioni, del resto, usano il tempo condizionale nei loro scritti, incerti dell’attendibilità delle fonti e, in almeno un caso, è lo stesso ministro Tambroni a commentare la nota come generica e quindi inutile. Per non parlare, poi, della ventilata esistenza di un «archivio segreto del Pci», di cui Donno parla per pagine senza avere prove (Ivi, pp. 67-72).
Ilenia Rossini, Conflittualità sociale, violenza politica e collettiva e gestione dell’ordine pubblico a Roma (luglio 1948-luglio 1960), Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Anno Accademico 2014-2015
Sono necessarie due premesse: la prima nel merito e la seconda nel metodo. Innanzitutto è verosimile che il Pci disponesse di una solida tradizione in attività di intelligence, variamente definite come riservate o addirittura paramilitari, volte a tutelare il partito nel teso clima del secondo dopoguerra <1222.
1222 Maurizio Caprara, Lavoro riservato: i cassetti segreti del Pci, Feltrinelli, Milano 1997. Si veda anche il lavoro storico, ma attraversato dalle ragioni della polemica politica, di Carmelo Giovanni Donno, La “Gladio rossa” del Pci 1945-1967, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001.
Andrea Tanturli, La parabola di Prima linea. Violenza politica e lotta armata nella crisi italiana (1974-1979), Tesi di dottorato, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Anno Accademico 2016-2017
Praticamente una fotografia della situazione italiana in quegli anni con un partito Comunista cosciente di essere destinato ad un’eterna opposizione per le probabili conseguenze golpiste di un’eventuale salita al potere, come anche del diffuso e sottaciuto italico sentimento di indipendenza dall’Occidente e dall’Oriente che avrebbe impedito o reso difficile qualunque invasione. Infatti anche la famosa “Gladio Rossa”, che avrebbe teoricamente contato su migliaia di individui, è ampiamente infiltrata dai servizi segreti delle Forze Armate <272.
272 Pelizzaro G.P., Gladio Rossa, edizioni Settimo Sigillo, Roma, 1997
F. Marco Valli, Strategia, strateghi e pop culture nella guerra fredda: da Hiroshima alla Luna (1945-1969), Tesi di dottorato, Sapienza Università di Roma, Anno Accademico 2020-2021
#1945 #1946 #1956 #1991 #AndreaTanturli #anticomunismo #DC #FMarcoValli #Friui #GiacomoPacini #Gladio #IleniaRossini #Jugoslavia #MACI #milano #O #organizzazioni #Osoppo #paramilitari #PCI #Rossa #segrete #StayBehind #URSS #USA