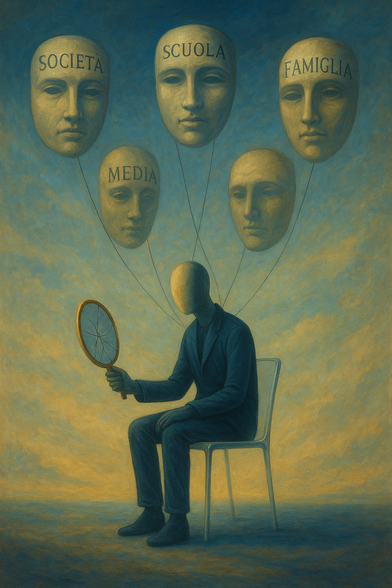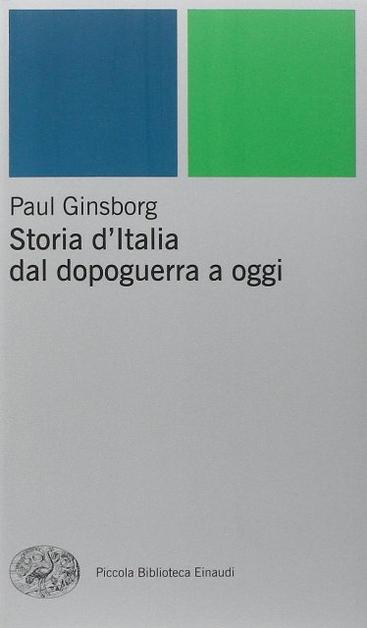La possibilità di intraprendere le riforme era soggetta all’apertura a sinistra dei governi democristiani
I cambiamenti sociali derivati dal boom economico e gli squilibri economici e sociali che minacciavano lo sviluppo italiano attendevano una risposta sul piano politico. Tale risposta doveva consistere in una serie di riforme di grande portata che avevano bisogno di un largo consenso per la loro messa in atto. <6
La possibilità di intraprendere le riforme era soggetta all’apertura a sinistra dei governi democristiani. Questa apertura fu lenta ed ostacolata dall’una e dall’altra parte. Da un lato, infatti, nella Democrazia Cristiana (d’ora in avanti DC) continuavano a prevalere posizioni attendiste come quelle dei dorotei, nati nel 1959, che divennero presto la corrente dominante nella DC. Questi fecero di tutto per rinviare l’apertura a sinistra. Infatti, ritenevano che non fosse ancora arrivato il momento dato che non esistevano garanzie tali da soddisfare gli imprenditori e la Chiesa cattolica.
I primi tentativi di governo di centro-sinistra furono a livello locale, a Milano, Genova, Firenze, Venezia e altri comuni di minore importanza.
In quegli anni, però, si verificarono due importanti cambiamenti sulla scena internazionale che accelerarono le scelte politiche a favore di un giro a sinistra.
Nel 1961 John Kennedy era diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America e la nuova amministrazione americana aveva accettato con una certa rassegnazione il centro-sinistra, considerandolo come l’unica soluzione alla situazione italiana. Con il centro sinistra l’Italia avrebbe potuto affrontare le riforme necessarie e allontanato il pericolo dei comunisti dal governo, favorendo un’unione con il più moderato Partito Socialista Italiano (d’ora in avanti PSI).
Nel 1958 la morte di Pio XII e l’ascesa al trono pontificio di Giovanni XXIII costituì un’altra importante spinta verso il cambiamento, soprattutto quando, nel 1961, Papa Roncalli iniziò un processo che avrebbe portato la Chiesa cattolica a rivedere i rapporti con la società e con la politica italiane. Non più intromissioni dirette in politica: la Chiesa doveva centrare la propria azione nella ricerca della giustizia sociale e nella difesa dei più umili. Doveva assumere un ruolo eminentemente pastorale e spirituale. Nell’ultima enciclica del 1963, “Pacem in Terris”, il papa invitava alla conciliazione inernazionale, al rifiuto delle barriere della guerrra fredda, alla neutralità della Chiesa. Indirizzare l’enciclica «a tutti gli uomini di buona volontà» significava credere nella necessaria collaborazione tra i cittadini di diverse credi religiosi e politici. C’erano anche riferimenti alla classe lavoratrice per la quale il papa auspicava un miglioramento economico e sociale. E non venivano dimenticate neppure le donne che dovevano fare il loro ingresso nella vita pubblica. Insomma, in tal modo si creavano le basi per un possibile dialogo tra cattolici e marxisti. <7
In un convegno della DC del 1961, a San Pellegrino, venne proposta una programmazione orientativa del mercato verso obiettivi sociali: la piena occupazione, lo sviluppo del mezzogiorno, l’equità distributiva. Il mercato lasciato a se stesso aveva aumentato gli squilibri geografici, sociali e produttivi italiani ed era necessario un intervento di pianificazione economica da parte dello Stato. Si trattava di un importante passo per gettare le basi teoriche di un’alleanza con il PSI.
Nello stesso convegno, si evidenziò anche il pericolo che il boom economico rappresentava per l’elettorato DC (l’abbandono delle campagne da parte dei contadini e delle classi medie rurali). Da qui la necessità sul piano sociale di prestare maggiore attenzione alle nuove classi urbane per attrarle al partito. Sul piano politico era necessaria una ridefinizione delle relazioni con il PSI.
La dirigenza del partito poi vedeva nell’unione con il centro-sinistra l’occasione per creare una maggioranza più ampia e solida alla Camera nonché l’opportunità di dividere la sinistra, separando per sempre i socialisti dai comunisti.
Aldo Moro, allora segretario DC, proponendo un’unione con il PSI in modo forse ambiguo ma tale da tranquillizzare tutti e superare le obiezioni di oppositori e fautori del centro-sinistra, riuscì ad ottenere l’appoggio della maggioranza del suo partito. <8
Anche in campo economico i più alti dirigenti del settore pubblico e privato si convertirono alla via moderata al centro-sinistra intrapresa dalla DC. Continuavano ad essere contrari la Confindustria e la maggioranza dei piccoli e medi imprenditori spaventati dalle possibili riforme che avrebbero aumentato il costo della forza lavoro e concesso maggiore spazio alle organizzazioni sindacali. Erano ben consapevoli che una gran parte del miracolo economico si doveva proprio a quello.
Il punto cruciale dell’accordo era il programma da presentare. Esistevano tre possibili vie: 1º) un programma che accettava il modello economico capitalista, ma vedeva la necessità di riforme correttive idonee ad affrontare i problemi storici dell’Italia: la povertà del Sud, l’arretratezza dell’agricoltura ecc. Era necessario rendere più efficiente la burocrazia, dar vita all’organizzazione regionale, riorganizzare gli enti locali per fronteggiare i nuovi bisogni derivati dalla rapida urbanizzazione, costruire case e scuole, modernizzare il sistema educativo, creare un nuovo servizio sanitario e di sicurezza sociale su scala nazionale. La ricchezza generata dal boom economico sarebbe stata la spinta necessaria per questo ambizioso programma di riforme. 2º) Un programma basato su riforme strutturali per distruggere il sistema capitalista e creare un sistema alternativo. Questa via può forse essere considerata utopica, dato che non teneva conto della resistenza che avrebbe offerto la maggior parte della società italiana. 3º) Infine, un programma minimalista di riforme correttive ma portate avanti non al prezzo di minare l’egemonia del partito della DC.
La storia dei governi di centro-sinistra (dal 1962 al 1968), caratterizzati dall’immobilismo e dall’incapacità di portare a termine i vasti programmi di riforme promesse all’elettorato dimostra come alla fine fu la via minimalista a prevalere.
Poche furono le riforme effettivamente attuate e spesso i risultati non furono positivi. La nazionalizzazione dell’industria elettrica non riuscì né ad escludere l’ingerenza degli ex monopoli, né a ridurre i costi per i consumatori. Furono rinviate l’istituzione delle Regioni e l’introduzione del sistema sanitario nazionale, mentre un tentativo di riforma globale della pianificazione urbanistica fu definitivamente abbandonato per l’opposizione di alcuni settori dell’opinione pubblica. Nel 1968 due decreti ministeriali cercarono di palliare questa lacuna legis, fissando almeno gli standard urbanistici e i limiti di edificabilità ai bordi delle strade. Fecero eccezione la riforma della scuola media unificata e l’elevamento dell’obbligo scolastico ai 14 anni, nonostante un iniziale rifiuto da parte degli stessi insegnanti. Tuttavia, non si era fatto nulla per modernizzare organizzazione e contenuti della scuola superiore e dell’Università.
Complice anche una difficile situazione economica, le riforme furono frenate e costantemente rinviate a causa, si può ragionevolmente supporre, delle pressioni esercitate sulla politica dai grandi gruppi di potere economico. <9
I governi di centro sinistra non erano quindi riusciti a dare risposte credibili alle molteplici esigenze di un’Italia in rapido cambiamento. Il loro fallimento, confermato dalla crescente disoccupazione (soprattutto femminile), dalla chiusura di molte piccole aziende o dal loro assorbimento da parte delle aziende maggiori, dal calo dei consumi, dalla diminuzione del potere contrattuale dei lavoratori, ebbe importanti conseguenze sul piano elettorale, favorendo un calo dei voti per la DC ed un aumento per il Partito Comunista Italiano (d’ora in avanti PCI) nelle seguenti elezioni politiche.
La mancanza delle necessarie riforme correttive causò anche un grave logoramento dell’apparato statale. L’impresa pubblica che stava per concludere la stagione del grande sviluppo iniziata negli anni Cinquanta con lo sviluppo della siderurgia, la costruzione delle autostrade, l’espansione della rete telefonica, di lì a pochi anni perse la capacità di produrre profitti e finì in perdita. Si deve ricordare che l’industria pubblica non si autofinanziava, ma otteneva facilmente finanziamenti pubblici; inoltre, era esente da qualsiasi tipo di controllo super partes, rispondeva solo al ministro delle Partecipazioni statali. I dirigenti nel settore pubblico, anche per i livelli più bassi, venivano scelti per norma dai partiti politici secondo i principi della lottizzazione. Ciò favorì la nascita e il perpetuarsi al potere di una nuova generazione di imprenditori ed amministratori pubblici strettamente legata ai partiti politici dominanti che godette di estrema libertà di azione.
Una delle promesse incompiute dei governi di centro-sinistra riguardava la modernizzazione della burocrazia italiana che dava importanti segnali di paralisi. Impiegati statali anagraficamente vecchi ed ancorati alle vecchie procedure, si dimostravano contrari ad ogni tipo di innovazione. Inoltre, i finanziamenti destinati dallo Stato alla pubblica amministrazione spesso non venivano utilizzati a causa della complessità della rete giuridico-amministrativa e le leggi restavano inattuate.
Qualcosa di simile accadeva anche nelle relazioni con la Comunità europea e gran parte degli aiuti stanziati per l’agricoltura non vennero utilizzati.
Per ultimo il decennio dei governi di centro-sinistra fu caratterizzato nel meridione dall’aumento esponenziale del clientelismo grazie a quattro fonti economiche essenziali: 1º) il boom edilizio; 2º) i nuovi poli di sviluppo industriale sovvenzionati dalla cassa per il mezzogiorno; 3º) le risorse finanziarie degli enti locali; 4º) la distribuzione di fondi da parte del governo ad alcuni gruppi della società civile come i pensionati (aumento delle pensioni per invalidità e pensioni sociali). Ciò diede ai governi locali democristiani la possibilità di creare una serie di meccanismi che permetteva loro di conquistare consensi in ogni strato della popolazione, malversando il denaro pubblico a favore degli interessi privati e del partito.
[NOTE]
6 Paul Ginsborg, Storia d’Italia…, cit., p. 344 e ss.; Matteo Re, La Italia actual: evolución histórica y cultural desde 1945 hasta nuestros días, Madrid, Editorial Universitas, Edición actualizada, 2011, p. 93 e ss.
7 Paul Ginsborg, Storia d’Italia…, cit., p. 353.
8 Paul Ginsborg, Storia d’Italia…, cit., p. 356-7.
9 Paul Ginsborg, Storia d’Italia…, cit., p. 377. L’autore ricorda la “politica dei due tempi” promossa da Aldo Moro.
Lilia Zanelli, Gli anni di piombo nella letteratura e nell’arte degli anni Duemila, Tesi di dottorato, Università di Salamanca, 2018
#anni #centroSinistra #Confindustria #DC #economia #governi #LiliaZanelli #PCI #pontefice #PSI #riforme #Sessanta #società