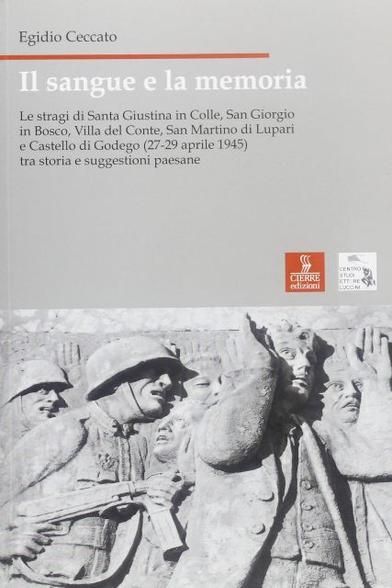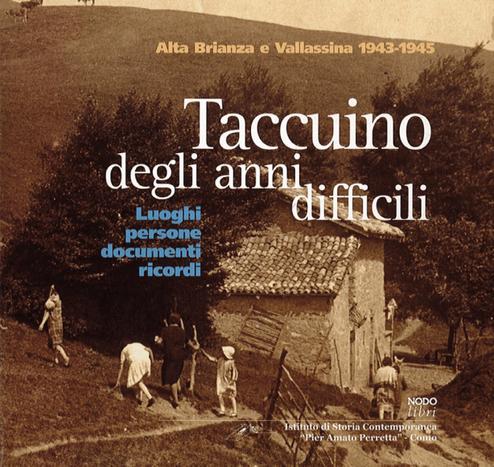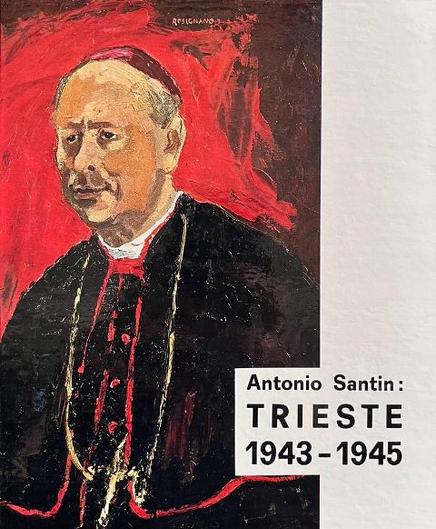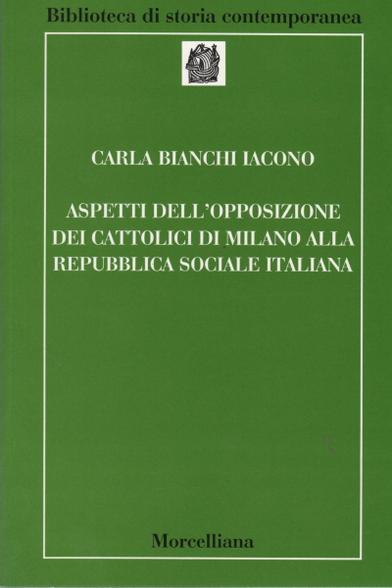La tempestiva azione del Gruppo Marina consentì di salvaguardare molte delle opere della Marina
La Marina fu anche protagonista nella liberazione di Venezia. Il 28 aprile il Gruppo Marina, che faceva capo al contrammiraglio Franco Zannoni, appartenente al Comitato Centrale Militare, alle dipendenze del C.L.N., entrò in azione sin dall’alba in concorso con le squadre dei gruppi dei partiti inquadrate per sestiere, riunite sotto il comando del capitano di corvetta Carlo Zanchi. Furono occupate le caserme San Daniele e Sanguinetti, l’ex comando della Marina Repubblicana, vari uffici distaccati, il circolo ufficiali, i Cantieri A.C.N.I.L. e Celli, il Magazzino viveri di San Biagio. Il Gruppo attaccò a mano armata l’Arsenale, disperdendo con il fuoco delle armi gli ultimi residui centri di resistenza del forte reparto della Marina tedesca che aveva protetto la fuga del comando tedesco dell’Arsenale. Fu lanciato un ultimatum che prevedeva che i tedeschi lasciassero l’Arsenale entro le 16, senza attuare il piano distruttivo previsto e senza far saltare la polveriera della Certosa. Poco prima dell’ora di scadenza fu alzata la bandiera nazionale sui pennoni delle torri e il capitano di vascello Rosario Viola, per delega del C.L.N., assunse il comando temporaneo dell’Arsenale, nominando il colonnello delle Armi Navali Alberto Gerundo direttore di Marinarmi e il tenente colonnello del Genio Navale Alfio Denaro, direttore di Maricost. La tempestiva azione del Gruppo Marina consentì di salvaguardare molte delle opere della Marina; l’Arsenale, in particolare i macchinari e i bacini, aveva già subito notevoli danni a opera dei tedeschi. Gli oltre trecento uomini della X MAS, con i loro ufficiali e l’armamento al completo, si asserragliarono nella caserma Sant’Elena; dovettero essere condotte lunghe trattative poiché essi richiedevano salvacondotti che li mettessero al sicuro dall’azione dei partigiani; cosa che il C.L.N. non voleva dare. Fu necessario un ultimatum dato il 29 per arrivare alla resa, che si svolse il 30, in concomitanza con l’arrivo dei reparti dell’Esercito regolare, dei commando alleati e degli NP della Marina. Grazie all’arrivo dei commando il Gruppo Marina di Lido poté procedere all’occupazione delle principali batterie, che fino ad allora avevano minacciato di aprire il fuoco sulla città, al disarmo del personale della Difesa e alla cattura dei numerosi mezzi della Marina Repubblicana, compresa una motosilurante.
Giuliano Manzari, La partecipazione della Marina alla guerra di liberazione (1943-1945) in Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, Periodico trimestrale, Anno XXIX, 2015, Editore Ministero della Difesa
L’ultima fase dell’azione partigiana a Venezia si intensificò nel mese di aprile del 1945, dopo che il 10 aprile le forze alleate avevano attaccato la Linea Gotica. A Venezia, ancora una volta, si ripresenta una situazione unica per gli spazi e le modalità con cui si svolse l’Insurrezione. L’obiettivo comune era quello di preservare la città nel suo complesso, nel suo patrimonio storico e artistico, nel suo patrimonio archivistico legato alle amministrazioni e ai ministeri fascisti, nel patrimonio industriale di Porto Marghera <230. L’andamento iniziale dell’insurrezione fu quindi lento, parziale, anche per timore delle rappresaglie e dell’isolamento di cui Venezia godeva rispetto al fronte militare di terra. In seguito, tra il 25 e 26 aprile, il moto insurrezionale si fece più forte, grazie ad un più convinto intervento della popolazione locale. Ancora fondamentale fu la rivolta dei detenuti che si tenne nel carcere di Santa Maria Maggiore il 26 aprile del 1945, e le insurrezioni operaie che si ebbero in molte fabbriche di Marghera. Nella notte del 27 aprile i volontari dei GAP e delle brigate cittadine riuscirono ad occupare la caserma di San Zaccaria <231. Solo agli inizi di maggio furono isolate e sconfitte le ultime cellule di fascisti che ancora presidiano i punti strategici o le caserme, come accadde con la X MAS a Sant’Elena <232, l’8 maggio del 1945. In questo clima avvenne quindi la mediazione con le forze tedesche grazie alla partecipazione, come mediatore, del patriarca Piazza, che non era mai stato vicino alla resistenza <233. L’intervento del patriarca come responsabile delle trattative fu promosso, oltre che per salvaguardare la città e i cittadini, anche per interessi politici di arginamento delle forze partigiane più a sinistra. Questo episodio fece discutere molti aderenti alla resistenza già all’epoca <234. Il 28 aprile, in Piazza San Marco, mentre le truppe alleate entravano in città, una grande manifestazione fece sventolare nel cielo il tricolore. Venezia era libera, la guerra era terminata.
[NOTE]
230 ERNESTO BRUNETTA, La lotta armata: spontaneità e organizzazione, in GIANNANTONIO PALADINI, MAURIZIO REBERSCHAK, GIUSEPPE TATTARA (a cura di), La Resistenza nel Veneziano, Università di Venezia, Istituto Veneto per la Storia della Resistenza, Venezia, 1985, p. 437.
231 Ivi, p. 439.
232 Ivi, p. 438.
233 MAURIZIO REBERSCHAK, I cattolici veneti tra fascismo e antifascismo, in EMILIO FRANZINA (a cura di), Movimento cattolico e sviluppo capitalistico, atti della giornata di studi (Venezia, 1974), Marsilio, Venezia, Padova, 1974
234 GIULIO BOBBO, La lotta resistenziale a Venezia, in GIULIA ALBANESE, MARCO BORGHI (a cura di) Memoria resistente: la lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei protagonisti, Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, Nuova Dimensione, Venezia, Portogruaro, 2005, p. 234
Francesco Donola, Armando Pizzinato: pittore partigiano, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2022-2023
In quasi tutte le parrocchie, comunque, si verificarono scontri armati, più o meno accaniti, tra le parti: «I tedeschi parevano furie scatenate; sparavano in tutte le direzioni; si temeva quasi una rappresaglia»; a Noale, però, la nutrita sparatoria ingaggiata dai fuggitivi, col timore di un’imboscata, non ebbe risposta e «fu assicurato alle staffette tedesche libero il passaggio e così il paese non ebbe a soffrire alcun danno per la ritirata» <492. A quanto riportato dalle cronistorie, comunque, furono scongiurati tragici spargimenti di sangue e, all’arrivo degli alleati, il 30 aprile, il bilancio era di qualche caduto, in entrambi gli schieramenti, e qualche prigioniero tedesco arresosi. Fortunatamente, l’unico episodio di “rappresaglia” nei confronti della popolazione, si risolse, a Peseggia [frazione del comune di Scorzè, in provincia di Venezia], da parte di alcune SS, nell’atto di chiudere a chiave nel campanile, un gruppo di ostaggi. Nulla di paragonabile alle decine di vittime che, con il proprio corpo, protessero la ritirata nazifascista lungo quel tristemente famoso percorso, rievocato da Egidio Ceccato in “Il sangue e la memoria” <493. A differenza di quanto accadde in alcune parrocchie in corrispondenza di altri eventi significativi, quali, ad esempio, la caduta di Mussolini, questa volta, i curati non poterono esimersi dal celebrare con «festoso scampanio» <494 l’avvenuta liberazione, facendo da sfondo allo sventolio di bandiere e fazzoletti con il quale la popolazione dava sfogo al proprio entusiasmo.
[…] I contenuti di un volantino del C.L.N., rinvenuto fra gli incartamenti della prefettura repubblicana veneziana per l’anno 1945, fanno presagire il subitaneo riaffiorare delle contrapposizioni ideologiche in concomitanza con il volgere al termine della parentesi resistenziale e, di conseguenza di quella che fu, senza giri di parole, rassegnata convivenza e forzata collaborazione; i «corvi neri» “che un giorno si sono inchinati al fascismo e ne hanno incensato i capi e le loro opere tentano ora di spacciare la falsa moneta del loro patriottismo per usare della vostra opera e del vostro sacrificio […]. Stanno ancora col piede sui due piatti della bilancia, pronti ad abbandonarvi e negare se il vento dovesse cambiare direzione. Lavorano nel silenzio e nel mistero per non rilevare ora la loro identità. […] continuano la loro trama diretti da un papa già fascista, ora filo-inglese, domani ancora fascista se gli avvenimenti e l’interesse dovesse consigliarli [sic] di mutare bandiera”. All’esortazione «Diffidate dei preti!», seguivano i capisaldi della polemica anticlericale, ossia le accuse rivolte al clero di tenere i fedeli lontani dalla cultura «in stato di ignoranza, di inferiorità, perché non scopriate le loro menzogne per dominarvi con l’oscurantismo e la paura. […] Siate uomini e non schiavi della sottana nera» [27 gennaio 1945] <498.
[NOTE]
498 ACS, cit., cat. K42, b. 50, fasc. 92, «Venezia. Attività del clero».
492 Don E. Neso, Cronaca relativa alla parrocchia di Noale. Dicembre 1943-Giugno 1945, op. cit., p. 3.
493 E. Ceccato, Il sangue e la memoria, op. cit.
Daiana Menti, Il clero del Miranese dall’inizio del Novecento alla seconda guerra mondiale nelle sue relazioni con le pubbliche autorità, Tesi di Laurea, Università Ca’ Foscari Venezia, Anno Accademico 2012-2013
#1945 #aprile #Città #clero #CLN #curati #DaianaMenti #fascisti #FrancescoDonola #frazione #GiulianoManzari #Liberazione #maggio #Marina #Militare #MiranoVE_ #NoaleVE_ #parroci #partigiani #provincia #Resistenza #ScorzèVE_ #tedeschi #Venezia