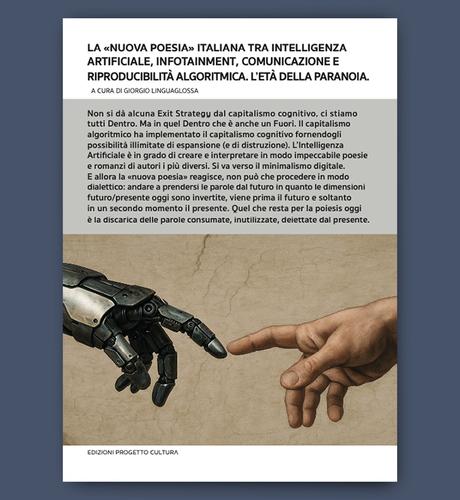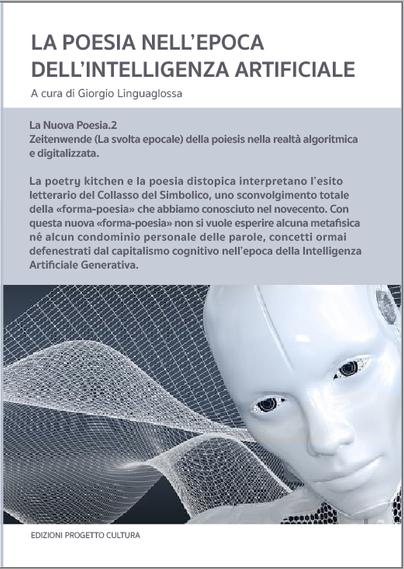Editoriale (Quaderno nn. 29-30, 17×24, de “Il Mangiaparole”) in corso di stampa dal titolo: La «nuova poesia» italiana tra Intelligenza Artificiale, Infotainment, Comunicazione e Riproducibilità algoritmica. L’età della paranoia, Il nostro mondo è definito dal tipo di storie in cui crediamo,
La storia letteraria è un libro di ricette.
I cuochi adesso si atteggiano a poeti.
Lo chef di Milano tiene il computo degli invitati.
Adesso anche i contabili si pensano poeti.
Guarda bene l’indice, se non sei tra gli invitati è perché sei nel menù.
I poeti sono i camerieri che portano le vivande e le bevande.
I critici fanno i buttafuori.
In cucina c’è un’orchestrina gitana che suona con le fisarmoniche e i tamburelli.
I poeti preparano i piatti in cucina e intrattengono gli ospiti.
Dovunque ci sono schiocchi di dita e pacche sulla spalla.
C’è allegria.
(Giorgio Linguaglossa)
Editoriale (Quaderno nn. 29-30, 17×24, de “Il Mangiaparole” in corso di stampa dal titolo: La «nuova poesia» italiana tra Intelligenza Artificiale, Infotainment, Comunicazione e Riproducibilità algoritmica
L’Età della paranoia
Il nostro mondo è definito dal tipo di storie in cui crediamo
Se dovessi dare un nome alla nostra epoca la chiamerei l’Età della paranoia. Il recentissimo incontro ad Anchorage, in Alaska, tra Trump e Putin è il cassico incontro di due fratelli siamesi: un gangster che si incontra con un criminale prezzolato. Trump, Xi, Kim Jon-ung, Kameney, Nethanyau, Orban etc., i piccoli e i grandi aspiranti dittatori dispersi per il globo, le masse che votano i loro paranoici rappresentanti non sono meno paranoiche dei loro capi. Il capitalismo cleptocratico non sa che farsene del capitalismo democratico, vuole disfarsene, ha ormai infranto le regole e le istituzioni della deterrenza che ci eravamo dati dalla fine della seconda guerra mondiale. Il capitalismo dei sovrani sovranisti e populisti vuole avere le mani libere, vuole semplicemente fare soldi, togliere ai poveri per dare ai ricchi. Il capitalismo è diventato paranoico, la guerra dei dazi ne è un esempio eclatante. È probabile che nel prossimo futuro verremo sottomessi da una super Intelligenza Artificiale da noi creata. Scrive Geoffrey Hinton, uno degli inventori della Intelligenza Artificiale:
«La maggioranza dei principali ricercatori di intelligenza artificiale ritiene che molto probabilmente creeremo esseri molto più intelligenti di noi entro i prossimi 20 anni. La mia più grande preoccupazione è che questi esseri digitali superintelligenti semplicemente ci sostituiranno. Non avranno bisogno di noi. E poiché sono digitali, saranno anche immortali, voglio dire che sarà possibile far risorgere una certa intelligenza artificiale con tutte le sue credenze e ricordi. Al momento siamo ancora in grado di controllare quello che accade ma se ci sarà mai una competizione evolutiva tra intelligenze artificiali, penso che la specie umana sarà solo un ricordo del passato».
I critici marxisti del capitalismo hanno impiegato la speciosa tesi secondo cui nel mondo del capitalismo maturo (quello finanziario di oggi e quello delle monete digitali) non si dà una Exit Strategy, non si dà più alcuna possibilità di uscire dal capitalismo (se non per ricapitombolare in un capitalismo di stato a carattere autocratico e coercitivo), così il neo-liberismo ha guadagnato il campo rimasto aperto e sguarnito dalle forze della critica.
Ma forse non è necessario sostenere la tesi di una Exit Strategy, non c’è bisogno di sortire fuori dal nastro di Möbius, perché stiamo sempre in un Dentro che è anche un Fuori. Il lato debole del migliore pensiero critico marxista (Benjamin, Adorno, Gramsci, Zizek) non è riuscito a pensare questa evenienza che la scienza ci ha rivelato, e si è trovato appiattito nel voler cercare una soluzione comunque e dovunque, e così è rimasto impigliato come una mosca nella carta moschicida.
Allora, non c’è che ribadire: Non si dà alcuna Exit Strategy, stiamo tutti Dentro. Ma in quel Dentro che è anche un Fuori.
La poesia odierna oggi non può che andare a prendersi le parole dal futuro in quanto le dimensioni futuro/presente oggi sono invertite, viene prima il futuro e soltanto in un secondo momento il presente. Non c’è modo di rammaricarsene. Ecco le ragioni che spiegano la depletazione derubricazione del passato (leggi tradizione) e la invasione del futuro nel presente. Ecco le ragioni che spiegano la depletazione e la derubricazione delle antiche categorie antinomiche /Avanguardia/Retroguardia, Tradizione/Antitradizione, Vecchio/Nuovo perché queste categorie si trovano nel nastro di Möbius, stanno in un Dentro/Fuori che altro non è che un Fuori/Dentro. Nel capitalismo sviluppato la dialettica Dentro/Fuori ha sostituito la antica dialettica hegelo-marxista Soggetto/Oggetto, Nuovo/Vecchio, con il beneficio di inventario dei marxisti ortodossi e degli aborigeni ortodossi, nonché degli eterodossi alla plastilina. Perché meravigliarsi dicendo che oggi non c’è futuro quando in realtà siamo immersi ogni giorno nel futuro, che ha sostituito il presente? Altra domanda retorica: la categoria del Nuovo in arte non è più in contraddizione con il Vecchio, in quanto entrambe si trovano, contemporaneamente, nel medesimo nastro di Möbius.
Per altro verso, avviene che la poiesis distopica non è più distopica allorché la caliamo nell’oggi distopico. La poiesis autoconsolatoria e autotelica che imperversa nei paesi a minimalismo digitale agisce nel senso che si fa i fatti suoi, e così accredita, ammalia e gratifica i benpensanti da autofiction e da autonoleggio con messaggi da pacifinti e da pasticcini alla crema.
Gli umani delle società post-democratiche vivono in modo performativo le loro esistenze. Viviamo nella narrazione che gli altri danno delle loro vite meravigliose su Facebook, Instagram, TikTok, in cui si vedono solo gli highlights, i momenti magici, le torte nuziali. L’influenza delle narrazione raccontate da altri e, soprattutto, dai social media sulla nostra percezione del Reale ci convince che quella sia la realtà. Viviamo in un’èra di disinformazione e di sovraccarico di disinformatzia.
Viviamo ossessionati dalla ricerca di un “sé autentico” (come se il sé autentico fosse un diamante nascosto in chissà quale profondità ascosa del nostro inconscio).
Viviamo traumatizzati dalla scoperta del cambiamento. Cerchiamo l’anedonia, non la felicità. Abbiamo sostituito la felicità con il benessere, il benessere con il fitness, la personalità con una natura adattativa e performativa; gli avanzamenti tecnologici insinuano in noi sgomento e ansia da prestazione. Invariabilmente, sorgono narrazioni distorte, false: novax, notax, i negazionisti, i revisionisti del passato, i terrapiattisti, i bipolaristi, i narcisisti, gli omofobisti, le credenze fideistiche, gli irrazionalisti del MAGA, i primitivisti, i putinisti.
Viviamo in universi completamente diversi solo perché crediamo in storie diverse.
Viviamo con l’ausilio del pedometro.
Crediamo in false narrazioni ma che hanno conseguenze nel mondo del Reale. E Continuiamo a crederci convinti che il «falso» sia il «reale».
Le narrazioni dei social media sono diventate il motore più poderoso della normologia della storia umana.
Viviamo nell’immondezzaio delle storie.
In questo contesto storico, parlare del ruolo della letteratura nel promuovere il pensiero critico è un atto di smisurata ingenuità. Ma è che noi siamo ingenui, inguaribilmente ingenui, e lo pensiamo davvero.
Nel 1951 Isaac Asimov immaginava una scuola fatta soltanto da robot onniscenti. Oggi abbiamo l’intelligenza artificiale. Cosa cambierà?
Nel 2050 la normalità con cui scrolliamo ore al giorno il telefonino sarà studiata come crisi irreversibile dell’attenzione e della memoria?, o fra qualche decennio guarderemo a ChatGpt 5 con la stessa tenera condiscendenza con la quale ricordiamo i pomeriggi passati a giocare con il Commodore 64 o a programmare in Basic?
Il fatto è che siamo diventati diversi perché narriamo storie diverse, creiamo nuove narrazioni che narrano un altro Reale. Viviamo in un ecosistema digitale dove abbiamo accesso a un oceano di informazioni e dati. Il risultato è l’effetto placebo: ci convinciamo che la narrazione a noi più conveniente ci regala benessere, attenua le nostre ansie, le nostre paranoie. Ma è falso. Dobbiamo capovolgere il Reale per vedere bene al suo interno che cosa c’è. Per questo motivo la categoria del «falso» oggi sale sul podio delle Star. Dobbiamo riconoscere che il «vero» è diventato il «falso», e il «falso» è diventato il »vero». È una dialettica al triplo salto mortale quella che dobbiamo mettere in atto. Non ci resta che smascherare il «falso» mediante un altro «falso», la copia con un’altra copia, un duplicato con un altro duplicato.
L’ansia del falso e del vero ci accompagna in ogni momento della nostra vita quotidiana. Optiamo invariabilmente per lo pseudo-falso a noi più conveniente, e rigettiamo il falso, quello vero. E viviamo felici e contenti.
“State attenti però: la nave è ormai in mano al cuoco di bordo”.
“Nel 1949 Richard Feynman mi parlò della sua versione della meccanica quantistica chiamata ‘sum over histories’. Mi diceva:
«l’elettrone fa tutto ciò che vuole. Va in qualsiasi direzione con qualsiasi velocità, avanti e indietro nel tempo, fa come gli pare, e poi si sommano le ampiezze e si ottiene la funzione d’onda». Gli dissi: «Sei un pazzo». Ma non lo era”.
Freeman Dyson mentre racconta dell’idea di Feynman dei path integral (integrale sui cammini). La citazione si trova un po’ ovunque, ma io l’ho presa dal libro “Quantum Field Theory for the Gifted Amateur” di Lancaster e Blundell.
La nostra variante è questa:
«la parola fa tutto ciò che vuole. Va in qualsiasi direzione con qualsiasi velocità, avanti e indietro nel tempo, fa come gli pare, e poi si sommano le ampiezze e si ottiene la funzione poetica»
La poetry kitchen di Francesco Paolo Intini, Mimmo Pugliese, Letizia Leone, la poesia distopica di Antonio Sagredo, Tiziana Antonilli, Marie Laure Colasson e Vincenzo Petronelli sono una hilarocomoedia melanconica e burlesque. Intini la sua meravigliosa lingua di plastilina la impiega e la piega in quanto lingua miserabile che emana un odore di fritto misto di pesce. È la lingua del commercio degli affari propri; questa lingua, o meglio, questo linguaggio, quello che desertifica il logos, quello della poesia del neoermetismo e del quotidianismo in voga oggidì è qualcosa contro cui occorre gridare vendetta. Intini usa questo linguaggio spiegazzato, miserrimo, ipoveritativo e lo fa deflagrare in autentici colpi di scena apoplettici di riso amaro. Francesco Intini, Tiziana Antonilli e Raffaele Ciccarone e gli altri autori dis/topici rappresentano un classico della poesia kitchen perché sono arrivati a tanto facendo del packaging del inguaggio miserabile e spiegazzato che troviamo nelle discariche delle refurtive parolaio-mediatiche.
L’enunciato kitchen e quello distopico agiscono in uno spazio linguistico che è diventato mera superficie, mero nastro di Möbius; in questo spazio o, più propriamente, in questo «campo dinamico», si inscrive il nuovo discorso poetico «superficiario» nella quale la scrittura poetica si presenta in formazioni dis/locate e dis/articolate.
Ma questa dis/locazione è ben più che un artificio retorico, si tratta invece d’una petizione di sopravvivenza in virtù della quale il discorso poetico agisce come all’interno di una «griglia campo-dinamica». Attraverso queste griglie e queste dis/locazioni gli enunciati assumono la connotazione di significato. Ed ecco emergere il senso, il consenso e il significato. Foucault asserisce che è possibile che a volte queste griglie vengano momentaneamente infrante; soltanto in questi casi si dà l’opportunità fugace di fare «esperienza» di qualcosa di «proprio» per il tramite di questa frattura e dell’improprio. È in tal modo ammissibile esperire l’esistenza in sé di qualcosa come un ordine di senso o di non senso, ma si tratta di un pensiero antropizzante. Infrangere questo ordine di senso e di non senso è il compito precipuo della poesia distopica e del kitchen.
Ordine del discorso e ordine del pensiero sono oggi dis/connessi, lo spazio in cui pensiamo e parliamo può essere infranto in qualsiasi momento. E il significato va a farsi benedire. È la situazione limite delle eterotopie, ovvero, quella sorta di «contro-spazi» di cui le culture sono munite e «in cui gli spazi reali, tutti gli altri spazi reali che possiamo trovare all’interno della cultura, sono, al contempo, rappresentati, contestati e rovesciati».1
La poesia distopica è una eterotopia, una reazione allergica all’ordine disciplinare del senso e del significato. Occorre fare in fretta: il panorama poetico italiano invaso dai poeti elegiaci con i loro compitini educati e lucidati deve essere al più presto rigettato. I tavoli delle conferenze culturali sono fatti dello stesso legno di quello delle bare della cultura ammuffita che ha orchestrato quelle confidenze. È vero invece che la poesia nuova scaccia la vecchia per una legge ontologica e biologica. Prima o poi la nuova poesia prevarrà, è solo una questione di tempo. È una questione eventuale, una modalità dettata dalla necessità storica. Prima o poi l’evento accadrà. Whatever it takes.
1 Id., Eterotopie, in Archivio Foucault III , a cura di A. Pandolfi, trad. it. di S. Loriga, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 310.
#Adorno #AntonioSagredo #Benjamin #eterotopie #ExitStrategy #FrancescoPaoloIntini #giorgioLinguaglossa #Gramsci #hilarocomoedia #IsaacAsimov #letiziaLeone #MarieLaureColasson #nuovaOntologiaEstetica #poetryKitchen #RichardFeynman #TizianaAntonilli #VincenzoPetronelli #Zizek