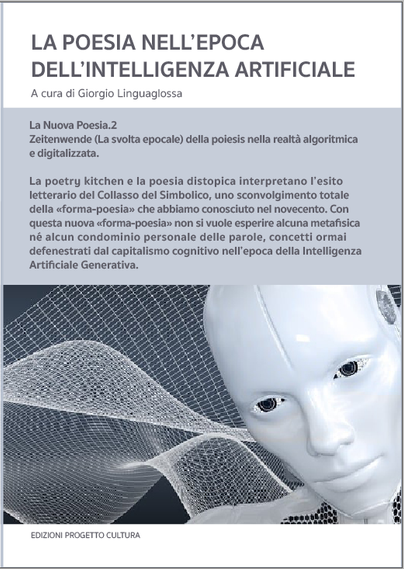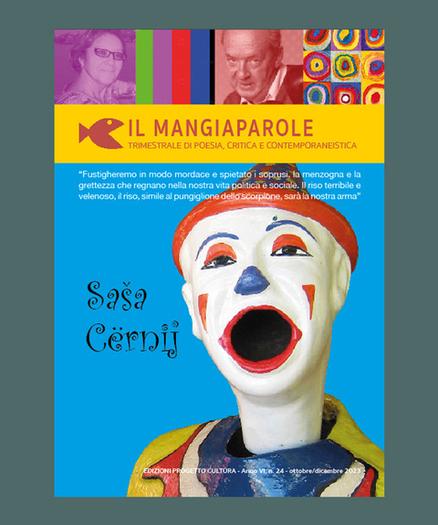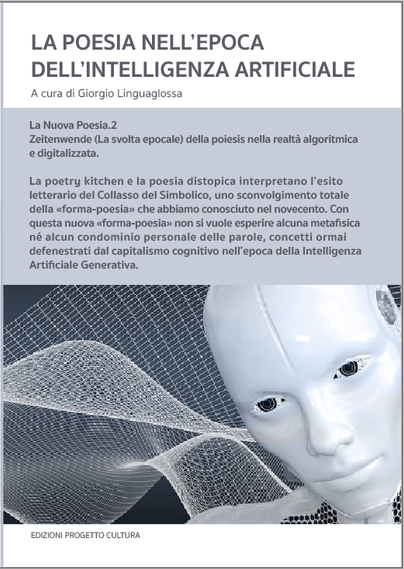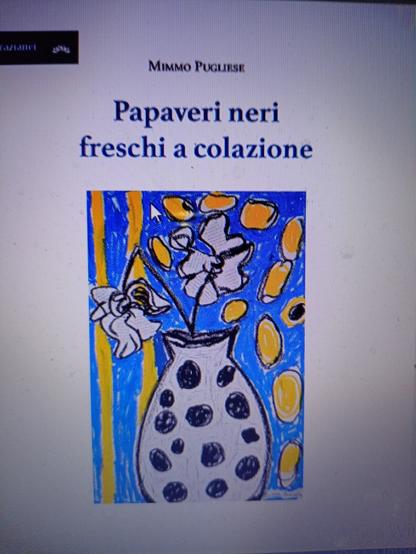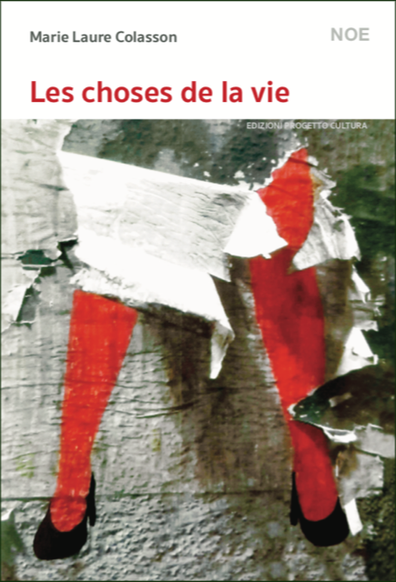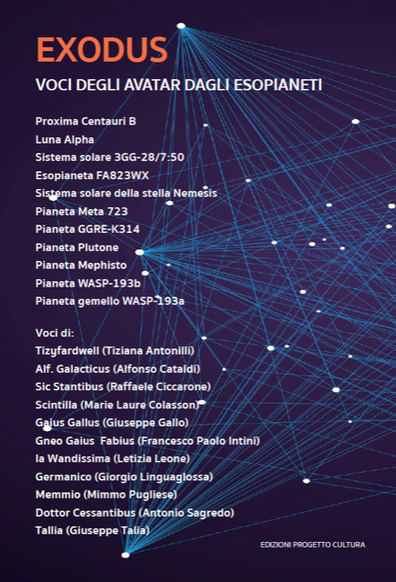L’enunciato kitchen e quello distopico (suo corollario) agiscono in uno spazio che è diventato mera superficie, mero nastro di Möbius, un discorso poetico organizzato per formazioni dis/locate, ibride, dis/funzionali alla idea di tradizione, intesa come ordine linguistico costrittivo – Riflessione di Vincenzo Petronelli
Ben ritrovati cari amici dell’Ombra,
mi fa molto piacere tornare a scrivere su queste pagine che per me hanno il profumo di casa, proprio in coincidenza di quest’articolo, che trovo riassuma emblematicamente dei nuclei centrali della poetica Kitchen.
Come giustamente evidenzia Marie Laure Colasson, la poesia di Francesco Intini, Mimmo Pugliese, Giorgio Linguaglossa e Antonio Sagredo sono dei punti di riferimento imprescindibili per lo sviluppo del progetto Poetry kitchen, per la particolare “piegatura” destrutturante assunta dal loro registro linguistico, rappresentativa del vuoto o se vogliamo della vanificazione del sistema di significazione convenzionale che caratterizza l’epoca attuale.
La “liquidità” del mondo odierno, con la frantumazione dei codici espressivi dovuta al mondo digitale, con la globalizzazione, che ha contaminato le variabili linguistiche locali tradizionali, con la vorticosità dei mutamenti storico-politici ed i loro riflessi culturali, hanno inevitabilmente isterilito la prassi linguistica e comunicazionale cui il mondo si era abituato a partire dal secondo dopoguerra; c’è bisogno – è questo il concetto che sottende l’operazione mimetica della Poetry kitchen – di un modello espressivo che rifletta tale vuoto odierno nella lingua e che evidenzi per converso anche la soggettività e lo sbriciolamento delle immagini, delle metafore e direi anche topoi classici della poesia, ormai inadeguati a ritrarre il mondo e la società attuali. Peraltro, non si tratta solo di una questione di adeguatezza nella rappresentazione mimetica della scrittura poetica, ma anche della necessità di creare nuovi spazi palingenetici per la poesia ed il sapere tutto.
Come abbiamo avuto modo di accennare in un altro articolo, la storia e la filosofia della scienza, ci dimostrano come siano proprio i momenti di crisi dei paradigmi consolidati, corrispondenti alle fasi di transizione storiche, a determinare, negli intellettuali più sensibili ed avveduti, l’opportunità di rinnovare i modelli di conoscenza ed evitare la supremazia di quella che Giorgio chiama correttamente “la lingua dell’idioletto”; quel balbettio pseudo-poetico, che in questo contesto fluido rischia di imporsi, nella grigia comfort zone del conservatorismo culturale, rappresentato dalla poesia del quotidiano.
Come evidenzia opportunamente Marie Laure Colasson nel suo intervento, “è nelle discariche delle refurtive parolaie-mediatiche”, che la ricerca kitchen trova la propria essenza, al fine di ricostruire, rintracciare, ciò che la comunicazione artefatta, filtrata, selezionata dagli interessi dominanti, esecra a proprio piacimento ed edificare l’impalcatura di una nuova significazione poetica e linguistica, che rifletti (avalutativamente, come sempre per ciò che riguarda l’interpretazione artistica ed intellettuale) la contemporaneità.
Altrettanto correttamente, la Colasson sottolinea come la reciprocità fra “l’enunciato kitchen e quello distopico” (suo naturale corollario) “agiscono in uno spazio che è diventato mera superficie, mero nastro di Möbius”, dando vita ad un discorso poetico organizzato per “formazioni dis/locate e dis/articolate”: si tratta di un’opzione fondamentale per la sopravvivenza di un linguaggio poetico che mantenga ancora il suo senso e la sua dignità intellettuale, attraverso l’individuazione della sua (riprendo sempre le parole di Marie Laure) “connotazione di significato”.
La decostruzione di uno schema sintattico e semantico consolidato, determina ipso facto una morfologia distopica e dunque la Poetry kitchen è poesia distopica, l’unica via di fuga possibile dalle ridicole tendenze tardo pascoliane, che abbondano nella poesia (specie italiana) di oggi, riflettendo anche in poesia, la deriva populista nella quale purtroppo l’Europa è oggi immersa.
Versi come questi di Mimmo Pugliese:
“Nella sala d’attesa si lucidano rivoltelle
il domatore arriva in motoslitta
è già morto 11 volte
ma il corridoio non ha mai cambiato spartito”;
o questi altri di Francesco Paolo Intini:
“Un passero rovista nel riciclabile. Manca un led alla rabbia finale.
Il potere si concentra in un motore poi passa di mano in mano
Ma non saprà dirci, con tutta evidenza,
Cos’è quest’allegrezza nel fil di rame…”;
mettono indiscutibilmente la parola “fine” a qualsiasi tentativo di perpetuazione di modelli poetici che nel nome di una presunta “tradizione” pretendono di eternare un modello di poesia isterilita e dunque asservita.
Il progetto Poetry kitchen segna una frattura definitiva con questi cascami ormai non solo anacronistici, ma ingombranti, parassiti annidantesi nel nostro panorama culturale, e lo fa in maniera incisiva, non limitandosi solo alla dimensione sincronica, ma affondando anche in quella diacronica, come in questi versi di Giorgio Linguaglossa:
“Diomede ed Euriloco sperano che le vacanze di Troia non finiscano più.
Odisseo mette il caricatore nel kalashnikov di Agamennone il quale, beato lui, si prende la tintarella sulla spiaggia.
Odisseo, Menelao, Agamennone si spalmano l’abbronzante sul corpo sotto l’ombrellone”.
Screenshot
È evidente la necessità di procedere a mettere anche la storia sotto la lente d’ingrandimento, rileggendone criticamente i canoni linguistici, pena l’impossibilità di ricostruire adeguatamente le azioni delle onde sotterranee che hanno sempre attraversato la poesia occidentale: perché qualsiasi operazione di ricerca sulla lingua è un intervento antropologico, ed in quanto tale fa inevitabilmente i conti con le concrezioni della storia.
Siamo di fronte ad un’opzione vitale per recuperare quello che Giorgio Linguaglossa evidenzia come il fattore mancante nella costruzione poietica dominante oggi, il Fattore Fantasia – ammorbata proprio dal dipanarsi dei condizionamenti storici – senza il quale qualsiasi impalcatura di costruzione poetica viene inevitabilmente a decadere.
L’idea di “tradizione” è una delle chiavi interpretative delle articolazioni di controllo delle manifestazioni del pensiero, con la sua fissità sul Reale, che avvilisce la poiesi; come dimostrano gli studi di antropologia storica, il concetto di tradizione, è servito come strumento di forgiatura e controllo politici delle prassi sociali e culturali in varie epoche storiche ed a varie latitudini, nel nome di una presunta “purezza delle origini”, funzionale alla perpetuazione dell’ordine costituito nelle varie articolazioni che regolano le società.
Si tratta in realtà di un processo di manipolazione che va ad incidere su quella che è una dinamica fisiologica, che tutte le società, di ogni epoca storica hanno sempre avvertito, vale a dire quella di assicurarsi la coesione sociale e il senso di appartenenza, processo che parte storicamente dalla riattualizzazione degli antichi miti nella quotidianità, conferendo alla comunità un senso di rassicurazione collettiva.
Nel passaggio dalla dimensione antropologico-sociale a quella antropologico-culturale, tale attitudine innata nell’uomo, si riassume nella celebre formula coniata in filosofia da Nietzsche del “mito dell’eterno ritorno”, ripresa poi da uno degli artefici della moderna ricerca storico-religiosa, Mircea Eliade, con la quale lo studioso romeno riassume la rielaborazione nella dimensione del quotidiano dei modelli archetipi mitologici, il riproporsi ciclico dell’ordine cosmico, del ciclo della vita, della morte e della rinascita, che si reitera nell’espletamento del rito.
Nel passaggio dal mondo contadino a quello industriale ed al “modo di produzione capitalistico”, la tradizione ha finito – in forma ancor più accentuata che in passato – per diventare uno strumento di conservazione e legittimazione di istituzioni, status, gerarchie sociali o rapporti di autorità, grazie al potere di persuasione dell’”idea forza” della sua perpetuazione nel tempo, inculcando credenze, sistemi di valori, codici convenzionali e di comportamento ripetitivi, nei quali si afferma implicitamente la continuità col passato.
Le critiche a questa degenerazione del concetto di tradizione, sono alla base di una delle opere più importanti di antropologia storica del ‘900, dal titolo, per l’appunto L’invenzione della tradizione, di Eric Hobsbawm (uno dei maggiori storici contemporanei) e Terence Ranger.
I due autori partono dall’osservazione che: “tradizioni che ci appaiano, o si pretendono, antiche, hanno spesso un’origine piuttosto recente, e talvolta sono inventate di sana pianta”; “è caratteristico (di tali tradizioni: nda) il fatto che l’aspetto della continuità sia in larga misura fittizio” e “che assumano la forma di riferimenti a situazioni antiche”.
I due studiosi, dimostrano in realtà come si tratti di elaborazioni di risposte calate dall’alto, di fronte a fasi di rapido cambiamento sociale; in queste situazioni, evidentemente le forme di potere costituite intravedono il rischio di scricchiolii, per sventare i quali è fondamentale cercare di coinvolgere le comunità, fornendo loro l’impressione di individuare a sua volta delle soluzioni a tale stato di incertezza, moltiplicatesi esponenzialmente con l’affermazione dell’ “età del capitalismo”, almeno dalla fine del ‘700 e la rottura dei precedenti equilibri.
Non è un caso dunque, che quest’idea “ossessiva” del concetto di tradizione, si radichi soprattutto durante l’800: basti pensare ai vari tentativi di legittimazione dinastica, in contrapposizione alla nascita dei nuovi stati nazionali ed a loro volta ai vari miti creati ad arte per rafforzare le aspirazioni nazionaliste, che avranno come corollario, nel corso del ‘900, lo sviluppo del nazionalismo con tutte le nefandezze da esso prodotte nel corso del secolo.
E non è un caso, altresì, che nell’individuare la definizione di ogni nuova tradizione, si ricorra sempre alla costruzione immaginifica di presunte abitudini umane originarie, attraverso la dimostrazione della loro perpetuazione, in maniera immutata, nel tempo: si attua così, verso queste supposte consuetudini, il meccanismo che Ugo Fabietti definisce di “rimozione dalla storia” e che alimenta quello che già Marc Bloch aveva ribattezzato “idolo delle origini”, che ritroviamo ormai a tutti i livelli, dalla più bieche strumentalizzazioni politiche, fino alla creazione di sagre paesane, sfruttando “l’eterno selvaggio” che si annida nella società occidentale.
L’antropologia combatte queste concrezioni negative e le loro ricadute, mostrando come non esistano culture chiuse alla contaminazione nello spazio ed al contatto con la storia ed evidenziando come qualsiasi cultura sia soggetta a processi evolutivi, in ogni sua singola articolazione, radicati nelle dinamiche storiche.
La prassi di edificare tradizioni ad hoc, si estrinseca per forza di cose, anche attraverso il controllo delle singole manifestazioni del pensiero e della creatività, in modo da annientare le aspirazioni al cambiamento, che soprattutto nei momenti di crisi tendono ad affiorare, come reale via d’uscita dal panorama di difficoltà.
In questo quadro, inevitabilmente, la poesia, da sempre considerata la massima espressione della creazione umana e dotata storicamente di una particolare forza d’impatto sull’animo umano che probabilmente condivide solo con la musica – sua musa gemella – ha goduto sempre di “attenzioni particolari”, soprattutto in quelle realtà che possono basarsi su maggiori eredità legate a modelli classici (e ciò non riguarda evidentemente solo la nostra classicità) a perorazione della pretesa nobiltà di modelli archetipi esemplari cui attenersi; ed è così che in ambito italiano proliferino tuttora scritti elegiaci di sapore pascoliano o gozzaniano, assolutamente insignificanti al giorno d’oggi, ma che assolvono questa funzione consolatoria.
Cosa fare? Forse la soluzione è davvero quella che Giorgio Linguaglossa prospetta nel suo componimento qui presente: “mettere mine ad ogni endecasillabo” o scioglierli facendone dentifrici.
Un caro saluto a tutti.
(Vincenzo Petronelli, poeta componente della redazione de lombradelleparole.wordpress.com e della rivista cartacea Il Mangiaparole)
.
Vincenzo Petronelli è nato a Barletta l’8 novembre del 1970, laureato in lettere moderne con specializzazione storico-antropologica, risiede ad Erba in provincia di Como. Dopo un primo percorso post-laurea come ricercatore universitario nell’ambito storico-antropologico-geografico e redattore editoriale negli stessi comparti, oltreché in quello musicale, attualmente gestisce un’attività di consulenza aziendale nel campo della comunicazione, del marketing internazionale e dell’export. Agisce in vari settori culturali. Come autore sono impegnato scrive testi di poesia, di narrativa e di storytelling sportivo, musicale e cinematografico, nonché come autore di testi per programmi televisivi e spettacoli teatrali. Nel contempo, prosegue nell’impegno come ricercatore in qualità di cultore della materia sul versante storico-antropologico, occupandosi in particolare di tematiche inerenti i sistemi di rappresentazione collettiva, l’immaginario collettivo, la cultura popolare, la cultura di massa, la storia delle religioni. È attivo nell’ambito della ricerca storica e antropologica e come storyteller, nell’organizzazione di eventi e festival culturali in diversi settori (musica, letteratura, teatro, divulgazione) e come promoter musicale. È redattore per il blog letterario internazionale lombradelleparole.wordpress.com e collabora con le riviste “Il Mangiaparole” e “Mescalina” occupandosi di musica, poesia e del rapporto tra poesia e scienze sociali. Dal 2018 è presidente dell’associazione letteraria Ammin Acarya di Como. Ha iniziato a comporre poesie dalla seconda metà degli anni novanta. Alcuni suoi testi sono presenti nelle antologie IPOET edita nel 2017 e Il Segreto delle Fragole edita nel 2018, entrambe a cura dell’editore Lietocolle, nonché in Mai la Parola rimane sola edita nel 2017 dalla associazione “Ammin Acarya” di Como, nel blog letterario internazionale “L’Ombra delle Parole”. È uno degli autori presenti nelle Antologie Poetry kitchen 2022 e Poetry kitchen 2023, nonché nella Agenda 2023 Poesie kitchen edite e inedite 2023 e nel volume di Giorgio Linguaglossa, L’Elefante sta bene in salotto, Progetto Cultura, Roma, 2022. Sue poesie sono presenti nel volume La poesia nell’epoca della Intelligenza Artificiale a cura di Giorgio Linguaglossa, Progetto Cultura, 2025.
#AntonioSagredo #FrancescoPaoloIntini #giorgioLinguaglossa #IntelligenzaArtificiale #MarieLaureColasson #MimmoPugliese #poesiaDistopica #poesiaKitchen #VincenzoPetronelli