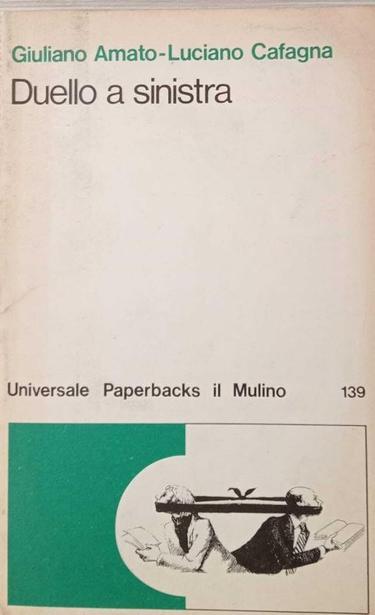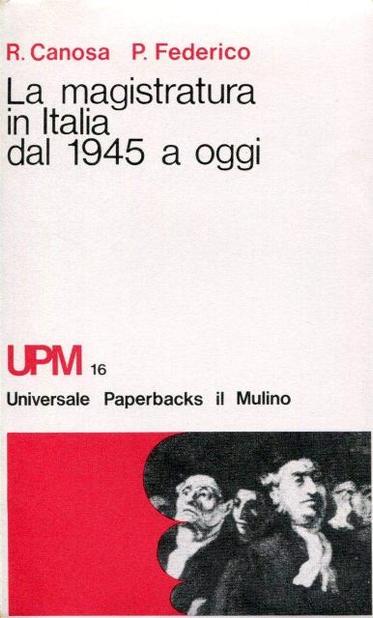Fermezza o trattative con le Brigate Rosse nel 1981
Ma non è certo solo il caso Gioia, o, più in generale, un diverso approccio verso il ruolo della commissione inquirente, a dividere il Psi dal Pci. Gli ultimi mesi del 1980 infatti fanno riaprire vecchie ferite che risalgono a oltre due anni prima, ai giorni del rapimento di Aldo Moro e che ancora non si sono rimarginate. Nel mese di ottobre Berlinguer si reca a deporre presso la commissione parlamentare sul caso Moro ed esprime opinioni critiche nei confronti della condotta del Psi, che aveva rotto il “fronte della fermezza” con il suo tentativo umanitario; l’Avanti definisce «sconcertante» la deposizione del segretario comunista <220. A novembre è il turno di Craxi di deporre in commissione ed il leader del Psi parla dei contatti attivati con gli esponenti di Autonomia e, pochi giorni dopo, rilascia un’intervista all’Europeo sull’argomento. Ma il momento di maggior tensione arriva alla fine del mese quando i quattro commissari del Psi, dopo una riunione con Craxi, abbandonano polemicamente la commissione. In un comunicato si spiega la condotta dei socialisti con non meglio precisate «strumentalizzazioni e violazioni di legge» nei lavori della commissione e con la divulgazione intenzionale di documenti e, soprattutto, la «tendenza a trasferire l’obiettivo dell’inchiesta, trasformando i lavori della commissione in un vero e proprio processo politico diretto contro una tesi, una condotta e una forma politica» <221. A generare le ire del Psi sembra essere stata soprattutto la richiesta da parte della procura di una copia delle deposizioni di Craxi, Landolfi, Signorile e Guiso; ire acuite quando sia la Dc che il Pci (che insieme dispongono della maggioranza dei voti) si dimostrano intenzionati ad accogliere la richiesta dei magistrati <222.
I giorni del rapimento di Aldo Moro ritornano prepotentemente alla memoria di tutti quando, nel mese di dicembre, si verifica una nuova emergenza che ripropone il dilemma tra “fermezza” e “trattativa”. Il giorno 12 del mese viene rapito il magistrato Giovanni D’Urso, presidente di sezione della Cassazione e distaccato presso il ministero di Grazia e giustizia con responsabilità sul trasferimento di detenuti. L’azione è subito rivendicata dalle Br, che chiedono per la liberazione che venga chiuso il carcere dell’Asinara in Sardegna. Questa volta, a differenza di quanto era avvenuto nel 1978, lo schieramento tra fautori della fermezza e disponibili alla “trattativa” si definisce molto rapidamente.
Nel governo i socialisti sostengono che la chiusura del carcere non costituisce una violazione di legge <223 e la si può concedere per salvare una vita umana, mentre la maggior parte dei democristiani ed i repubblicani affermano che, sebbene non rappresenti un’illegalità, la chiusura dell’Asinara significa piegarsi al ricatto, e con ciò dare legittimità ai terroristi. I magistrati in generale dimostrano grande solidarietà nei confronti di D’Urso e, coloro che manifestano un’opinione, sebbene nessuno ovviamente proponga di violare la legge, sono a favore di prendere «tutte le misure possibili» per salvare il giudice rapito <224. Il 25 dicembre Craxi rilascia una dichiarazione nella quale dice che il carcere sardo deve essere chiuso subito; si tratta di quello che Gaetano Scamarcio definisce il «blitz di Natale» <225. Due giorni dopo la vecchia prigione viene effettivamente sgombrata <226, ma il 28 vi è una rivolta nel carcere di Trani organizzata dai terroristi, che prendono in ostaggio diversi agenti di custodia. Questa volta la reazione del governo è di notevole determinazione: il giorno seguente le installazioni di Trani vengono prese d’assalto dalle unità speciali dei Carabinieri, che salvano gli agenti sequestrati e ristabiliscono l’ordine senza vittime.
La posizione del Pci è, dall’inizio, critica di ogni linea d’azione che implichi segni di arrendevolezza nei confronti dei terroristi; dopo la chiusura del carcere sardo, nel commentare le esternazioni di Pertini, il quale si dimostra decisamente contrario a trattative, un editoriale dell’Unità afferma che “…è impensabile che chi governa questo paese sia così sprovveduto […] da non capire quello che anche il più ingenuo degli italiani ha capito subito: che l’Asinara era un pretesto, che cedere su quel pretesto significava esporsi a pagare poi, e forse subito, prezzi e rischi sempre più alti, che nessuna proclamazione di “autonomia” nell’atto di cedimento avrebbe liberato il governo dal sospetto di aver accettato il terreno della contrattazione coi terroristi…” <227
Il 31 dicembre viene assassinato a Roma il generale dei carabinieri Enrico Galvaligi, responsabile della sicurezza esterna delle carceri e quattro giorni dopo le Br diramano un comunicato in cui dichiarano che D’Urso è stato condannato a morte, ma che lasceranno ai compagni detenuti una valutazione definitiva. In favore della trattativa ci sono, oltre al partito Radicale, i cui deputati vanno nelle carceri a parlare con i terroristi, i vertici dell’Anm e, si direbbe, la maggior parte dei magistrati. Tra di essi però non mancano segnali in senso contrario, ad esempio il discorso d’inaugurazione dell’anno giudiziario del Pg di Roma Pascalino, che invita alla fermezza <228; oppure, qualche giorno dopo, la decisione dei magistrati della sezione civile della pretura, che rigettano l’istanza del fratello del giudice rapito con la quale si chiede di ordinare ai giornali la pubblicazione dei documenti Br per uno «stato di necessità» <229; ma quando Curcio accenna alla liberazione del brigatista Gianfranco Faina, la Corte d’Appello di Firenze ne ordina subito la libertà provvisoria, attirandosi le critiche del Pci <230.
I socialisti, mentre Craxi si trova in Africa in vacanza, tengono una direzione e sembrano orientati ad evitare contatti con i brigatisti in carcere <231; poco dopo, l’8 gennaio, i terroristi detenuti a Trani affermano che daranno il loro benestare alla grazia se giornali e Tv divulgheranno documenti preparati dai brigatisti <232. Mentre diversi giornali proclamano quello che verrà definito il “black-out”, per non favorire il disegno dei terroristi, i magistrati si fanno ancora promotori di una linea meno intransigente e l’Anm promuove un incontro con la federazione della stampa per trattare l’argomento; il segretario dell’associazione, l’esponente di Magistratura democratica Senese, spiega che «la nostra posizione è che nel rispetto della legalità si debba fare tutto per salvare il collega […] La cosa peggiore che si possa fare in questo momento è trasformare il dibattito sulle decisioni da prendere in una discussione teologica sui massimi sistemi» <233.
Intanto Craxi rientra dalle vacanze e impone la linea al partito sconfessando la direzione precedente: il Psi appoggerà la campagna radicale per la pubblicazione. Ad essa aderiscono Lotta Continua, il Manifesto, L’Avanti e, in un secondo momento anche il Secolo XIX ed il Messaggero. Il 14 gennaio l’Avanti ospita una lettera dello stesso D’Urso che, dalla prigionia, chiede la pubblicazione dei documenti; il giorno seguente il magistrato viene liberato.
Dopo il rilascio il Presidente del consiglio si reca immediatamente alla Camera per fare una relazione sull’accaduto ma nel suo discorso, ben accolto da Psi, Psdi e radicali, si sforza di non accusare nessuno e non prendere parte nel dibattito tra fermezza e trattativa. I repubblicani appaiono critici <234, ma lo stesso può dirsi di importanti settori della Dc. Il Popolo cita una dichiarazione di Piccoli in cui spiega che «l’atteggiamento di fermezza è stato determinante per la tenuta contro il ricatto delle Br» e poi, illustrando la posizione dei partiti, spiega che “Il Psi ha esposto la propria posizione «in autonomia»” ricordando la polemica di Balzamo contro il Pci, accusato di «farneticare su un presunto partito del cedimento che non è mai esistito» <235. Ma qualche tempo dopo Piccoli apparirà molto più deciso; in occasione del congresso del suo partito, nei primi giorni di maggio 1982, circa la richiesta di
pubblicare documenti ricorderà che “…affermavo: siamo dinnanzi al più grave ed inaccettabile dei ricatti […] furono molti i giornali, anche di partito, che ritennero di accedere alle richieste delle Br […] Mi limito ad osservare che accedere a quella richiesta consentì alle Br di conseguire un obiettivo essenziale della loro strategia di intossicazione psicologica […] Ciò che avrebbe dovuto suggerire maggior cautela a esponenti socialisti nell’affrontare alcune delle questioni poste dalla liberazione di Ciro Cirillo…” <236
Nel caso D’Urso quindi si riprende il gioco delle parti già sperimentato quasi tre anni prima, ma con qualche differenza: a questo punto l’opinione pubblica sembra essersi assuefatta, in qualche misura, alla tesi circa le possibilità che lo Stato si impegni in qualche tipo di “trattativa” con i terroristi. Di conseguenza l’azione del Psi, accompagnata da quella dei radicali, è assai più decisa ed incisiva. L’altra differenza è che questa volta a sostenere il governo in Parlamento non ci sono più i comunisti, e quindi i democristiani si ritrovano soli ad osservare il movimentismo degli alleati socialisti e lo fanno non senza malumori e risentimento.
[NOTE]
220 “Sconcertante deposizione di Berlinguer su Moro”, Avanti del 11 ottobre 80
221 “Si sono dimessi i commissari Psi”, Avanti del 29 novembre 80
222 “Commissione Moro”, La Stampa del 28 novembre 80
223 Inoltre la dismissione dell’Asinara era già prevista e al momento del sequestro vi rimanevano solo 25 detenuti.
224 Vedi ad esempio “I magistrati contrari a scelte aprioristiche per Giovanni D Urso”, Avanti del 19 dicembre 80, o “I magistrati favorevoli a chiudere l’Asinara”, Avanti del 31 dicembre 1980, contenente un’intervista a Beria d’Argentine; vedi anche P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992 Cit. pag. 858
225 Dichiarazione citata in G. Fiori, Berlinguer Cit. Pag. 412
226 Secondo Fiori, in questa maniera, la chiusura è «data non alle Br per salvare una vita umana, ma a Craxi per salvare il governo», Ibid. Pag. 413
227 “Salvare un governo o la democrazia?”, Unità del 30 dicembre 80
228 “E’ escluso che lo stato possa cedere al terrorismo”, Popolo del 10 gennaio 81
229 “Giornali (con poche eccezioni) prevale la linea della fermezza”, Popolo del 13 gennaio 81
230 “Traspare una torbida trattativa con le BR”, Unità del 9 gennaio 81
231 G. Fiori, Berlinguer. Cit. Pag. 415
232 “33 giorni di prigionia”, La Stampa del 15 gennaio 1981.
233 “Iniziativa dei giudici verso stampa e partiti”, Avanti del 7 gennaio 81
234 “Le BR annunciano: liberiamo d’Urso”, Unità del 15 gennaio 81
235 “La maggioranza unita nella lotta al terrorismo”, Popolo del 15 gennaio 81
236 “Relazione di Piccoli al congresso”, Popolo del 3 maggio 82
Edoardo M. Fracanzani, Le origini del conflitto. I partiti politici, la magistratura e il principio di legalità nella prima Repubblica (1974-1983), Tesi di dottorato, Sapienza – Università di Roma, 2013
#1980 #1981 #1982 #Asinara #Berlinguer #BrigateRosse #carabinieri #carcere #Craxi #DC #EdoardoMFracanzani #EnricoGalvaligi #fermezza #generale #GiovanniDUrso #magistrato #PCI #Piccoli #Pri #PSI #radicali #rapimento #rilascio #trattativa #uccisione