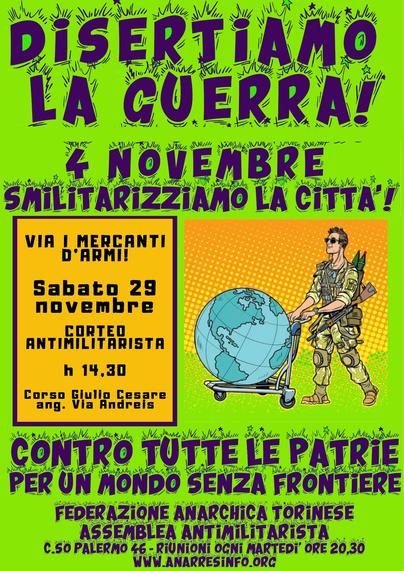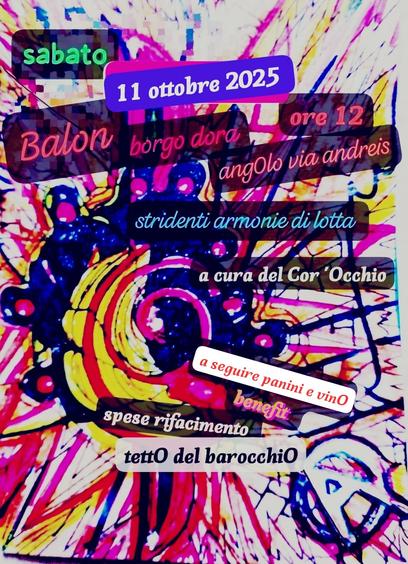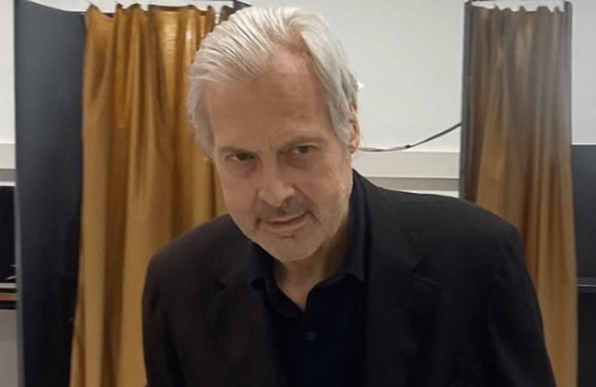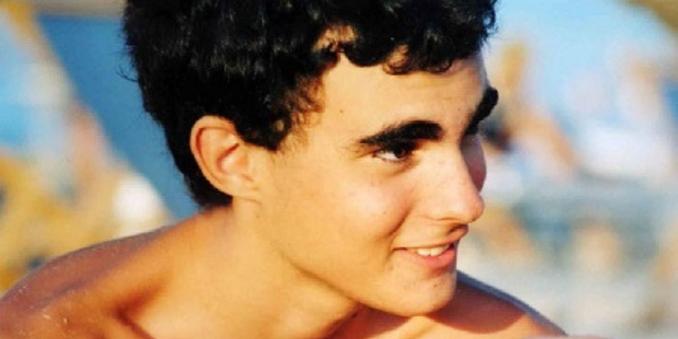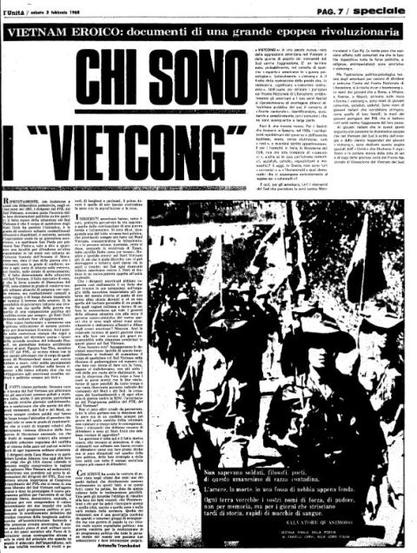Il PCI solidarizzava con i Vietcong, ripensando alla Resistenza in Italia
Contro l’idea del ‘tradimento’ degli ideali resistenziali e la concezione rivoluzionaria e classista della Resistenza portata avanti dai movimenti (e da alcune frange del partito, per la verità), il PCI oppose (e ripropose) una narrazione della Resistenza entro la cornice togliattiana della svolta di Salerno: una Resistenza interclassista e democratica, fortemente ancorata al concetto di ‘popolo’, legata semanticamente a quello di ‘nazione’, costruita discorsivamente sull’unione delle diverse componenti sociali e politiche del paese (quelle progressiste, ovviamente) <20. In occasione del ventennale della Resistenza, il 25 aprile del 1965, si invocava una «nuova unità operaia e democratica» , mentre l’anno seguente un giovane Achille Occhetto, dal 1963 segretario della federazione giovanile, parlava <21 della Resistenza nei termini di «vittoria del popolo» e «guerra di popolo». Contro la ‘Resistenza rossa’ si scagliò anche Paolo Spriano <22, opponendo la «verità storica» alla formula coniata dal movimento studentesco. E la verità (neanche a dirlo) risiedeva proprio nell’elemento popolare: «quando si vuole adoperare la formula ‘ci fu una sola Resistenza e fu Resistenza proletaria’, si dice cosa non vera: non vera nella realtà, poiché alla Resistenza parteciparono forze sociali e politiche diverse, non vera neppure nelle intenzioni comuniste, nella piattaforma che i comunisti le davano. […] La Resistenza che è culminata nell’insurrezione al Nord, fu un grande sommovimento di popolo, fu vittoriosa, anche perché il PCI, che tanta parte ebbe nel suscitarlo, intese profondamente questo carattere unitario, nel quale la classe operaia assunse una funzione di direzione, una funzione positiva, nazionale nuova». <23
Sarebbe certamente tedioso fare un elenco delle centinaia di articoli e le decine di pubblicazioni sulla Resistenza che uscirono intorno alla metà degli anni settanta, soprattutto per il trentennale, nel 1975, ma è opportuno semmai metterne in luce alcuni aspetti. Tra questi, vale la pena ricordare il ruolo importante assunto dal discorso sul Vietnam. Tra la metà degli anni sessanta e la metà del decennio successivo, infatti, ‘popolo’ e ‘Resistenza’ si trovarono con altissima frequenza sullo stesso asse discorsivo della narrazione delle lotte del popolo vietnamita contro l’imperialismo statunitense. «Ha diritto il popolo del Viet Nam del Sud a essere indipendente e libero e unito anche se questo turberà ‘l’equilibrio’ a sfavore dell’imperialismo americano nel sud-est asiatico?», chiedeva retoricamente Mario Alicata ai lettori de l’Unità nei giorni dell’evacuazione di Hanoi nel luglio del 1966. E ancora: «Ha diritto l’imperialismo americano a massacrare impunemente un popolo, a trascinare il mondo verso un conflitto generalizzato, per opporsi all’inarrestabile marcia dei popoli verso la loro indipendenza nazionale, sol perché in alcuni paesi tale bandiera è stretta nel pugno in primo luogo dai comunisti?». <24
In generale, sulla stampa di partito, la semantizzazione del discorso sul Vietnam si basava sul alcuni fondamentali assunti: l’eroismo del popolo vietnamita <25, la sua forza <26, il suo coraggio <27, la sua unità <28, la sua volontà <29, il suo sacrificio <30, la sua conseguente invincibilità <31; la rappresentazione biblica del re Davide contro il gigante Golia <32; la denuncia del genocidio di un popolo e di una ‘guerra sporca’ <34; il collegamento locale/globale, tra la lotta del popolo vietnamita e la lotta dei popoli del mondo (tra cui quello italiano) <35; il discorso sulla ‘guerra di popolo’ <36; la congiunzione spirituale tra la Resistenza del popolo italiano e la resistenza del popolo vietnamita. Ciò che collegava narrativamente i due popoli era proprio la vitalità degli ideali resistenziali. Nel ventennale della Resistenza italiana, nel 1965, Enrico Berlinguer spiegava, in un articolo su l’Unità dal titolo evocativo, “La Resistenza oggi”, che l’attualità della lotta partigiana era data da «ciò che [avveniva] nel mondo», e cioè «l’attacco barbaro che gli americani [stavano conducendo] contro il popolo del Viet Nam», e «ciò che [accadeva] in Italia» contemporaneamente, ossia «un’offensiva padronale e un’involuzione politica che [mettevano] in causa le conquiste fondamentali delle classi lavoratrici e le prospettive stesse di un’avanzata del nostro regime democratico». Perciò, concludeva, non era retorico l’appello che aveva fatto Longo «perché l’Italia della Resistenza [fosse] tutta, moralmente, politicamente, e in tutte le forme concrete che si renderanno necessarie, con la Resistenza del popolo del Viet Nam». <37
È presente in questo passo un nodo fondamentale del pensiero e della politica berlingueriana, poi anche base discorsiva del ‘compromesso storico’. In Italia, come in altre parti del mondo per certi aspetti affini, la possibilità di scivolamento nella crisi istituzionale, cioè di un’involuzione politica e di un rovesciamento delle conquiste democratiche a opera di forze reazionarie sempre presenti nel tessuto sociale, gettava un’ombra perenne sul paese.
È a partire dagli anni sessanta, dunque, che l’idea della crisi era entrata in sordina nel discorso del partito. Il XII congresso, svoltosi a Bologna tra l’8 e il 15 febbraio del 1969, rilevando l’approssimarsi della conclusione dell’esperimento del centrosinistra, aveva sottolineato la necessità di una «nuova maggioranza di forze laiche e cattoliche» che fosse «espressione politica dell’aggregazione di un nuovo ‘blocco politico’ di classi e ceti sociali». Ma se inizialmente la crisi era concettualizzata eminentemente come fenomeno <38 politico, in seguito, nel corso degli anni settanta e con i primi segnali di recessione, fu sempre più spesso presentata anche come questione economica. Il XIII congresso, infatti, tenutosi a Milano tra il 13 e il 17 marzo del 1972, registrava lo stato di crisi politico-economica in cui versava il paese, che si era generato grazie alle storture di una crescita non (o mal) regolamentata. Un episodio drammatico come la strage di piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969, aveva nel frattempo concorso a rafforzare gli scenari più bui <39. Per «isolare e per battere il fascismo», aveva scritto Alessandro Natta su Rinascita del luglio 1973, occorreva «una politica capace di risolvere in termini di libertà, giustizia, di progresso i problemi delle masse popolari» attraverso un «incremento di libertà e di giustizia» e l’«espansione della partecipazione e del controllo popolare». <40
[NOTE]
20 Bassi, “Una guerra semantica”. Si veda la figura n. 21, Carlo Levi, “25 aprile”, l’Unità, XL, 113 (25 aprile 1963), in appendice iconografica. Nell’illustrazione era scritto: «Se per la prima volta noi ci incontrammo insieme nella nuova coscienza di lotta e di rivolta, nel sangue, nell’azione sbocciata come un fiore, questo nuovo valore, questa è la Resistenza. Se questo primo seme comune, sotterrato negli anni, ha germogliato nuovo a un luglio di popolo per l’oggi, per il dopo, questa è la Resistenza».
21 “A venti anni dalla gloriosa insurrezione nazionale del 25 aprile. Trionfino gli ideali della Resistenza con una nuova unità operaia e democratica”, l’Unità, XLII, 113 (25 aprile 1965).
22 Achille Occhetto, “Andare avanti”, l’Unità, XLIII, 113 (25 aprile 1966).
23 Paolo Spriano, “Ancora sull’antifascismo tra i giovani. ‘Resistenza rossa’?”, l’Unità, XLVIII, 139 (23 maggio 1971).
24 Mario Alicata, “Il mondo a una svolta”, l’Unità, XLIII, 178 (24 luglio 1966).
25 Si parlava, per esempio, di «eroica lotta del popolo vietnamita, m.d.b., “Esaltante incontro di massa con le donne vietnamite”, l’Unità, XLIX, 299 (1° ottobre 1972), o di «eroici combattenti per la libertà», “Gli USA rispettino i patti!”, l’Unità, XLIX, 299 (1° novembre 1972).
26 “Un crimine immane che non ha piegato il Vietnam. Il martirio di un popolo”, l’Unità, L, 23 (24 gennaio 1973).
27 L’articolo “Hanoi: senza il sabotaggio di Nixon oggi nel Vietnam ci sarebbe la pace”, l’Unità, XLIX, 299 (1° novembre 1972) parlava per esempio di «lotta coraggiosa del popolo vietnamita».
28 Per esempio, in “Il Vietnam della tempesta”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968) si parlava di «un intero popolo» e di «lotta di tutto un popolo».
29 Per esempio: «il nemico non ha spezzato la volontà dell’eroico popolo del Vietnam», “‘Libertà e unità della Patria’ scopo della lotta del Vietnam”, l’Unità, L, 1 (2 gennaio 1973); «rafforzano il popolo vietnamita nella sua determinazione di combattere e vincere», “Continua la lotta e la vigilanza dei popoli mentre riprendono gli incontri di Parigi”, l’Unità, L, 1 (2 gennaio 1973).
30 Si parlava sovente di «popolo martoriato», “Gli USA rispettino i patti!”, l’Unità, XLIX, 299 (1° novembre 1972); di «sacrificio del popolo del Vietnam» e ancora di «popolo martoriato», “Manifestazioni e iniziative in tutta Italia”, l’Unità, XLIX, 350 (22 dicembre 1972).
31 Per esempio: «[Nixon] vuole sterminare tutto un popolo, ma il popolo vietnamita è come la terra, che sempre fa rinascere i suoi germogli e la vita», “Le donne protagoniste dell’esaltante manifestazione al Flaminio. Da ogni quartiere, da ogni comune per le loro sorelle del Vietnam”, l’Unità, XLIX, 299 (1° ottobre 1972).
32 Si vedano: «Oggi lo stesso popolo tiene testa, in condizioni di incredibile sproporzione di forza e con un incredibile coraggio, alla più grande potenza industriale del mondo, alla più avanzata tecnologia militare» “Il Vietnam della tempesta”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968); «La più potente e feroce macchina di guerra del mondo non è riuscita a soffocare la voce di libertà e indipendenza di un piccolo popolo», “I bombardamenti sono cessati. Ora si deve conquistare la pace”, l’Unità, XLV, 294 (2 novembre 1968).
33 Erano frequenti le espressioni come «barbaro genocidio», “Chi sono i Vietcong’”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968), o «barbaro massacro», “Manifestazioni e iniziative in tutta Italia”, l’Unità, XLIX, 350 (22 dicembre 1972).
34 Per esempio: “Alla notizia dell’accordo che pone fine alla sporca guerra nel Vietnam emozione ed entusiasmo in tutta Italia”, l’Unità, L, 24 (25 gennaio 1973).
35 Si diceva per esempio: «Una data storica che segna la vittoria dell’eroico popolo del Vietnam e di tutte le forze democratiche e di pace del mondo intero», “Accordo di pace. Continui la mobilitazione e la vigilanza”, l’Unità, L, 23 (24 gennaio 1973). Si veda anche “Una storica vittoria dell’eroico Vietnam e di tutti i popoli del mondo”, l’Unità, L, 24 (25 gennaio 1973).
36 «È la guerra di popolo che si sviluppa. Oggi colpisce il nemico più forte che mai, e non isolatamente, ma su tutto l’arco del fronte interno che risulta tutto in movimento, scompaginato da un’iniziativa militare e politica che rivela non solo uno slancio eroico inimmaginabile ma una linea politica robusta, nazionale, legata alle masse, profondamente connaturata con le esigenze di libertà e indipendenza tradizionali del popolo vietnamita», “No all’aggressione”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968). Sullo stesso numero, a pagina 8 e a caratteri cubitali: “Generazioni di vietnamiti in lotta per la libertà e l’indipendenza contro gli stranieri. Una guerra di popolo”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968).
37 Enrico Berlinguer, “La Resistenza oggi”, l’Unità, XLII, 113 (25 aprile 1965).
38 Alberto Cecchi (ed.), Storia del PCI attraverso i congressi (Roma: Newton Compton, 1977), pp. 321-322.
39 Dalla metà degli anni settanta, peraltro, il discorso sulla Resistenza (e sul popolo) risentirono del clima complicato dalla tensione sociale. Per esempio, nel giugno 1974 Arrigo Boldrini scriveva: «La risposta inequivocabile che la schiacciante maggioranza del popolo italiano ha dato al terrorismo degli squadristi neri contiene anche una indicazione che occorre cogliere in tutto il suo significato: gli ideali della Resistenza che furono a base del patto costituzionale e della nascita della Repubblica debbono permeare profondamente l’azione di ferma difesa dell’ordine democratico e debbono ispirare tutta la nostra vita sociale», “La Resistenza e le Forze armate”, l’Unità, LI, 150 (2 giugno 1974).
40 Alessandro Natta, “Per un modo nuovo di governare”, Rinascita, XXX, 27 (6 luglio, 1973)
Giulia Bassi, Parole che mobilitano. Il concetto di ‘popolo’ tra storia politica e semantica storica nel partito comunista italiano, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Trieste, Anno Accademico 2015-2016
#1963 #1965 #1968 #1972 #1973 #GiuliaBassi #guerra #Liberazione #lotta #partigiani #PCI #popolo #Resistenza #Vietcong #Vietnam