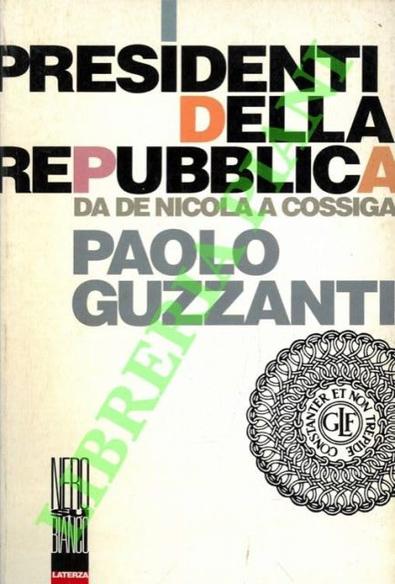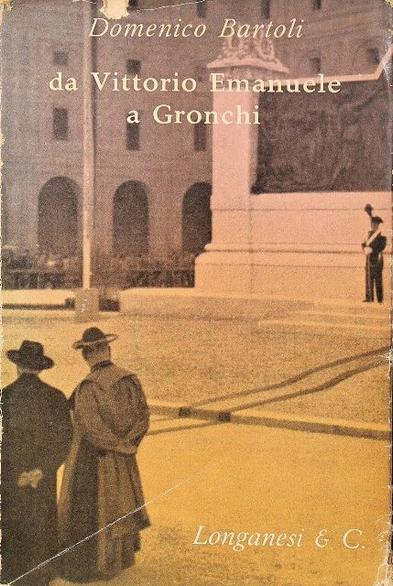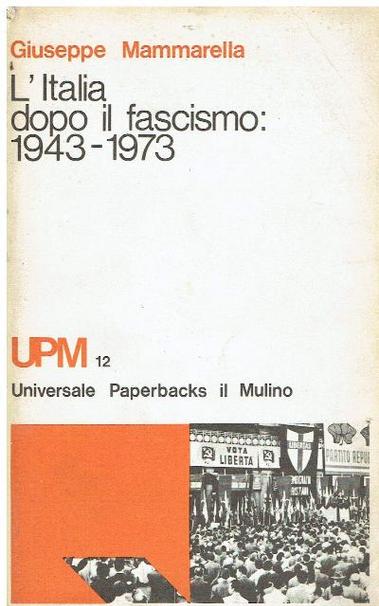Il governo Segni entra in crisi il 6 maggio 1957
Gronchi ha una propria interpretazione del potere conferito al Presidente della Repubblica dall’art. 92 della Costituzione. Egli ritiene, infatti, che compito del Capo dello Stato non sia soltanto quello di individuare una personalità e nominare un governo in grado di ottenere la fiducia in Parlamento, ma anche di scegliere un esecutivo idoneo a sopperire alle esigenze della nazione <76: un criterio di valutazione, quest’ultimo, palesemente discrezionale, soprattutto se si considera la ferma convinzione di Gronchi della necessità di un governo con la sinistra, in direzione del quale si concentreranno tutti i suoi sforzi durante il mandato.
Il governo ereditato da Gronchi è quello guidato da Scelba, suo acerrimo nemico <77. Tuttavia, il governo Scelba entra in crisi molto presto, a causa del ritiro del proprio appoggio da parte del Pri. Il 22 giugno 1955 il governo si dimette e il 6 luglio 1955 viene nominato – voluto dalla segreteria democristiana, ma non gradito a Gronchi – il primo ministero Segni (si ripropone la coalizione centrista di Dc, Psdi e Pli, senza i repubblicani, che però votano la fiducia), cui Gronchi riesce a imporre, per la carica di ministro degli Interni, il nome di Tambroni <78. L’iter di formazione del governo Segni non esula da particolarità: infatti, a costui viene affidato un pre-incarico finalizzato a prendere il tempo necessario a delineare un programma di governo che trovi la convergenza delle forze del quadripartito. La scelta del pre-incarico sembra aver consentito a Gronchi di indirizzare le politiche governative sulle idee del centro-sinistra <79. Il governo Segni inizia l’opera di statalizzazione dell’economia, presentando un disegno di legge per l’istituzione del Ministero delle Partecipazioni statali. Il disegno viene approvato, nella sua versione definitiva, con un emendamento, fortemente voluto, tra gli altri, da Enrico Mattei, che sottrae le aziende a prevalente partecipazione statale alla disciplina sindacale degli altri datori di lavoro <80. Inoltre, è sotto il governo Segni che, il 25 marzo 1957, viene firmato il Trattato di Roma che istituisce la Comunità economica europea.
Zoli I
Il governo Segni entra in crisi il 6 maggio 1957, a causa della perdita del sostegno dei socialdemocratici di Saragat. Sulle ragioni della decisione dei socialdemocratici, al di là dei motivi fondati su contrasti relativi a singole scelte politiche (in particolare, su un progetto di legge sui patti agrari), si interrogano le testate giornalistiche del tempo, trovando spiegazioni diverse: qualcuno attribuisce la decisione a un impulso derivante dal capo del partito laburista del Regno Unito, pronunciatosi sulla questione dell’unificazione socialista, altri, invece, e questa versione è particolarmente interessante ai nostri fini, rinvengono la ragione del distacco dalla coalizione governativa nei contrasti emersi in materia di politica estera tra il Quirinale e il ministro degli esteri Martino (Pli) <81. Effettuate le consultazioni di rito, Gronchi affida l’incarico a Adone Zoli, il quale forma un governo monocolore Dc che si presenta al Parlamento il 29 maggio. Nel conferimento della fiducia, si rivela determinante il voto favorevole del Msi, a causa dell’astensione del Psi. Rifiutando di presiedere un governo a cui il sostegno della destra è fondamentale, Zoli rassegna le proprie dimissioni <82. Al termine delle rinnovate consultazioni, Gronchi rilascia la seguente dichiarazione: “quello che importa non sono le formule che debbono essere considerate strumenti per raggiungere delle finalità, e le finalità [del procedimento di formazione di un governo], secondo me, sono due: rispondere alle esigenze del Paese e rispettare l’autorità e il prestigio del Parlamento”. Inoltre, continua, “secondo la costituzione italiana la scelta del Capo dello Stato costituisce di per se il governo nella pienezza dei suoi poteri” e il Parlamento interviene solo successivamente con il voto di fiducia, rendendo quindi la responsabilità del Capo dello Stato italiano diversa da quella del Presidente francese, che nomina un governo che può dirsi formato soltanto dopo l’investitura del Parlamento <83. Gronchi, sulla base di tali considerazioni, si riserva di decidere se accettare le dimissioni del primo ministro e assegna prima un mandato esplorativo al presidente del Senato, Merzagora (16 giugno), allo scopo di sondare la concreta possibilità di formare un governo che ottenga la fiducia delle camere, poi un incarico a Fanfani (18 giugno). E’ questa la prima volta che viene introdotto nella storia costituzionale italiana lo strumento del mandato esplorativo <84. Il fallimento dei tentativi Merzagora e Fanfani determina la decisione di Gronchi di rigettare le dimissioni di Zoli, il 22 giugno. La ripresentazione di Zoli alle camere, senza una nuova discussione su un voto di fiducia (peraltro già ottenuta), non rimane avulsa dalle critiche parlamentari. In particolare, don Sturzo, richiamandosi a un tema per la prima volta introdotto da Maranini nel 1949, ossia quello della “partitocrazia”, denuncia, da un lato, il ruolo sempre più crescente dei partiti nelle crisi di governo, che ostacolano un’assunzione di responsabilità in sede parlamentare, dall’altro lato, la scarsa trasparenza nella scelta e nomina dei ministri, non più facilmente riconducibile a una scelta del Presidente del Consiglio, da effettuarsi in vista del mantenimento dell’unità di indirizzo politico <85.
[NOTE]
76 Cfr. A. Baldassarre – C. Mezzanotte, op. cit., pp. 87-88.
77 Quando Scelba si reca, come da prassi, dal Presidente della Repubblica per presentare le dimissioni del governo “in segno di ossequio”, Gronchi fa emettere un comunicato in cui dichiara di “non accettare” le dimissioni (anziché di respingerle) (cfr. A. Baldassarre – C. Mezzanotte, op. cit., pp. 89-90). Per una ricostruzione del dialogo intercorso tra Scelba e Gronchi cfr. I. Montanelli – M. Cervi, op. cit., 1989, pp. 28-29; P. Guzzanti, Presidenti della Repubblica. Da De Nicola a Cossiga, Bari, Laterza, 1992 p. 93.
78 Cfr. ASPR, Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, Crisi di governo-Diari, busta 10; G. Mammarella – P. Cacace, op. cit., p. 65; F. Damato, op. cit., pp. 55-56; P. Guzzanti, op. cit., p. 82.
79 Sul significato di questo pre-incarico, che troverebbe un precedente – seppure diverso – in quello affidato da Einaudi a De Gasperi dopo la tornata elettorale del 1953, cfr. M. Nardini, I primi passi della presidenza Gronchi ed il governo Segni, in Aa. Vv., op. cit., 2013, pp. 5-8. In effetti, il pre-incarico affidato a De Gasperi non fu frutto di una scelta interamente riconducibile al Capo dello Stato, che avrebbe preferito affidare l’incarico direttamente al leader della Dc. Fu De Gasperi stesso a ritenere opportuno un sondaggio presso le forze politiche. A ben vedere, tra l’altro, a seguito di quel sondaggio De Gasperi si rivelò propenso a rifiutare un eventuale incarico, che alla fine accettò soltanto a causa delle insistenze del Presidente. Il suo governo non ottenne tuttavia la fiducia delle camere.
80 Cfr. I. Montanelli – M. Cervi, op. cit., 1989, pp. 30-32.
81 Cfr., per la prima versione, Enrico Mattei, Il governo Segni virtualmente in crisi per la decisione dei socialdemocratici di ritirarsi, in La Nazione del 6 maggio 1957; per la seconda versione, Le dimissioni di Segni probabilmente in giornata, in Paese sera del 7 maggio 1957. Le ragioni delle dimissioni non sembrano peraltro potersi rinvenire, come invece è sostenuto da qualcuno, in un tentativo di riavvicinamento tra Saragat e Nenni, a quanto risulta dalle dichiarazioni di quest’ultimo riportate nel secondo articolo menzionato: “la crisi di governo […] rimette in movimento una situazione stagnante. Ma nelle dichiarazioni di Saragat la difesa del centrismo, prospettata in polemica con noi, lascia assai incerti su quello che la socialdemocrazia vuol fare, se cioè passare decisamente alla opposizione […] o tentare la ricostruzione di un governo di centro, il cosiddetto “quadripartito di ferro”. In questo secondo caso verrebbe ribadita la politica che ha reso impossibile il riavvicinamento tra i due partiti, che dell’unità socialista è la premessa”. Entrambi gli articoli sono consultabili in ASPR, Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, Crisi di governo-Diari, busta 11. Per la tesi dell’avvenuto distacco a causa del riavvicinamento tra partito socialista e partito socialdemocratico, cfr. S. Tabacchi, La formazione del governo Zoli, in Aa. Vv., op. cit., 2013, p. 5. Montanelli, invece, pone l’accento sul ruolo che le divisioni interne alla Dc hanno nella crisi di governo (cfr. I. Montanelli – M. Cervi, op. cit., 1989, pp. 67-68).
82 Cfr. ASPR, Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, Crisi di governo-Diari, busta 11. Una ricostruzione è anche fornita in I. Montanelli – M. Cervi, op. cit., 1989, pp. 71-73.
83 Dichiarazione rilasciata in data 13 giugno 1957 al segretario della stampa parlamentare. La dichiarazione, riportata integralmente, si trova in ASPR, Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, Crisi di governo-Diari, busta 11 e in Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Servizio archivio storico, documentazione e biblioteca, Discorsi e messaggi del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Quaderni di documentazione, n. 11, Roma, 2009, p. 217.
84 Secondo parte della dottrina il “mandato esplorativo” si distinguerebbe dal pre-incarico in virtù della dichiarata non disponibilità del soggetto (in questo caso, Merzagora) di accettare un incarico (cfr. S. Tabacchi, op. cit., p. 10). Altri rinvengono un elemento distintivo nella circostanza che nel caso del pre-incarico il soggetto scelto viene effettivamente incaricato a formare il nuovo governo, mentre nel caso del mandato esplorativo no. La valutazione circa la riconducibilità del mandato all’una o l’altra categoria sarebbe quindi effettuabile soltanto ex post, dopo aver constatato a chi viene affidato l’incarico vero e proprio. La distinzione è peraltro meramente descrittiva (cfr. Fascicolo curato dalla Presidenza della Repubblica sulla crisi del II governo Moro, in ASPR, Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, Crisi di governo-Diari, busta 20, pp. 12-14). Si segnala, peraltro, che la prassi successiva sembrerebbe suggerire un ulteriore tipo di criterio distintivo: il mandato esplorativo infatti si connoterà nel corso della presidenza Saragat per la sua genericità (si tratta di sondare gli orientamenti delle forze politiche allo scopo di valutare quali strade siano praticabili per la formazione di un governo di cui non sono precisata né la formula politica né il programma).
85 Cfr. S. Tabacchi, op. cit., pp. 12-13. Una critica all’imposizione fatta da Gronchi, nel “suo stile presidenziale”, a Zoli affinchè quest’ultimo si ripresentasse alle camere si riscontra anche in P. Guzzanti, op. cit., p. 96. Una ricostruzione dell’intera vicenda si trova anche in G. Mammarella – P. Cacace, op. cit., pp. 65-66 e F. Damato, op. cit., pp. 63-64.
Elena Pattaro, I “governi del Presidente”, Tesi di dottorato, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2015
#1955 #1957 #DC #ElenaPattaro #esplorativo #GiovanniGronchi #governi #mandato #Pli #Presidente #Repubblica #repubblicani #Scelba #socialdemocratici #Zoli