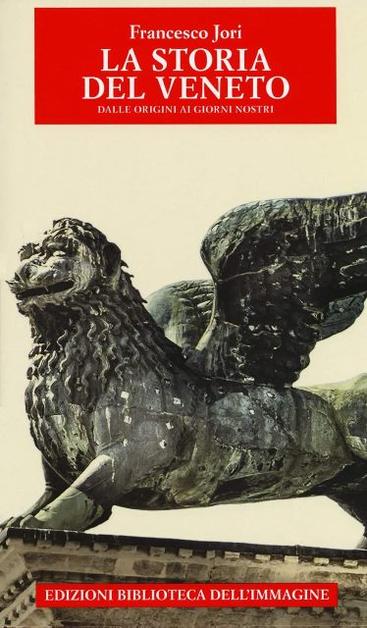L’egemonia cattolica nel Veneto determina rapporti di forza peculiari tra la DC e il PCI
Il Veneto è una regione popolata da piccole città, piccole imprese, agricoltura contadina ed è permeata dalla devozione al cattolicesimo. <35 La chiave di successo della sua economia, che decollò negli anni ’50 per poi svilupparsi negli anni ’60 e raggiungere l’apice negli anni ’70, fu il basso costo del lavoro derivante dall’impegno part time nell’industria e dal lavoro domestico, ossia la cosiddetta “economia sommersa”.
Alla base della politica del dopoguerra che predominò in Veneto, vi fu il controllo della riproduzione della forza lavoro, dal punto di vista materiale e ideologico, e soprattutto, quello delle condizioni di vita al di fuori della fabbrica. Questo fu possibile dalla frammentazione e dalla dispersione e, conseguentemente, dalla debolezza organizzativa della classe operaia; in secondo luogo, dalla presenza delle istituzioni sociali della Chiesa, una serie di organizzazioni collaterali come le cooperative, le casse di mutuo soccorso, l’Azione Cattolica, tutte facenti capo alla parrocchia, il cuore della vita religiosa.
Nel 1945 il governo italiano scelse un tipo di sviluppo guidato dalle forze del mercato, specialmente da quello internazionale, garantendo così l’incremento dei consumi interni moderni e la compressione dei salari. Questa modello portò un ritardo allo sviluppo della classe operaia nell’industria, lo spostamento di massa dalla campagna alla città e quindi un rapido sviluppo del terziario e dell’ingrossamento delle fila dei ceti medi, sia in ambito produttivo che in quello distributivo. Il cardine di questo percorso era la mobilità individuale e, quindi, lo sfruttamento proprio delle disuguaglianze nel sistema al fine di incentivare la partecipazione ai profitti che il sistema poteva elargire.
Considerando che l’Italia faceva parte del blocco occidentale e si trovava sotto la tutela statunitense che impose, nel 1947, l’esclusione dal governo del PCI (il partito che rappresentava la classe operaia), e dall’altro lato, l’apparato produttivo del paese era quello di un paese in via di sviluppo e si basava sull’eccesso di manodopera a basso costo, si capisce perché il governo del tempo abbia optato per questo tipo di modello di sviluppo.
La svolta che portò alla concretizzazione del miracolo economico del 1958-1962 fu l’attuazione di una politica basata su grandi profitti derivanti dai bassi salari che stimolavano gli investimenti necessari ad assicurare un buon livello di produttività, il quale a sua volta garantiva la crescita, la competitività dell’economia italiana a livello internazionale. Due elementi fondamentali di tale processo furono la produzione industriale di beni di largo consumo a bassa tecnologia e i salari bassi (conseguenza dell’elevato tasso di disoccupazione e della debolezza dei movimenti operai organizzati nel periodo della Guerra Fredda).
Questo scenario spiega, in un certo modo, il successo del settore della piccola impresa nel Veneto, la quale ha contribuito a mantenere costante il benessere della regione e della piccola industria, dove il lavoro a tempo parziale e il lavoro domestico avevano mantenuto relativamente basso costo della manodopera. Ricordiamo che, oltre al conflitto scatenato dagli uomini se ne aggiunse in quegli anni uno provocato dalla natura <36: nel 1951, una devastante alluvione sconvolse il Polesine, allagando oltre la metà della provincia, causando più di 100 vittime e 180mila sfollati (80 mila persone lascerà la regione per sempre). Mentre nel 1963, una frana dal monte Toc, ai confini tra le province di Pordenone e Belluno, piomba nel lago artificiale creato dalla diga del Vajont; provocando la morte di 1917 persone e distruggendo gli abitati del fondovalle. <37
Nonostante le guerre e disastri naturali, la capacità e la voglia di ripresa riescono farsi largo. L’avvio vero come detto è degli anni Sessanta, quando il reddito nazionale netto aumenta del 54 per cento, e il risparmio del 170. Nel 1961, le aziende con meno di 100 addetti assorbono il 72 per cento dell’occupazione. È un salto di qualità progressivo anche se rapido: l’operaio che lavorava giorno e notte in fabbrica, un po’ alla volta si mette in proprio diventando imprenditore di successo, scrivendo storie di tante crescite tipicamente venete. A renderlo evidente è il tasso di natalità delle imprese dell’epoca, di gran lunga superiore a quello della crescita occupazionale: segno evidente che molti ex dipendenti hanno deciso di fare il salto di qualità, avviando un’attività autonoma.
Negli anni Settanta, avviene uno storico sorpasso, gli addetti all’industria hanno superato il fatidico 50 per cento. Se negli anni Sessanta il reddito pro capite del Veneto è stato nettamente inferiore a quello della media nazionale, nel 1970 si verifica l’aggancio, merito di un’industrializzazione che marcia di pari passo con il potere d’acquisto. Inizia, come già annunciato, a decollare anche il settore terziario: una persona su tre, nella popolazione attiva, opera in questo settore. Per il resto dell’economia di questa regione, la seconda parte degli anni Settanta, è quella del grande balzo, con un trend che si dimostrerà costante fino ai primi anni Ottanta.
Pur la Chiesa subendo negli anni ’70, pressioni di una crescente e generale secolarizzazione, l’amministrazione locale con i suoi provvedimenti, in particolar modo nei settori dell’edilizia e della previdenza sociale, divenne un elemento fondamentale per il conseguimento e il mantenimento dell’egemonia di quel partito che per quasi l’intero dopoguerra governò questa regione, la DC.
Durante la dittatura, con la soppressione dei partiti e dei principali corpi intermedi, i poteri locali attuano ovunque in Italia forme di “resistenza” e di salvaguardia della propria collocazione nella struttura sociale. <38 Nel Veneto rurale operano in tale direzione fattori specifici, legati al ruolo della Chiesa che sembrano mitigare l’impatto del fascismo sulla società locale. Non si può non notare che, anche in Veneto l’effetto delle politiche di fascistizzazione della società e di formazione delle nuove generazioni concepite da Mussolini per l’intera nazione (con l’aiuto della stampa, radio, scuola e corpi intermedi creati ad hoc), hanno avuto un forte impatto. Infatti, sarebbe errato attribuire al Veneto del primo dopoguerra una cromatura “bianca”, talmente spessa da riemergere, intatta, dopo la caduta del fascismo. <39 Dalla fine dell’Ottocento, oltre all’associazionismo cattolico, compare e si diffonde anche quello di aspirazione socialista: nei primi anni del Novecento in molti centri urbani del Veneto si formano alleanze comprendenti socialisti, radicali e repubblicani che, dando vita alla stagione delle cosiddette giunte bloccarde, spezzano l’egemonia moderata in ambito amministrativo. <40 Una parte dell’associazionismo mutualistico Veneto urbano favorisce il radicamento del Partito socialista nel territorio, secondo un progetto basato sulle trasformazioni di capitale sociale sedimentato nelle associazioni mutualistiche in risorsa politica, mediante la presenza del partito e il controllo del municipio. Il Partito socialista in Veneto si rivela incapace di saldare le proprie lotte nelle campagne, a differenza delle realtà urbane. In Veneto, nel biennio 1919-20 la mobilitazione delle classi subalterne raggiunge livelli ineguagliati. <41 La contrapposizione fra organizzazioni “bianche” e “rosse” pregiudica la possibilità di successo dei contadini, ma rivela l’eterogeneità degli orientamenti politici nel Veneto d’inizio secolo. In Veneto, la devozione dei contadini ha reso possibile l’incapsulamento nella filigrana “bianca” delle plebi rurali mobilitate a seguito della crisi agraria di fine Ottocento. La storia elettorale del Veneto vede emergere il cromatismo “bianco” già agli inizi del Novecento. Ma l’incidenza della frattura città-campagna discrimina l’insediamento elettorale dei cattolici (rurale) da quello dei socialisti (urbano): il bianco, quindi, è dominante solo in campagna. Lungi dal costituire soltanto “una parentesi”, il fascismo modificherà in profondo il profilo politico lasciando sopravvivere, alla sua caduta, solo le realtà organizzative più forti, ossia solo il capitale sociale “bianco”. Per capire le caratteristiche di fondo della subcultura “bianca”, e al contempo, i motivi per i quali essa ha potuto attraversare il fascismo senza esserne sradicata: dobbiamo immaginare una sorta di sfera immutabile, dove vigevano “leggi” stabilite probabilmente attorno al Settecento, custodite dagli uomini di Chiesa che, creavano una specifica cultura paesana, dove contadini e artigiani erano gli attori principali.
L’apparente immutabilità che sembra caratterizzare il Veneto “bianco” nel passaggio dal fascismo alla democrazia è data dalla centralità della Chiesa nella cultura politica locale e dalla sua capacità di riproporsi quale schermo protettivo nei confronti di qualunque intervento esterno ritenuto pericoloso dalla società locale. Senza più il fascismo e con uno Stato molto diverso da quello scaturito dal Risorgimento nulla più osta alla trasformazione del suo capitale sociale anche in una risorsa politica. È prevalsa l’interpretazione secondo cui in Veneto l’egemonia politica cattolica fosse acquisita fin dal primo dopoguerra. Possiamo sostenere invece che tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento la Chiesa abbia consolidato l’egemonia <42 nei contesti rurali, mentre è solo durante il ventennio fascista, in virtù della libertà di iniziativa ottenuta mediante il compromesso che il regime, che essa riesce a divenire fulcro anche dell’ambiente urbano. Il passaggio attraverso il fascismo può essere identificato come una fase di mutamento del capitale sociale “bianco” sia per effetto dell’annichilimento delle forme organizzative altre e minori ad opera della dittatura, sia in seguito al riposizionamento operato dalla Chiesa nella struttura delle linee di frattura. Con la nascita della DC e la sua posizione dominante nel corso della seconda metà del Novecento la frattura Stato-Chiesa può essere gestita da posizioni molto favorevoli per il Vaticano, che può concentrare la propria forza politica nel proporsi come ancora di salvezza contro il comunismo. Lo spostamento nella struttura delle linee di frattura comporta un cambiamento nelle modalità di azione per la Chiesa: dall’intervento sociale, contro lo Stato liberale e in concorrenza con il movimento socialista fino all’avvento del regime, al controllo del perimetro ideologico in funzione anticomunista nel secondo dopoguerra.
L’egemonia cattolica nel Veneto determina rapporti di forza peculiari tra la DC e il PCI segnati dal preponderante dominio elettorale della prima sulla seconda, e accompagna la trasformazione di un’area preminentemente rurale in zona ad alta densità di sviluppo industriale di piccola impresa. In Veneto, le fratture connesse alla formazione dello Stato nazionale (centro periferia e Stato-Chiesa), unitamente al cleavage città-campagna, hanno preceduto e contenuto la frattura capitale-lavoro, mentre il conflitto di classe si è manifestato in presenza di forme di controllo sociale capaci di impedirne una riproduzione in termini partitici significativi. <43 Questo incapsulamento della struttura di cleavages prevalenti funziona anche nel dopoguerra, quando la frattura principale diventa quella che contrappone il mondo “bianco” al comunismo, il quale condivide con i “nemici” storici, il “centro” del sistema politico, lo Stato, ma anche “il centro urbano”, l’essere percepito quale minaccia esterna in grado di depauperare la filigrana della società locale. Per almeno i primi decenni del secondo dopoguerra, in Veneto, il criterio decisivo di alleanza sarà il legame tra localismo e la sua cultura prevalente, si vota allo stesso modo della comunità a cui si fa parte e dei suoi leader, senza tener conto della propria posizione economica.44 Il localismo non si traduce in posizioni eversive e pericolose, in quanto la dimensione simbolica e organizzativa della Chiesa danno linfa ad un capitale sociale che garantisce la coesione, l’articolazione, l’aggregazione e la soddisfazione delle domande individuali e collettive (responsiveness) e la presenza della DC assicura l’accesso al sistema politico e il rispetto delle sue regole. <45 Il fattore religioso incide sul piano morale e, su quello dell’integrazione, dell’identità sociale e su quello materiale dell’organizzazione, della rappresentanza e della mediazione con le istituzioni. <46 Negli anni Cinquanta su iniziativa delle ACLI venne svolta un’indagine presso i giovani della provincia di Vicenza, dove emerse la rilevanza di tali elementi, quale la premessa e fondamento degli orientamenti politici nella subcultura “bianca”. <47 Dalla ricerca risulta che nella società veneta di quel periodo, il rapporto con la politica era complesso, come i rapporti di forza elettorali. I partiti considerati come attori non troppo amati né apprezzati, cui vengono attribuiti ruoli ben precisi: la DC appare attenta alla tutela della Chiesa e della libertà, ma indifferente ai problemi di chi lavora; mentre il PCI e PSI figurano come nemici della religione, ma sostenitori dei lavoratori. La religione costituisce la filigrana “bianca” che collega gli orientamenti di fondo, è nel nome della religione che la DC viene legittimata come protagonista delle scelte. L’appartenenza alla Chiesa viene ritenuta una premessa sufficiente per attribuire il consenso ad un partito che pure non gode di molta fiducia. La Chiesa rafforza questo aspetto, grazie alla capacità di gestire e riprodurre un sistema di valori e significati incardinato alla vita quotidiana, all’interno della quale è la stessa istituzione ecclesiastica a fornire alla società una peculiare concezione del mondo. Inoltre, la Chiesa produce anche risorse organizzative e beni materiali (assistenza sociale, sostegno economico e organizzazione territoriale), garantendo così, forme di accountability sociale nei confronti dei governanti, attraverso la pressione svolta dal mondo cattolico locale sui parlamentari veneti e l’opera di mediazione svolta dalle parrocchie, compensa il deficit di responsiveness della DC. <48 Adesione o rifiuto della dimensione religiosa comporta anche appartenenza o antagonismo rispetto ai valori e alle logiche dello sviluppo locale. L’alternativa fra DC e PCI non sembra, per i veneti degli anni Cinquanta, porsi come alternativa fra Chiesa e lavoro, ma fra due modelli di sviluppo differenti.
Dimensione religiosa e sviluppo territoriale costituiscono aspetti complementari, dai quali la DC attinge risorse di consenso. L’identificazione con la DC si fonda sull’appartenenza alla comunità cattolica, che si riproduce attraverso il contesto locale e familiare egemonizzato dalla Chiesa. <49 Falliscono infatti, vari tentativi di far nascere un partito cattolico fortemente strutturato; la DC è un classico esempio di partito a “istituzionalizzazione debole” <50, nato per legittimazione esterna, che ebbe come sponsor la Chiesa, e sviluppatosi per diffusione territoriale. L’autentica “istituzione forte” quindi, è la Chiesa, con la propria rete associativa, che organizza la società locale e l’attività delle istituzioni amministrative. Si rafforza così, l’idea fortemente radicata nella cultura politica veneta sin dall’Ottocento, secondo cui chi opera a livello del governo locale non svolge un’attività locale, ma amministrativa, entro un contesto nel quale l’attività dell’ente locale si orienta in larga parte al contenimento di interventi e spese e all’appoggio esterno alla rete organizzativa cattolica, soprattutto alle sue strutture creditizie e assistenziali. <51
[NOTE]
35 MESSINA, PATRIZIA, et al. Cultura politica, istituzioni e matrici storiche. Padova University Press, 2014.
36 JORI, FRANCESCO. La storia del Veneto: dalle origini ai nostri giorni. Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2018
37 JORI, FRANCESCO. La storia del Veneto: dalle origini ai nostri giorni. Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2018
38 POMBENI P. (1995), La rappresentanza politica, in R. Romanelli (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Donzelli, Roma
39 ALMAGISTI, MARCO. Una democrazia possibile: politica e territorio nell’Italia contemporanea. Carocci, 2016
40 CAMURRI R. (a cura di) (2000), Il comune democratico. Riccardo Dalle Mole e l’esperienza delle giunte bloccarde nel Veneto giolittiano, Marsilio, Venezia
41 PIVA FA. (1977), Lotte contadine e origini del Fascismo. Padova-Venezia, 1919-22, Marsilio, Venezia.
42 RICCAMBONI G. (1992), L’identità esclusa. Comunisti in una subcultura bianca, Liviana, Padova.
43 DIAMANTI I., RICAMBONI G. (1992), La parabola del voto bianco. Elezioni e società in Veneto, 1946-1992, Neri Pozza, Vicenza
44 ROKKAN S. (1970), Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Process of Development, Universitetsforlaget, Oslo (trad. it. Cittadini, elezioni e partiti, il Mulino, Bologna 1982)
45 ALMAGISTI, MARCO. Una democrazia possibile: politica e territorio nell’Italia contemporanea. Carocci, 2016
46 DIAMANTI I., PACE E. (1987), Tra religione e organizzazione. Il caso delle ACLI: mondo cattolico, società e associazionismo nel Veneto, Liviana, Padova
47 DIAMANTI I. (1986), La filigrana bianca della continuità: senso comune, consenso politico, appartenenza religiosa nel Veneto degli anni ’50, in “Venetica, Rivista di Storia contemporanea”
48 ALMAGISTI, MARCO. Una democrazia possibile: politica e territorio nell’Italia contemporanea. Carocci, 2016
49 TRIGILIA C. (1986), Grandi partiti e piccole imprese. Comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa, il Mulino, Bologna
50 PANEBIANCO A. (1982), Modelli di partito: organizzazione e potere nei partiti politici, il Mulino, Bologna
51 TRIGILIA C. (1982) La trasformazione delle culture subculture politiche territoriali, in “Inchiesta”
Simone Spirch, Il Veneto lungo: dalla Serenissima ai giorni nostri, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2021-2022
#1945 #1962 #1963 #agricoltura #alluvione #anni #anticomunismo #cattolici #chiesa #Cinquanta #DC #dopoguerra #impresa #industria #localismo #operai #PCI #Piccola #Polesine #PSI #secondo #Settanta #SimoneSpirch #terziario #Vajont #Veneto