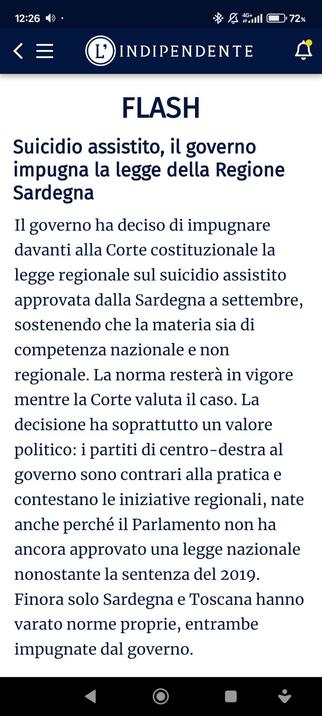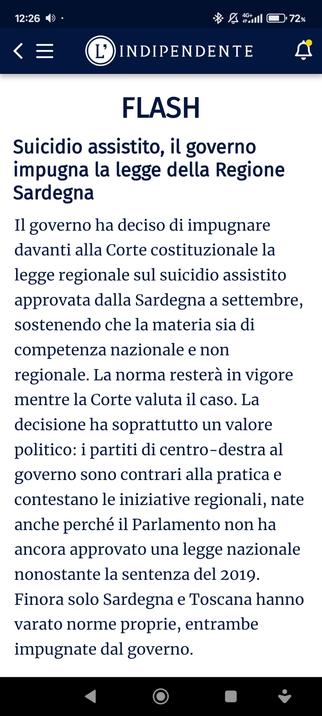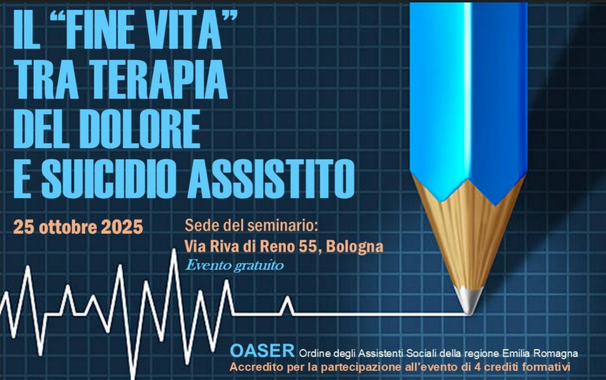Quando una scelta personale diventa un processo pubblico: le gemelle Kessler
Ci sono discussioni che sembrano fatte per restare civili, lucide, razionali. Poi arriva la realtà, e scopriamo che non siamo affatto pronti. La morte delle gemelle Kessler è uno di quei casi in cui il dibattito si è trasformato in una specie di confessionale collettivo: chi giudica, chi assolve, chi si straccia le vesti, chi tira in ballo Dio, chi la sacralità, chi la solitudine, chi persino la televisione degli anni Sessanta.
In mezzo a tutto questo rumore, spesso manca proprio la cosa più semplice: la voce delle dirette interessate, che non ci sono più e che, probabilmente, non avrebbero avuto alcun desiderio di essere trasformate in un ariete ideologico.
Prima di tutto, un preambolo
Non avrei mai voluto scrivere di questo argomento.
Mi sembrava — e sotto molti aspetti mi sembra ancora — stupido parlarne. Ci sono temi che dovrebbero rimanere privati, intimi, non trasformati in spettacolo da timeline: la morte, le scelte personali, il modo in cui qualcuno decide di concludere la propria storia.
Eppure, più leggevo commenti, analisi improvvisate, giudizi trancianti e teologie copia-incollate da meme, più mi saliva quella sensazione fastidiosa, quasi fisica, che mi prende quando la discussione pubblica deraglia completamente. Una specie di impulso irrefrenabile: ok, ora devo mettere ordine, almeno per me stesso. E per farlo, onestamente, non c’è altro modo se non scrivere.
Perché se un tema mi sembra assurdo, confuso, distorto, allora vale la pena di fermarsi un attimo e rifletterci meglio.
L’eco distorta di una scelta privata
Le Kessler erano due donne di quasi novant’anni. Hanno condiviso una vita intera e hanno scelto di condividerne anche la fine, attraverso una procedura legale, regolamentata, non improvvisata né impulsiva. Eppure, l’esito di questa scelta è stato trasformato in un’arena retorica in cui ognuno ha sentito il bisogno di dire «io avrei fatto», «io avrei evitato», «io so che cosa è giusto».
È curioso come la morte, più della vita, diventi improvvisamente proprietà pubblica: ognuno pensa di poterci entrare, giudicare, interpretare. È un meccanismo antichissimo, umano, perfino comprensibile. Ma resta profondamente viziato.
Dove si inceppa il ragionamento
Una delle cose più evidenti è quanto il dibattito sia infarcito di bias cognitivi e fallacie logiche. Non è una novità: quando entriamo in territori emotivamente densi, il nostro cervello smette di essere un laborioso archivista e diventa un commentatore notturno di talk show.
Ecco alcuni degli inciampi più evidenti:
La proiezione
«Io non lo farei mai, quindi chi lo fa non è lucido.»
Un classico intramontabile. Proiettiamo sui corpi e sulle scelte degli altri il nostro vissuto, come se la loro biografia fosse la nostra.
Il falso dilemma
«O accetti il suicidio assistito senza condizioni, o vuoi far soffrire la gente.»
No. Tra il bianco e il nero c’è un archivio infinito di grigi. Esistono regolamenti, procedure, verifiche, tutele. Il mondo non è bipolare (non sempre, almeno).
Ma anche:
«Se accetti il suicidio assistito sei un debole»
Altra variante del pensiero magico: trasformare una scelta complessa e ponderata in un difetto di carattere. Come se il coraggio si misurasse solo nell’ostinarsi a rimanere in vita a prescindere, e non anche nella lucidità di riconoscere quando una storia è arrivata alla sua ultima pagina.
Lo scivolone del pendio scivoloso**
«Se lo permetti a loro, domani elimineremo i fragili.»
Dove “domani” è sempre un tempo indefinito e “elimineremo” è un verbo scelto apposta per far venire i brividi. Nessun collegamento logico, solo suggestione.
L’appello al sacro
«La vita è un dono di Dio, non puoi disporne.»
Benissimo, se ci credi. Ma allora vale per te. In uno Stato laico, il tuo codice spirituale non può diventare automaticamente la norma per chi non lo condivide. Se permettiamo il suicidio assistito a qualcuno, non significa che debba suicidarti tu. Tu puoi continuare a seguire le regole del tuo dio.
Lo spaventapasseri
«Quindi secondo te i depressi devono morire?»
Interpretare la posizione dell’altro nel modo più radicale possibile è il modo migliore per non capirla mai. Tanto più che nessuno ha parlato di depressione in questo caso.
L’elefante nella stanza: Dio
Il tema religioso è quello che più di tutti riesce a spostare la conversazione fuori asse. Per chi crede, esistono dogmi, comandamenti, significati nella sofferenza. È legittimo. Ma è un linguaggio interno a quella comunità.
Il problema nasce quando da un insegnamento personale si pretende un obbligo universale. Quando il “Dio vuole” diventa “la legge deve”. Quando ciò che per te è sacro diventa un recinto per tutti.
Chi non crede vive questa dinamica come un paradosso: è come sentirsi dire che l’amico immaginario di qualcun altro ha deciso cosa possiamo fare con il nostro corpo. È inevitabile che il discorso sembri surreale.
Autodeterminazione non significa leggerezza
Un errore di fondo, molto diffuso, è immaginare che chi sceglie il suicidio assistito lo faccia per impulsività, fuga, improvvisazione. In realtà la procedura legale — soprattutto nei paesi dove è regolamentata — richiede colloqui, verifiche, documenti, conferme. È tutto tranne che un gesto “facile”.
E le Kessler, per come è stato ricostruito, avevano pianificato tutto: cremazione, urna, lasciti. Non erano due adolescenti spaventate. Erano due donne di quasi novant’anni che hanno vissuto abbastanza da sapere cosa volevano.
La verità è che abbiamo paura
Temiamo la morte. Temiamo ancora di più l’idea che qualcuno possa guardarla in faccia e dire «ho finito». Ci destabilizza. Va contro un istinto di sopravvivenza che ci accompagna da milioni di anni.
Paradossalmente, è proprio l’esistenza di un termine a dare spessore a ciò che facciamo prima. Sapere che non abbiamo tempo infinito potrebbe essere un pungolo a vivere meglio, non a vivere nel terrore: scegliere cosa conta, con chi vogliamo passare i giorni che restano, quali battaglie meritano le nostre energie. La morte, in questo senso, non è solo una minaccia ma anche un promemoria feroce: non possiamo continuare a rimandare all’infinito.
Quando due persone scelgono di concludere la propria storia in modo lucido, consapevole e condiviso, mettono in crisi un pezzo profondo della nostra psicologia. Forse per questo il dibattito diventa così violento: non stiamo giudicando loro, ma la minaccia simbolica che rappresentano.
La mia posizione
A questo punto è giusto chiarirla, senza giri di parole. Io credo che la vita sia un bene prezioso, ma non un bene proprietario di altri. Non credo che si possa entrare nei vissuti altrui con l’arroganza di sapere cosa sia meglio per loro. E non credo che un principio religioso — per quanto importante per chi lo vive — possa diventare un obbligo civile.
D’altra parte, riconoscere che la vita è finita non significa coltivare un culto della morte. Al contrario: vuol dire prendere sul serio il fatto che ogni biografia ha un inizio e una fine, e che tra questi due estremi c’è uno spazio limitato in cui possiamo — finché siamo lucidi — decidere che uso fare del nostro tempo. Per qualcuno questo comporta spremere ogni ultimo giorno, per altri arriva il momento in cui il semplice prolungamento biologico non coincide più con l’idea di vivere.
Per me, una scelta come quella delle Kessler appartiene esattamente a chi l’ha fatta. È un atto che riguarda due persone, la loro relazione, la loro intimità, il loro tempo. Noi possiamo discuterne per capire il contesto, migliorare le leggi, evitare abusi. Ma non per riscrivere la loro volontà.
La cosa più onesta che possiamo fare, forse, è accettare che non tutte le esistenze appartengono al coro. Alcune, fino alla fine, restano duetti.
#bigottismo #finevita #gemelleKessler #kessler #liberta #suicidioAssistitio