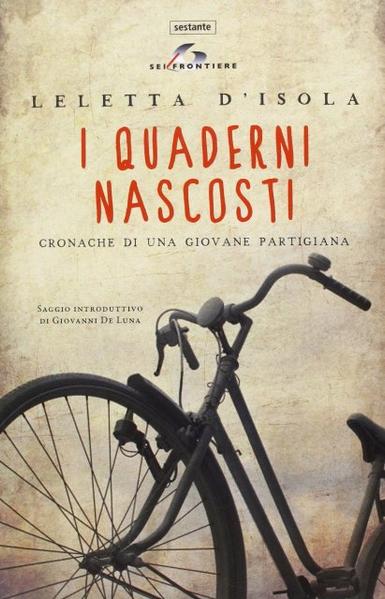I due fratelli scelgono lo schieramento partigiano di Barbato
Ormai è il 1939 e subito dopo la sua [di Felice Luigi Burdino] laurea scoppia la Seconda Guerra Mondiale: con un suo amico decide di arruolarsi nel comando di aviazione, viene immediatamente preso e da qui inizia la sua carriera militare. Dopo un anno a Perugia decide di tornare a Pinerolo. Per un anno insegna greco e latino al Liceo Classo G.F. Porporato, ma poi viene chiamato negli alpini, frequenta il corso e nel 1942 assume il titolo di “tenente”. Dopo aver affrontato varie vicissitudini, l’8 di settembre si trova vicino a Pergine, una cittadina in provincia di Trento, al comando del plotone di collegamento della città: lì come altrove, al momento del comunicato di Badoglio scoppia il caos e nessuno sa cosa sia meglio fare. Il giorno successivo, un’azione intrapresa dai tedeschi in città mette paura, ma gli uomini di Burdino attendono i suoi ordini e nessuno scappa prima di avere da lui il via libera. La sera del 9 settembre li lascia andare, scende in paese e il giorno successivo decide di rientrare a Pinerolo. A casa, due giorni dopo il suo arrivo, torna anche il fratello: insieme decidono di schierarsi dalla parte dei partigiani e, tra le diverse possibilità, scelgono lo schieramento di Barbato [Pompeo Colajanni]. I due fratelli vengono subito arruolati dal comandante, che è ben felice di aver acquisito due membri del loro calibro. Immediatamente i fratelli Burdino assumono il nome di battaglia di “Fratelli Balestrieri I e II” e così comincia la loro esperienza tra i partigiani.
“È stato Barbato, fin dal primo incontro che mi ha praticamente presentato questo nome di battaglia. Lui diceva “Ballistrieri, che doveva essere, io però non ho mai trovato questo dato, uno dei luogotenenti di Nicola Barbato che aveva diretto la rivolta dei fasci siciliani. Ora, Ballistrieri non mi piaceva: siccome c’era un famoso alpinista che io avevo visto una volta o due e si chiamava Balestrieri, allora io l’ho modificato e sono stato registrato come Franco Balestrieri. Senza contare poi che “Balestrieri” è anche quella spada con la balestra e quindi mi riportava a epoche precedenti. Io ho preso anche un nome nuovo, Franco: d’altra parte F. B. significava Felice Burdino, Franco Balestrieri. Nulla era lasciato al caso” <117.
Fin dai primi giorni si manifestano subito in modo evidente i motivi che spingono Barbato ad essere felice dell’arruolamento di Balestrieri, il quale si presenta come un uomo carismatico, intelligente, autorevole e dotato di un grande spirito di iniziativa. Proprio queste sue caratteristiche lo portano ad essere sia il protagonista delle principali azioni compiute dai partigiani in pianura <118 sia uno dei comandanti più rispettati e temuti di tutti i venti mesi di Resistenza. In poche parole, Balestrieri è un vero uomo d’azione, uno di quei comandanti che scendono in battaglia per primi e si ritirano per ultimi.
Bellissime sono le parole con cui lo ricorda Leletta: “Ci sono partigiani che fanno la guerra per forza, per non essere impacchettati dai tedeschi, altri che la fanno per un ideale, certi ancora combattono per dovere: Balestrieri è forse l’unico che fa la guerra con passione, per amore della giustizia” <119.
Proprio l’amore per la giustizia è l’elemento che lo stesso Balestrieri indica come una delle motivazioni principali che ha spinto gli uomini a schierarsi dalla parte dei partigiani: “In questi Venti Mesi queste creature han fatto cose strabilianti, senza mai chiedere niente. Ecco, l’han fatto non per una posizione politica: la maggior parte non sapeva neanche esattamente dov’era la Russia e chi fossero gli Alleati e dov’era il fronte in cui gli alleati combattevano in Italia. L’han fatto per un motivo esclusivamente umano o, se volete salire un po’ più su, diciamo morale. Questa è la moralità. Con una intuizione però importante, che è consistita nel capire chi erano gli uni (tedeschi, fascisti e brigate nere) e chi erano gli altri. E han scelto, non perché la nostra parte si pensava fosse poi vincitrice, ma perché pur qualche volta compiendo una qualche ingiustizia, eravamo un po’ più nella giustizia”. <120
Emblematico, in virtù di questo spirito, è sicuramente l’episodio che si verifica a Torino il 30 aprile 1945, quando ormai i partigiani si sono stabilizzati all’interno del palazzo dei sindacati fascisti da tre giorni. In quei giorni, uno dei loro camion diretto in Val Luserna però si era scontrato con la divisione di alpini tedeschi, a cui si era aggiunto in precedenza anche un gruppo di brigatisti neri. I partigiani perdono lo scontro a causa della notevole inferiorità numerica, ma poco dopo i brigatisti vengono catturati e il comando decide per la loro fucilazione. Con la durezza della sua voce Balestrieri riesce a placare la rivolta che intanto si verifica al palazzo, ma decide di non assistere all’esecuzione: egli è un combattente, non un boia <121. Con questa decisione termina la sua partecipazione alla Resistenza: il suo operato tra i partigiani viene ripagato con il titolo di cittadino onorario dei comuni di Bagnolo Piemonte e Barge, con una medaglia d’argento al valore militare e con il bellissimo ricordo che hanno di lui tutti gli altri partigiani.
Subito dopo la Guerra torna ad occuparsi delle sue due grandi passioni: l’alpinismo e l’insegnamento. Per quarant’anni, insegnando greco e latino, entra continuamente in contatto con le nuove generazioni e così ha la possibilità di educare i giovani all’importanza della memoria. L’aspetto che più colpisce della sua testimonianza è sicuramente la protezione che pone di fronte a quelli che sono i suoi ricordi: non sottolinea mai le sue gesta in maniera eccessiva, non enfatizza il dolore di alcuni momenti, non pone in risalto le morti degli uomini, ma racconta con rispetto, schiettezza e sincerità la sua Lotta di Liberazione. Ovviamente, quando decide di schierarsi con Barbato non è felice dei mesi che lo attendono, ma sceglie di partecipare alla Guerra senza esitazione, perché, in quel momento, quella è la decisione giusta da prendere. Per questo è possibile affermare con certezza che, qualora la vita gli avesse di nuovo offerto la possibilità di scegliere, egli avrebbe sicuramente deciso di combattere ancora in nome della giustizia.
[NOTE]
117 Stralcio della testimonianza rilasciata da Felice Luigi Burdino a Francesco Perrone il 4 novembre 2002. La trascrizione completa dell’intervento è riportata in appendice.
118 In questo caso si fa riferimento alle azioni compiute sul campo di aviazione di Murello, svoltesi tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre del 1943, e alla giornata del 20 dicembre 1943 a Cavour.
119 D’ISOLA, Quaderni nascosti. Cronache di una giovane partigiana, 2013, p. 110
120 Stralcio della testimonianza rilasciata da Felice Luigi Burdino a Francesco Perrone il 4 novembre 2002. La trascrizione completa dell’intervento è riportata in appendice.
121 BURDINO, Diario Partigiano, 2005.
Giulia Beltramo, Tra architettura e memoria. Il progetto di un museo diffuso per le terre della Resistenza in bassa valle Po e in valle Infernotto. Volume I, Tesi di laurea, Politecnico di Torino, Anno accademico 2017-2018
#1943 #1944 #1945 #BalestrieriI #Barbato #fascisti #FeliceLuigiBurdino #GiuliaBeltramo #guerra #LelettaDIsola #partigiani #Piemonte #PineroloTO_ #PompeoColajanni #Resistenza #tedeschi #Torino