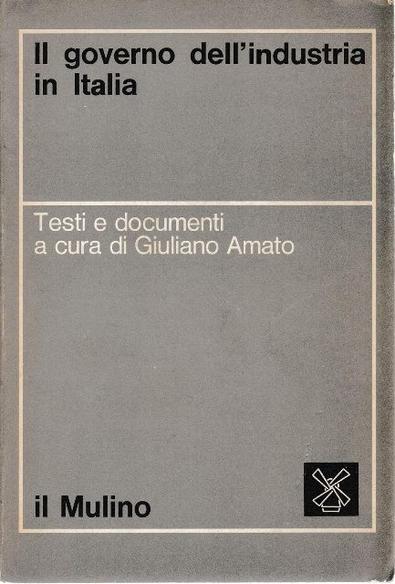Nel 1956 il numero di emigrati italiani verso paesi esteri superò le 200.000 unità
Con il passare del tempo però, si ripresentarono negli ambienti di governo preoccupazioni e perplessità riguardo il futuro del paese. Si cominciarono a ripresentare motivi di forte instabilità; nel giugno del 1953 fallì la legge elettorale maggioritaria, intesa a premiare i partiti della coalizione governativa, e contemporaneamente la figura di De Gasperi venne a mancare, colui che aveva fermamente guidato il paese sulla via della democrazia. Ci si domandò fino a quando avrebbero continuato ad agire alcuni fattori che resero possibile la ricostruzione economica e la restaurazione delle finanze pubbliche; se non si fosse ormai esaurita la spinta nei confronti dell’economia italiana dal recupero nell’epoca post conflitto degli impianti non totalmente utilizzati, dalla ripresa dell’agricoltura e dall’aiuto straordinario apportato dai prestiti americani. A contribuire fortemente a destare perplessità e preoccupazioni era il disavanzo della bilancia commerciale, che registrava saldi positivi solo nei confronti della Germania occidentale e la Svizzera.
Frutto di queste perplessità fu lo “Schema Vanoni”, una politica di piano condivisa alla fine del 1954. Lo Schema varato mirava al raggiungimento di alcuni fondamentali obiettivi nel corso di un decennio e sulla base di una crescita media annua del prodotto interno lordo del 5 per cento. <33 Gli obiettivi fondamentali si possono riassumere nella creazione di quattro milioni di nuovi posti di lavoro nei settori extragricoli, la riduzione del divario fra Nord e Sud del paese e il raggiungimento dell’equilibrio nella bilancia dei pagamenti. Per raggiungere tali obiettivi si rendeva necessario un ingente volume di capitali per favorire l’aumento degli investimenti industriali tramite la formazione di importanti risparmi. Il tutto era particolarmente improbabile, per questo si fece leva sull’espansione dell’edilizia e dei lavori pubblici come principale elemento propulsivo al fine di aumentare l’occupazione, nonché su un massiccio intervento dello Stato al fine di diversificare l’allocazione territoriale delle risorse e di imprimere un impulso agli investimenti. Nel contempo, si sottovalutarono l’incidenza che avrebbero avuto gli aumenti della produttività del lavoro, gli effetti del progresso tecnologico e organizzativo e le economie di scala che si sarebbero generate dallo sviluppo della domanda. <34 Lo Schema Vanoni promuoveva perciò un processo di graduale evoluzione.
In quegli anni l’economia italiana giovò del cambiamento politico-economico, a ragione di chi riteneva che il Paese sarebbe cresciuto vertiginosamente con l’intensificazione degli sforzi a favore di un maggiore accesso a una più vasta area di scambi. La transizione dall’economia autarchica ereditata dal periodo fascista, ad un tipo di economia liberista improntata agli scambi commerciali con gli altri paesi, si stava gradualmente compiendo.
I benefici della liberalizzazione degli scambi
Analizzando la decisione italiana di procedere verso un tipo di economia aperta da un punto di vista puramente teorico, i benefici ricercati, come dimostrato nel corso degli anni, erano sostanzialmente quattro: libero scambio ed efficienza, economie di scala nella produzione, incentivi all’innovazione e all’apprendimento, e intensificazione della concorrenza. Come visto, i dati di crescita dell’economia italiana furono più che positivi, questo perché analizzando il primo beneficio, lo spostamento da un equilibrio con dazi, ad uno con liberi scambi, elimina la perdita di efficienza e accresce il benessere nazionale. Vedendo nello specifico il secondo punto, l’Italia beneficiando di economie di scala, oltre ad aver aumentato la quantità di scambi internazionali, poté giovare di una maggiore disponibilità di varietà a prezzi inferiori. Aumentando gli scambi esteri, l’industria italiana, ebbe la possibilità di misurarsi con le migliori economie occidentali, e ciò ovviamente portò indubbi incentivi all’innovazione e all’apprendimento. Inoltre, gli imprenditori locali sono stimolati a ricercare nuovi mercati per le proprie esportazioni e a difendersi dalla concorrenza delle esportazioni. Questi vantaggi del libero scambio sono spesso chiamati “dinamici”, dato che un’intensificazione della concorrenza e del ritmo di innovazione può richiedere più tempo per manifestare i propri effetti, rispetto all’eliminazione delle distorsioni nella produzione e nel consumo. <35
Vedendo nello specifico il caso italiano, l’età degasperiana, nel 1953, finì insieme al modificarsi dello schema di politica economica temperata che l’aveva contraddistinta. Subentrò a De Gasperi come presidente del Consiglio, in seguito alla sconfitta elettorale della Democrazia cristiana nelle elezioni politiche del 7 giugno 1953, Giuseppe Pella. Pella, molto vicino a Luigi Einaudi, era un forte sostenitore del principio di libertà economica e, perciò, contrario all’interventismo statale, senza però disprezzare qualche lavoro pubblico dovuto ai sovrappiù prodotti dalle aziende. Da un certo punto di vista si potrebbe definire Pella un “monetarista”, in quanto assertore della teoria secondo cui con il controllo dell’offerta di moneta si sarebbe potuto controllare l’aumento del livello generale dei prezzi; i medesimi orientamenti erano condivisi anche da Donato Menichella, divenuto governatore della Banca d’Italia, in seguito all’elezione di Einaudi come presidente della Repubblica nel 1948.
Questo il quadro politico italiano. Italia che tra il 1955 e il 1963 conobbe una fase espansiva senza precedenti, anche se si ritiene che lo sviluppo industriale cominciò già dal 1953. Gli investimenti nell’industria manifatturiera fermi in media al 4,5 per cento del reddito nazionale lordo, salirono nel 1956 al 5,2 per cento, per poi culminare al 6,3 per cento tra il 1962 e il 1963. Il valore aggiunto passò invece nel decennio successivo al 1953, dal 20,6 per cento al 27,6 per cento. <36 Il prodotto dell’industria complessivamente si avvicinò a un indice pari al 47 per cento nella formazione del prodotto lordo privato, mentre il reddito nazionale crebbe con un saggio di aumento annuo del 5,8 per cento.
La bilancia dei pagamenti precedentemente in notevole disavanzo, registrò notevoli miglioramenti; da un disavanzo di 343 milioni di dollari nel 1952 si passò a un avanzo di 745 milioni nel 1959.
Attraverso questi miglioramenti ed altri fattori chiave nel processo di sviluppo industriale, l’Italia si inserì nel movimento ascendente dell’economia europea. Sul finire dell’anno 1962 il saggio di sviluppo italiano era inferiore solo a quello tedesco ed ampiamente superiore ai tassi di crescita di ogni altro paese dell’Europa occidentale. Già negli anni precedenti l’Italia aveva dato segnali di superbi miglioramenti, tant’è che nel decennio fra il 1950 e il 1961 il prodotto lordo nazionale registrò un aumento medio del 6,7 per cento. L’Italia grazie a questa miracolosa fase espansiva riuscì a ridurre sensibilmente il divario rispetto alle maggiori economie occidentali; ridusse il distacco di partenza che perdurava da fine Ottocento con l’Inghilterra, la Germania e la Francia, e superò economie migliori come quelle belga, olandese e svedese. Nel 1962, siderurgia, meccanica, chimica ed elettricità, i quattro settori principali del paese, rappresentavano in Italia il 16,1 per cento dell’offerta finale complessiva rispetto al 23,3 per cento in Germania e al 19,3 per cento in Francia.
Furono molti i fattori ad incidere in questa straordinaria espansione, avvenuta in una situazione di profitti crescenti, senza sensibili movimenti inflazionistici, e con un costante aumento del saldo dei conti con l’estero. Probabilmente il fattore dominante, al quale attribuire l’avvio del processo di rapido sviluppo degli anni Cinquanta, nonostante opinioni contrastanti, fu l’espansione veloce delle esportazioni, agevolata dalla progressiva liberalizzazione degli scambi. L’effetto trainante delle esportazioni, secondo alcuni invece, si vide in misura massiccia solo dopo il 1955. Tali esperti, come Silva, Targetti e Rey, osservarono che tale effetto appunto, agì solo su un numero limitato di settori produttivi (l’industria automobilistica, i prodotti petroliferi, alcuni prodotti tessili, le calzature, la gomma). Secondo questa teoria, a trascinare l’Italia sarebbe stata la spesa pubblica, soprattutto in agricoltura, nell’edilizia e nei trasporti. Negli anni più recenti, invece, esperti come Kregel e Grilli hanno osservato come l’andamento favorevole della bilancia dei pagamenti italiana, che rese possibile un veloce aumento degli investimenti senza creare un disavanzo nei conti con l’estero, fosse connesso all’andamento più che positivo delle ragioni di scambio internazionali, che dava all’economia italiana la possibilità di acquisire materie prime e semilavorati a costi reali decrescenti. Secondo Castronovo invece, il fattore trainante fu la presenza simultanea di condizioni favorevoli quali salari bassi, ampie possibilità di autofinanziamento, bassa conflittualità operaia e un forte arretramento tecnologico, che consentì rapidi aumenti di produttività. Rimanendo su questa teoria, è facile notare come l’industria italiana fece leva su una rilevante ed elastica offerta di braccia per contenere, o calmierare di volta in volta, la domanda salariale e per tenere comunque sotto controllo le vertenze sindacali. <37 Non mancarono, ovviamente, in quegli anni alcuni miglioramenti nell’assetto delle retribuzioni; ma in termini reali gli indici dei salari rimasero pressoché stazionari fra il 1950 e il 1954 e fra il 1956 e il 1961, e a livelli in ogni caso inferiori agli aumenti di produttività. <38 Secondo i calcoli della Banca d’Italia, a un incremento dei salari pari fra il 1953 e il 1961 al 46,9 per cento corrispose una crescita media della produttività dell’84 per cento. Stando alle stime dell’economista americano Stern, l’incremento delle esportazioni italiane fra il 1955 e il 1963 fu dovuto, per quasi il 60 per cento, alla maggiore competitività resa possibile soprattutto dallo scarto fra aumento della produttività e aumento dei costi di lavoro. <39
Nonostante idee e teorie differenti il tema delle esportazioni rimane centrale. La struttura della produzione italiana si ritrovò forzata a seguire l’orientamento che le imprimeva la domanda proveniente dai paesi europei in fase di avanzata industrializzazione. La domanda proveniente dai paesi con un’elevata industrializzazione era un tipo di domanda caratterizzata da beni di consumo di massa e da beni di lusso. Questo tipo di domanda, propria di società caratterizzate da livelli di reddito elevati, forzò l’Italia a fare largo spazio alla produzione di beni di consumo di massa e beni di lusso.
Contemporaneamente mentre l’industria italiana entrò a far parte di quel sistema di economie caratterizzate dalla produzione di massa di beni di consumo durevoli, le altre economie europee e i loro sistemi industriali passarono a produzioni ancora più avanzate. La modernizzazione servì sostanzialmente a mantenere inalterato il distacco dalle altre economie avanzate; nel frattempo nel quadro dell’industria mondiale, le produzioni italiane continuarono a ruotare attorno ai settori con una tecnologia relativamente semplice.
L’apertura degli scambi con l’estero connessa alla necessità di sviluppare una corrente di esportazioni orientata verso i mercati dei paesi industrializzati, diede luogo alla formazione di una struttura produttiva suddivisa in due settori ben distinti; si trattava di due settori caratterizzati ognuno da tecnologie proprie, il primo settore era rappresentato dalle industrie esportatrice, mentre il secondo da attività produttive orientate prevalentemente verso il mercato interno.
Il reddito nazionale subì una vertiginosa crescita, come detto; l’espansione degli investimenti ne fu la componente più dinamica, crescendo a tassi elevati in tutti i settori. <40 Fra il 1951 e il 1962 il tasso di aumento degli investimenti globali a prezzi correnti sfiorò il 10 per cento annuo. La distribuzione dei redditi cambiò a favore dei redditi d’impresa rispetto a quelli da lavoro, con la conseguenza che l’incremento degli investimenti non diede luogo a un uguale aumento della domanda globale. Perciò la propensione media ai consumi da parte della società si ridusse, essendo i percettori di redditi da lavoro i più inclini al consumo, a differenza dei percettori di redditi d’impresa. La diretta conseguenza di tale situazione fu la contrazione dei consumi collettivi, avendo meno frazioni di reddito coloro che erano portati a consumare di più rispetto a coloro che erano portati a consumare meno. In sostanza la pressione della domanda globale diventò minore di quella che l’aumento degli investimenti avrebbe potuto sostenere. Il risultato fu che si evitò il pericolo d’inflazione per eccesso di domanda e che il sistema mantenne un’ottima stabilità monetaria. La lira, oltre a non svalutarsi rispetto alle merci più di quanto non si svalutassero le altre monete, si deprezzò meno, tanto che nel 1958 le fu attribuito l’”Oscar” delle valute, risultando la moneta più stabile fra i paesi occidentali. Invero, i prezzi al consumo crescevano mediamente del 3-4 per cento, fenomeno comune anche ad altri paesi, ma i prezzi all’ingrosso tendevano a rimanere su valori stazionari, salvo oscillazioni ampiamente compensate. Tale stazionarietà dei prezzi contribuì positivamente, favorendo le esportazioni italiane. Contemporaneamente la competitività fece crescere la produzione nei comparti dinamici, mentre in quelli non dinamici, in quanto non orientati all’esportazione ma al mercato interno, la produttività subì un andamento inversamente proporzionale rispetto ai salari.
La necessità di aumentare la produzione e l’efficienza nei comparti esportatori portò al formarsi di numerosi nuovi posti di lavoro e al polarizzarsi della crescita industriale soprattutto in tre regioni: Lombardia, Piemonte e Liguria. Questa concentrazione diede vita a un notevole flusso migratorio dalle regioni del Mezzogiorno e del centro-nord meno sviluppate (il Friuli ad esempio), verso quel polo conosciuto come “triangolo industriale”. La forza lavoro non assorbita a livello nazionale, si spostò verso l’estero; il fenomeno della migrazione esterna non riguardò più le Americhe come ad inizio secolo, bensì gli altri paesi europei. Nel 1956 il numero di emigrati verso paesi esteri superò le 200.000 unità.
Complessivamente quasi due milioni di persone abbandonarono il sud-Italia, pari al 12 per cento, per spostarsi verso il nord del paese o verso altri stati. Non tutti gli emigrati meridionali trovarono impiego presso le industrie, infatti una parte considerevole di essi fu assorbita dal settore terziario come i servizi, la distribuzione commerciale o il pubblico impiego.
Il progresso che l’economia italiana compì tra fine anni Cinquanta e inizio anni Sessanta, fu di tale portata che la crescita del prodotto interno lordo, la produttività totale dei fattori e il prodotto per addetto risultarono i più alti e stabili nella storia del Paese. Nel 1963 gli investimenti fissi lordi raggiunsero in media il 25 per cento del reddito nazionale lordo, mentre il tasso di crescita del Pil superò il 7 per cento. L’Italia fu così paragonata per impatto alla Germania in Europa al Giappone nel mondo. Di pari passo il commercio internazionale subì una brusca impennata, registrando le esportazioni, tra il 1958 e il 1962, un tasso annuo di crescita prossimo al 16 per cento.
Non meno importante fu il cambiamento nella struttura economica nazionale; l’agricoltura cessò di essere il settore dominante e nonostante nel 1950 impiegasse ancora il 40 per cento della forza lavoro e fornisse il 25 per cento dell’intero valore aggiunto, nel 1963 fu superato dal settore industriale e da quello dei servizi.
Tutto ciò influì sulla dilatazione dei consumi e sul progressivo affermarsi di un nuovo stile di vita; un ibrido a metà tra la nuova cultura americana e la cultura italiana. Le città assunsero una nuova fisionomia, in particolare le grandi “capitali” del Nord industriale, con la nascita di interi quartieri popolari, ma anche con la costruzione dei primi grattacieli. La stagione espansiva volgeva così al termine portando con sé cambiamenti strutturali profondi.
[NOTE]
33 Si vedano V. Valli, L’economia e la politica economica italiana (1945-1975), Etas libri, Milano, 1977, pp. 109-110; B. Bottiglieri, La politica economica dell’Italia centrista (1948-1958), Ediz. Comunità, Milano, 1984, pp. 254-255.
34 Si veda al riguardo N. Andreatta, Fattori strategici dello sviluppo tecnico dell’industria italiana, in N. Andreatta et al., Il progresso tecnologico e la società italiana. Effetti economici del progresso tecnologico sull’economia italiana, Giuffrè, Milano, 1962. Invece sui vantaggi assicurati dall’ammodernamento degli impianti, si veda anche S. Leonardi, Schema di interpretazione dello sviluppo italiano in questo dopoguerra, in Critica marxista, luglio-ottobre 1968.
35 Per approfondire le ragioni a favore del libero scambio, e quelle a favore di un tipo di economia chiusa, consultare P. Krugman, M. Obstfeld, a cura di R. Helg, Pearson, 2007.
36 Si veda al riguardo A. Campolongo, Dinamica dell’investimento in Italia 1951-1967, in Moneta e credito, secondo trimestre 1968.
37 Si vedano al riguardo A. Triola, Contributo allo studio dei conflitti di lavoro in Italia, in Economia e lavoro, 1971; A. Cova, Movimento economico, occupazione, retribuzioni in Italia dal 1943 al 1955, in A. Cova et al., Il sindacato nuovo. Politica e organizzazione del movimento sindacale in Italia negli anni 1943-1945, Franco Angeli, Milano, 1981
38 Confrontare con A. Vannutelli, Occupazione e salari dal 1861 al 1961, in A. Fanfani, L’economia italiana dal 1861 al 1961, Milano, Giuffrè, 1961.
39 Si veda R. M. Stern, Composizione merceologica, distribuzione geografica e competitività nel commercio estero italiano nel periodo 1955-1963, in Moneta e credito, 1965.
40 Al riguardo non va trascurato il ruolo del credito a medio e lungo termine praticato da alcune banche specializzate, come la Banca di credito finanziario (Mediobanca), fondata nel 1946 dalle tre banche d’interesse nazionale ( Commerciale, Credito italiano, Banco di Roma), per l’esercizio appunto del credito a medio termine, poi esteso al lungo termine, da effettuarsi per il tramite dei loro sportelli; la Banca centrale di credito popolare (Centrobanca), istituita, essa pure nel 1946, dalle banche popolari per il finanziamento a medio e a lungo termine di imprese commerciali e industriali; l’Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), sorto nel 1952 con capitali forniti in prevalenza dallo Stato e con il compito di finanziare i Mediocrediti regionali.
Emanuele Zema, Come l’economia italiana si apre al mondo dopo la ricostruzione, Tesi di Laurea, Università Luiss “Guido Carli”, Anno Accademico 2017-2018
#1951 #1953 #1954 #1956 #1962 #dopoguerra #economia #EmanueleZema #emigrati #emigrazione #EzioVanoni #GiuseppePella #governi #industria #Italia #liberalizzazione #ministro #scambi #secondo